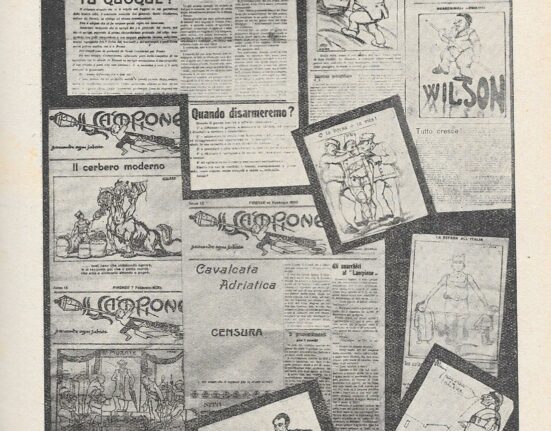“L’Inghilterra ama il tradimento…”.
Ecco una frase dell’Ammiraglio Giuseppe Sparzani che utilmente riscrivo: «L’Inghilterra ama il tradimento, ma disprezza i traditori».
Il motivo dell’utilità è semplice: mi offre il “destro” per trascrivere una serie di passi vergati da un personaggio discusso e, se si vuole, discutibile. Sono passi di testo che lasciano intendere un messaggio chiaro, ma evidentemente non per tutti, soprattutto ai giorni nostri. Un messaggio che ogni Italiano degno di essere considerato tale avrebbe preferito non leggere mai, quale ne sia o ne sia stata la fede politica, religiosa, l’inclinazione filosofica o altro ancora.
I passi che trascrivo sono del toscano Kurt Erich Suckert, alias Curzio Malaparte (1898-1957). Chissà perché i personaggi non certo specchiatissimi si cambiano sempre nome e cognome.
Un po’ anarchico, un po’ simpatizzante del Partito Repubblicano Italiano, interventista, arruolato dapprima come volontario nella Legione Garibaldina, poi passato al Regio Esercito, Curzio Malaparte pare (e sottolineo “pare”) che partecipi alla “Marcia su Roma”, aderisce al Fascismo e nel 1928 è già abbastanza avanti nel suo percorso iniziatico in Massoneria; nel 1933 viene espulso dal P.N.F. e nel 1940 è ufficiale dell’esercito regio “sabaudo”.
Dopo parecchi guai occorsigli per aver parlato senza peli sulla lingua su come vadano le cose per i soldati italiani al fronte, passa al nemico.
Dignità sotto i tacchi.
Intanto che passeggia per una Napoli occupata da un “misto griglia” di alleati tra di loro, giunge in un ex convento adibito a caserma angloamericana. Gli sono presentati degli uomini: una schiera di ex soldati del Regio Esercito Italiano che passa in rassegna per poi tenere loro un discorso. Ma prima di ciò fa dire a sé stesso: «Le uniformi del Corpo Italiano della Liberazione erano vecchie uniformi inglesi di color kaki, cedute dal Comando Britannico al Maresciallo Badoglio, e ritinte, forse per tentar di nascondere le macchie di sangue e i fori dei proiettili, di un verde denso, color di lucertola. Erano, infatti, uniformi tolte ai soldati britannici caduti a El Alamein e a Tobruk. Nella mia giubba erano visibili i fori di tre proiettili di mitragliatrice. La mia maglia, la mia camicia, le mie mutande, erano macchiate di sangue. Anche le mie scarpe erano state tolte al cadavere di un soldato inglese» (Curzio Malaparte, La pelle, ristampa, Adelphi Edizioni, Milano 2010, p. 14).
Poi lo Suckert-Malaparte osserva gli esseri umani che ha innanzi: «I soldati (erano quasi tutti molto giovani, si erano battuti bene contro gli Alleati in Africa e in Sicilia, e per questa ragione gli Alleati li avevano scelti per formare il primo nucleo del Corpo Italiano della Liberazione) stavano allineati in mezzo al cortile, là davanti a noi, e mi guardavano fisso. Erano anch’essi vestiti di uniformi tolte ai soldati inglesi caduti a El Alamein e a Tobruk, le loro scarpe erano scarpe di morti» (Ibidem, p. 15).
Ma chi sono costoro?
Esseri andati a rimpiazzare cadaveri, in uniformi di cadaveri, pronti per poter divenire cadaveri loro stessi al servizio del nemico?
Poi, cerchiamo per un attimo di non pensare al “cambio di bandiera”, ma solo a questo: come si fa ad accettare d’essere vestiti, a “spregio”, con divise palesemente tolte ai morti e ritinteggiate? Occorre aggiungere altro?