Sembra che almeno per ora io non sia riuscito a colmare il gap di un paio di mesi tra la stesura di questi articoli e la loro pubblicazione su “Ereticamente”, lo scarto verificatosi durante l’estate, complice da un lato la pausa estiva della nostra pubblicazione, dall’altro il fatto che proprio in questo periodo, dalla metà del 2019 in poi, abbiamo avuto davvero un florilegio di nuove informazioni e questioni riguardanti la tematica delle origini, la nostra eredità ancestrale. Nel momento in cui mi accingo a iniziare questo nuovo articolo, siamo poco oltre la metà di novembre, ma non è difficile verificare, calendario alla mano, che non riuscirà a comparire sulle pagine di “Ereticamente” prima di gennaio inoltrato.
Tuttavia, credo che si tratti di un danno relativo. Quello che conta, soprattutto riguardo a tematiche come quelle di cui ci stiamo occupando, non è tanto la notizia quanto la riflessione, l’analisi e l’approfondimento. Il vero problema è semmai un altro: magari il profluvio di informazioni che da alcuni mesi ci sta piovendo addosso riguardasse nuove scoperte, incrementi reali della nostra conoscenza, perlopiù abbiamo visto invece che si tratta di mistificazioni, un tentativo di alterare la nostra conoscenza storica e la percezione di noi stessi “africanizzandole” allo scopo di diminuire le resistenze all’invasione extracomunitaria di cui oggi l’Europa è oggetto: abbiamo visto spiattellare in rapida successione in questo anno di(s)grazia 2019 vichinghi, inglesi (quelli delle epoche passate, non dell’Inghilterra di oggi, dove Londra è diventata una città del Terzo Mondo governata da un sindaco pachistano), etruschi, romani di colore o almeno multietnici, e non da siti dei soliti quattro esaltati deficienti di sinistra (o di catto-sinistra, che fa assai poca differenza) che guardano con entusiasmo alla sostituzione etnica e alla sparizione del proprio popolo, ma da fonti finora autorevoli come la rivista “Nature” o addirittura la BBC (la televisione di stato britannica, e se questo non significa che queste aberrazioni hanno ormai il crisma dell’ufficialità…).
Bene, noi non ci siamo mai illusi che quello con cui ci siamo confrontati, non certo da adesso, fosse un contesto oggettivo basato sulla conoscenza dei fatti e la libertà di ricerca e di espressione, invece che viziato da una fortissima componente ideologica. Ora la cosa si inasprisce, la lotta per la verità, per il diritto di affermare, come diceva Chesterton, che l’erba è verde in primavera, che va difeso a fil di spada, si fa più dura, ma non sarà certo questo a indurci a smettere di lottare.
Come al solito, nel mare magnum della rete non è per nulla facile orizzontarsi, e così capita una volta di più di apprendere in ritardo cose che non è proprio possibile trascurare. Questa volta è il caso di un articolo di Robert Sepher pubblicato sul sito “The Living Spirit” in data 25 settembre e dedicato a L’impero dei tartari, la storia ariana nascosta. Di Robert Sepher mi sono già occupato in passato, si tratta di un ricercatore indipendente, “fuori dagli schemi” e dai dogmi della storia ufficiale. In poche parole, quello che noi oggi chiamiamo del tutto impropriamente l’impero mongolo e per cui Sepher preferisce la definizione di “Grande Tartaria” e che in età medioevale diventò la compagine statale territorialmente più estesa mai esistita su questo pianeta, un impero che andava dalle pianure ungheresi all’estremo Oriente, aveva nelle sue élite una importante componente “ariana”, bianca, cosa che ovviamente è oggi del tutto ignorata dalla più recente narrazione (o manipolazione) della nostra storia, tutta tesa, come abbiamo visto più volte, a minimizzare il ruolo delle popolazioni caucasiche.
“In realtà”, ci viene spiegato, “Gengis Khan aveva i capelli rossi e gli occhi verdi o blu. Esattamente come lo snello ariano Buddha, biondo e dagli occhi blu, è stato trasformato in un grasso e a volte obeso asiatico dell’est”.
Sono cose che per la verità non ci vengono del tutto nuove. Voi ricorderete che in particolare nella serie di articoli Ex Oriente lux, ma sarà poi vero?, ho più volte ricordato che contrariamente alla leggenda che ci viene propalata come “verità storica” che vorrebbe la civiltà europea dipendente “da est”, noi troviamo invece una inaspettata ma determinante componente europide alla base delle grandi civiltà asiatiche. Vi facevo, lo ricorderete, l’esempio della Cina dove questa componente è trascurabile dal punto di vista etnico-biologico ma molto importante da quello culturale. Vi ho citato l’episodio (prescindendo dalla questione se esso sia o meno storicamente avvenuto, perché quel che conta è il suo valore simbolico) dell’incontro fra Lao Tze e Confucio, e in particolare il simbolismo delle cavalcature dei due sapienti. Lao Tze cavalca un bufalo d’acqua che rappresenta “il sud”, Confucio invece un cavallo che rappresenta “il nord”. Cavallo-nord, cioè i cavalieri delle steppe settentrionali molti dei quali militavano al servizio del Celeste Impero ma erano perlopiù caucasici di stirpe turanica. Confucio si sarebbe ispirato alla loro etica fatta di lealtà verso i propri capi, rispetto delle tradizioni, devozione verso gli antenati e le divinità della propria gente, fedeltà alla parola data e agli impegni liberamente presi, e non vi è alcun dubbio che il confucianesimo sia stato la base ideologica di uno dei più vasti e duraturi imperi della storia.
Il 17 novembre il sito “The first News” che è in lingua inglese ma è polacco, ha pubblicato un articolo di Johanna Jasinska dedicato a una grande struttura circolare di età neolitica risalente a 7000 anni fa che si trova a Nowe Objezerze vicino a Cedynia nella Polonia nord-occidentale. Osservata per la prima volta nel 2015 da un appassionato di parapendio, la struttura è poi stata individuata su Google Maps nel 2016 dall’archeologo Marcin Dziewanowski. Dall’alto, la struttura apparirebbe così chiara da far pensare ai famosi e supposti alieni cerchi nel grano.
Questo tipo di strutture è chiamato dagli archeologi roundel, sarebbero recinti di età neolitica e se ne conterebbero circa 130 distribuiti tra Germania, Repubblica Ceca e Polonia. Questo di Nowe Objezerze appare particolarmente impressionante perché ha un diametro di 110 metri ed è composto da quattro fossati e tre palizzate con tre porte che conducono al centro. Era, spiegano gli archeologi, con tutta probabilità un luogo di culto oltre che un punto d’incontro delle comunità, una religione probabilmente basata sull’osservazione del cielo e i movimenti degli astri, perché l’allineamento fra il centro della struttura e le porte presenta significative correlazioni astronomiche.
Il ritrovamento di frammenti di ossa, cocci di vaso, pietre focaie, un frammento di quarzite, fa pensare che il luogo fosse intensamente frequentato.
Vorrei aggiungere qui una considerazione personale di cui mi assumo tutta la responsabilità; viene da pensare che il roundel sia stato l’antenato del circolo megalitico, basterà sostituire le palizzate lignee con pilastri di pietra, menhir per passare da una tipologia all’altra. Il punto di transizione è forse rappresentato da Gosek in Germania, che non a caso è il più antico circolo megalitico conosciuto.
“The Siberian Times” del 20 novembre ha comunicato un ritrovamento eccezionale avvenuto in quell’autentica miniera di tesori archeologici che è la grotta di Denisova nell’Altai. Un team di ricercatori dell’Istituto di archeologia ed etnografia di Novosibirsk ha rinvenuto una statuetta scolpita in avorio proveniente da una zanna di mammut che raffigura un leone delle caverne nell’atto di saltare. Dalla posizione nella stratigrafia della caverna, si è potuto dedurre che essa ha un’età compresa tra i 40 e 45.000 anni e si può attribuire con ogni probabilità proprio a un uomo di Denisova.
Già in passato sono state ritrovate pitture rupestri, nonché una costruzione “architettonica” come il doppio cerchio di stalagmiti della grotta francese di Bruniquel, attribuibili all’uomo di Neanderthal. Ora abbiamo la prova che anche i Denisoviani erano capaci di manifestazioni artistiche. Credo che ormai non possano sussistere dubbi sul fatto che gli uni e gli altri erano uomini, esseri umani tanto quanto lo siamo noi, e questo sempre che il fatto che entrambi questi gruppi si siano ripetutamente incrociati con gli uomini di Cro Magnon dando luogo a una discendenza fertile dalla quale a nostra volta noi stessi discendiamo, non fosse già di per sé una prova sufficiente.
Il fatto che in passato l’uomo di Neanderthal sia stato e in parte continua ancora oggi a essere falsamente raffigurato come un bruto scimmiesco, e la scarsa conoscenza che tuttora abbiamo dell’uomo di Denisova, tendono a occultarci questo fatto, ma se queste creature erano Homo sapiens quanto lo siamo noi, allora l’Out of Africa, la supposta “teoria” dell’origine africana è clamorosamente smentita, non solo perché questi uomini chiaramente sapiens erano presenti in Eurasia molto prima della presunta uscita dall’Africa della nostra specie, ma anche perché se la genesi di essa e la tripartizione nei ceppi di Cro Magnon, Neanderthal e Densova fosse avvenuta in Africa, anche nei neri subsahariani si troverebbero le tracce del DNA neanderthaliano e denisoviano, cosa che sappiamo non succede.
C’è da ringraziare il Cielo che questa scoperta sia avvenuta in Russia dove i ricercatori possono lavorare e pubblicare liberamente, e non in Occidente dove bisogna salvaguardare a tutti i costi il dogma della presunta origine africana, ed essa con ogni probabilità sarebbe stata rapidamente occultata.
Il 26 novembre “Discover Magazine” ha riportato la notizia dei ritrovamenti avvenuti in Siberia nel sito di Mamontovaya Kurya nei pressi del fiume Yana oltre il circolo polare artico, dal team di archeologi guidati dal professor Vladimir Pitluko dell’Istituto per la storia della Cultura Materiale di San Pietroburgo, ritrovamenti che consisterebbero in un gran numero di manufatti di pietra, osso e avorio (prevalentemente di mammut) che coprirebbero una fascia temporale che va da 40.000 a 18.000 anni fa.
Secondo gli archeologi russi, gli uomini appartenenti a quella che è stata chiamata la cultura Yana avrebbero dato vita a una cultura avanzata e sofisticata per l’età paleolitica, la cui base sarebbe stata la caccia a grandi animali come mammut e rinoceronti lanosi.
Questo ci riporta a un discorso che abbiamo già visto: è verosimile che durante quella che chiamiamo l’età glaciale, mentre le regioni oggi temperate erano strette dalla morsa del gelo, l’artico godesse di un clima molto più mite di quello attuale, favorevole alla vita di una megafauna e all’insediamento umano, infatti, grandi animali come i mammut non potrebbero vivere nell’Artico attuale, non tanto per il freddo, quanto per l’impossibilità di reperire cibo, a parte i licheni sepolti sotto la neve che oggi in quelle regioni permettono una stentata sopravvivenza alle renne e ai loro allevatori. Ricorderete che qualcuno ha ipotizzato uno scivolamento della crosta terrestre che avrebbe trasformato in polari regioni prima temperate e viceversa.
Non è tutto, perché “LiveScience”, sempre relativamente a questa sconosciuta “cultura Yana” ci dà un’informazione davvero sorprendente: l’analisi del DNA condotta su alcuni denti da latte ha rivelato che questi antichi cacciatori di mammut erano geneticamente diversi dagli attuali siberiani e si ipotizza che “venissero da ovest”. Beh, diciamolo pure, l’attuale antropologia è costretta a esprimersi in un linguaggio criptico perché per motivi politici occorre fare finta che le razze umane non esistano. Tradotto, significa che gli Yana erano di ceppo caucasico e non mongolico. Ma qui il discorso si fa complesso: dobbiamo pensare a una migrazione isolata, o non piuttosto a un’antica forte presenza caucasica nel cuore dell’Asia, esattamente come ipotizzato da Robert Sepher?
Il 3 dicembre “Il Giornale” – l’articolo è di Lavinia Greci – ha riportato la notizia del ritrovamento nel permafrost siberiano del corpo di un cucciolo perfettamente intatto, non si sa bene di lupo o di cane risalente a 18.000 anni fa (l’incertezza è dovuta al fatto che si suppone che proprio a quell’epoca sia avvenuta la domesticazione dei lupi i cui discendenti sono poi diventati i nostri cani domestici). Il corpo del cucciolo che è stato chiamato Dogor, è stato rinvenuto un anno e mezzo fa nei pressi del fiume Indigirka nella Siberia orientale, ed è attualmente conservato e studiato presso l’università di Jakutsk.
Nell’articolo, l’autrice ricorda anche che, sebbene il riscaldamento globale rappresenti certamente un danno per il pianeta, quanto meno il progressivo scioglimento del permafrost siberiano si sta rivelando una miniera di informazioni inaspettate sul passato delle regioni artiche, ed enumera i ritrovamenti di resti di animali che sono avvenuti in questi anni: un bisonte, un rinoceronte lanoso, un puledro mummificato. Ci sarebbero da aggiungere ancora il ritrovamento di un cucciolo di leone delle caverne in uno stato di conservazione solo un po’ meno buono di quello di Dogor, e se vogliamo, anche dei resti di un genere estinto di iena, il Chasmaportetes, avvenuto in Alaska. Una fauna che lascia intravvedere una situazione climatica delle regioni artiche molto diversa da quella di oggi, e ben più propizia all’insediamento umano.
In questi anni la Russia, la Siberia, le regioni artiche si stanno trasformando sempre più nell’Eldorado dell’archeologia preistorica, della paleoantropologia, della ricerca delle nostre remote origini. Quanto questo sia compatibile con la teoria della genesi africana, questo lo lascio decidere a voi.
Voi mi perdonerete se stavolta concluderò questo articolo in maniera insolita, andando a considerare non l’eredità degli antenati lontana nel tempo ma quella vicina, molto vicina a noi. Ai primi di dicembre, un tizio che non voglio nominare, ma si tratta chiaramente di un “compagno”, una testa di sardina, ha postato su facebook un commento secondo il quale le “marocchinate” commesse dai goumies nel 1944 contro le popolazioni dell’Italia centrale sarebbero state “una ripicca” per gli stupri commessi dai soldati italiani contro le popolazioni francesi durante la prima guerra mondiale. Questa fesseria partorita da un cervellino malato tuttavia offre il destro ad alcune importanti considerazioni. PRIMO: questi sinistri sono sempre pronti a inventare scuse per giustificare o sminuire qualsiasi atrocità commessa contro l’Italia e gli Italiani, mostrando quello che potremmo definire un masochismo etnico, un odio di fondo verso i propri connazionali. SECONDO: ammesso e non concesso che fatti del genere fossero avvenuti durante la Grande Guerra, non si capisce proprio cosa dovesse importare ai marocchini di quanto possa essere accaduto alle donne francesi una generazione prima. Qui si evidenzia un’altra distorsione della mentalità di sinistra per la quale un pezzo di carta o il colore di una divisa farebbero la cittadinanza, senza tenere conto della nazionalità etnico-biologica. TERZO: la suddetta testa di sardina ignora bellamente che durante la prima guerra mondiale Italia e Francia erano alleate, e che ciò che asserisce per giustificare gli stupri dei marocchini non può essere mai successo. Poiché, diciamolo pure, la sinistra nel dopoguerra ha occupato tutte le posizioni di rilievo in campo accademico, culturale, nella stampa, nei media, nella scuola, tra i cosiddetti intellettuali, noi ci siamo portati dietro per decenni un complesso di inferiorità culturale nei loro confronti. Oggi che grazie ai social media possiamo conoscere davvero “il pensiero” di questa gente (anche se “pensiero” riferito a costoro è una parola grossa), ci possiamo rendere conto della verità; sono ignoranti come capre, e di conseguenza pronti a credere qualsiasi baggianata, purché intrisa di odio anti-italiano.
NOTA: nell’illustrazione a sinistra la ricostruzione di un guerriero vichingo, ed è l’ennesima risposta alla polemica iniziata da “Nature” la scorsa estate. Voi stessi potete giudicare se abbia una fisionomia multietnica o prettamente caucasica. Al centro, una ragazza tartara nel costume tradizionale; anche nei suoi lineamenti di mongolico se ne vede assai poco. A destra, la ricostruzione del volto dell’uomo di Denisova.





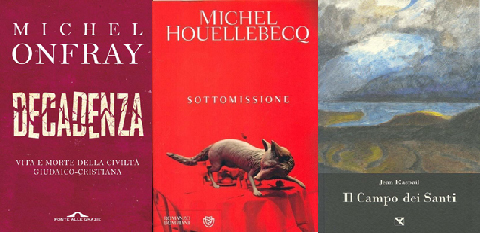

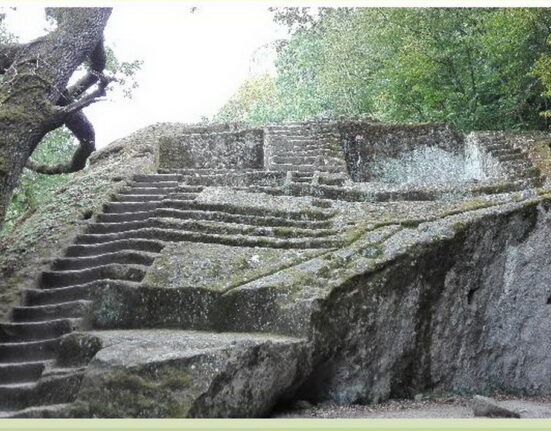
5 Comments