« …Est igitur… Res Publica Res Populi,
Populus autem non omnis hominum coetus
quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis
juris consensu et utilitatis communione sociatus»
[Cicerone, De Re Publica, I, XXV].
di Giandomenico Casalino
Se la Romanità, come è diffusamente trattato nei miei libri, si fonda sul Rito giuridico-religioso, allora la stessa è qualificata da un’unica, nel mondo indoeuropeo, anteriorità logica e quindi cronologica del Rito (jus) nei confronti sia della Politica che del Pensiero come epistéme, scienza sistemica dell’Essere; ciò di conseguenza esprime la verità che il Rito di fondazione della Civitas non è solo di fondazione di quest’ultima, come è tradizionalmente acquisito per la restante cultura indoeuropea, ma è di fondazione, nel senso che è il loro arché, di tutto ciò che è conosciuto come di ciò che non è conosciuto, anzi il tutto della civitas si fonda sul concetto che da quel “momento” in poi (dal Rito di fondazione…) a decidere (cioè ad essere il Politico…) ciò che è lecito e ciò che non lo è (cioè a fare “morale” nel senso cristiano-moderno della parola. . .) sarà solo e soltanto il Rito giuridico-religioso; esso, pertanto, dopo aver creato la Civitas ed essere quindi prima della stessa, continua a conservare la sua primazia su tutto il mondo romano, ché quest’ultimo da esso è creato. Prima del Rito che fonda e crea il mondo-città ed è il suo archè c’è “solo” il Rtà come Ordine-Rito Celeste, c’è l’Immanifesto, ed il Rito che il Fondatore (Romolo) esegue è ad imitazione di quello (Celeste) e determina nel metafisico ciò che irrompe “poi” nel fisico, come irruzione del Principio che è il Manifesto, cioè la storia del “Mondo”, che è come dire della Res publica…
Tale è la ragione per cui jus = rito equivale a mos = ritualità[1] come costumi, rituali, norme consuetudinarie sentite come cogenti (Mos Majorum) che sono e provengono dai Majores,per l’appunto i Maggiori cioè i più Grandi in quanto sono gli Avi e perciò più vicini all’Origine e quindi agli Dei;questo è il significato di ciò che affermiamo in ordine al fatto spirituale che nella Romanità diritto (jus) si identifica a morale (mos).
In tale senso il Diritto-jus è “al di là della morale”!
Nella Romanità infatti la “morale” non esiste come fatto psichico, “naturale”, individuale, pre-comunitario cioè nel senso cristiano-moderno (ed Hegel questa natura della “morale” l’ha compresa e tematizzata…) ma è “sollevata” dalla naturalità e identificata con l’Eticità, con la spiritualità del jus, divenendo Mos Majorum, realtà metafisica, oggettiva, sovrapersonale, sacra e quindi immodificabile ed indiscutibile. Questa è la ragione profonda per cui all’origine della Civitas romana non c’è la repressione del peccato ma la inesorabile punizione divina dell’errore, perché il primo è fatto psichico e individuale, il secondo è fatto spirituale e oggettivo, sovrapersonale: Remo cade, è un “fallito” (fàllere = cadere…) poiché commette l’errore di violare l’Ordine effettuale al Rito. Questo discorso della “assenza” della moralità, o meglio della sua dimensione essoterica e/o umana con la presenza in senso dualistico di bene e male e distinzione nonché contrapposizione di valori contrapposti, nella Romanità, viene straordinariamente negato e superato nell’Oggettivismo esoterico del jus, del Rito, dove è l’unica realtà del vero e del falso, dell’atto secondo il Rito che produce il Vero. La “morale”, in senso moralistico, non c’è più nella oggettività assoluta del cosmico Rtà, l’Essere è il Vero ed il “male” è soltanto presente come tale nella “conoscenza” limitata e particolaristica che, nella Romanità, in virtù della esistenza fondante del Rito e della sua esoterica valenza, viene a corrispondere alla fase preurbana, cioè precedente la incursione di Roma nel manifesto, il che è come dire che fenomenologicamente non è mai esistita. L’Oggettivismo esoterico nell’unità dell’Esistente, che è l’Assoluto, considera ciò che la morale con il suo essoterico naturalismo dualistico definisce “bene” e “male”, momenti necessari del Tutto, in sé non sussistenti poiché singolarmente astratti, momenti che, dal punto di vista del Rito giuridico-religioso, punto di vista metafisico che si identifica con la Idea stessa metastorica di Res publica, costituiscono, negati e superati, l’unità suprema del Cosmos che è la medesima Romanità.
Nella modernità l’unico Sapere filosofico che riproduce tale “irreligioso” amoralismo è quello di Hegel proprio perché nell’esoterico identificarsi del Pensiero con la Realtà (nel senso che è poi Pensiero anch’essa) tale Esperienza dello Spirito è l’Esperienza dell’Assoluto che conosce Se medesimo, pertanto non vi è più dualità né trascendenza di un Bene con cui si confronta ed a cui aspira l’umano errare nel “male”; tutto ciò in ragione del fatto spirituale dell’avvenuto superamento del rapporto religioso Io-Te, con subalternità del primo nei confronti del secondo; e tale rapporto è superato in virtù del Sapere che è l’Anamnesi della inesistenza ab origine di tale dualità; ed è la Realtà metafisica e tradizionale del Sapere filosofico, che non è più la limitatezza dualistica e devozionale del religioso-morale, ma è e consiste nel processo dell’Identificazione filosofica, del riconoscimento della necessità spirituale del Mondo: il suo discorso sarà «Io sono Te! E non più Io e Te!».
Le determinazioni essenziali di tale Oggettivismo, sono pertanto, il Vero e il Falso ed il Rito, eseguito secondo la Tradizione, produce il Vero nel senso che fa esistere il mondo, cioè lo crea e crea il civis, la Res publica; senza il Rito-jus
(quello che noi chiamiamo Diritto) il Romano non entra nella storia, non passa dall’Immanifesto (Amor) al Manifesto (Roma) cioè non agisce e quindi non esiste, né come Civis né come Populus, non realizza la sua natura: l’Ascesi dell’Azione. L’Azione è l’Atto che, provenendo dal Rito, essendo il suo effetto inevitabile, racchiude il Tutto; è quel “mondo” che, come si è detto, precede logicamente l’intero essere uomini, essere comunità, essere insieme agli Dei, per la semplice ragione che “tutto” il mondo-comunità, gli uomini nella loro “culturale” natura e gli Dei medesimi sono creati dal Rito (il sacrificio nutre gli Dei; li incrementa, li “irrobustisce”, li “ricrea” periodicamente rinnovando l’Atto primordiale di divinificazione con il quale essi stessi “si fecero” Dei…). Il verbo tecnico del sacrificare è mactare che significa “rendere grande”[2]. Il jus attribuisce quindi al romano la capacità-facoltà di agire nella storia, cioè di esistere, di agire nella Res Publica, nelle magistrature, nel Popolo e con il Popolo; senza il jus il romano sarebbe impossibilitato ad agire, senza Ascesi dell’ Azione non esisterebbe; è il jus che lo fa entrare nella “storia”, sarebbe a dire nella vicenda umana e lo fa essere ordinatore-creatore della stessa. Tale realtà prima della presenza ordinatrice del Romano, e cioè del Rito, noi possiamo dire che è realtà talmente “naturale” che è quasi belluina, more ferarum; tale concetto però lo esprimiamo noi, per la cultura romana invece essa semplicemente non esiste come mondo degli uomini liberi (Leggi, ordine e competenze. . .), bensì come caos animalesco.. .
La Forma che è la Luce, Roma non la vede-conosce nel Mondo, bensì la crea con il Rito giuridico-religioso ed è la Res publica; essa è il Kosmos dei Greci, è la Idea di Juppiter o lo “Stato” come Idea, come paradigma (in senso proprio platonico) che si realizza nel tempo, nel divenire che è il Mito di Roma ma è “sospeso” nell’Istante dell’Eterno come Idea della Mente divina, come teleologica Civitas augēscens, come Mondo romano che è l’Ordine della Legge e del Rito da difendere, accrescere, diffondere, elargire, donare a tutti i Popoli. La Forma romana si “costruisce”, si crea ogni giorno, ogni momento, ed è creata dal Popolo Romano nel suo impersonale anonimato mediante la Legge che si promulga, l’Editto che si emana, la strada, la basilica, l’acquedotto, le terme, i Templi, i Fori, le Città che si edificano, i diritti che si diffondono, il Limes che si difende, il posto a cui il legionario è stato comandato e che in nessun caso e per nessuna ragione viene abbandonato, l’alleanza (Pax Deorum) tra il Numen del Principe e gli Dei, la veneranda santità del Senato e l’auspicata Sovranità del Popolo Romano stesso convocato nei suoi Comizi, la cui Majestas è seconda solo a quella di Giove Ottimo Massimo.
[1] FESTO, De verborum significatione (L 364, 34): «ritus est mos comprobatus in administrandis sacrificiis»; cfr. anche, P. CERAMI, G. PURPURA, Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano, Torino 2007, pp. 296 ss.
[2] G. CASALINO, Res publica res populi. Studi sulla tradizione giuridico-religiosa romana,Forlì 2004, pagg. 88 ss.

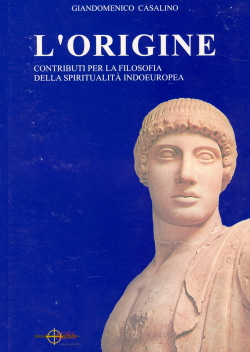


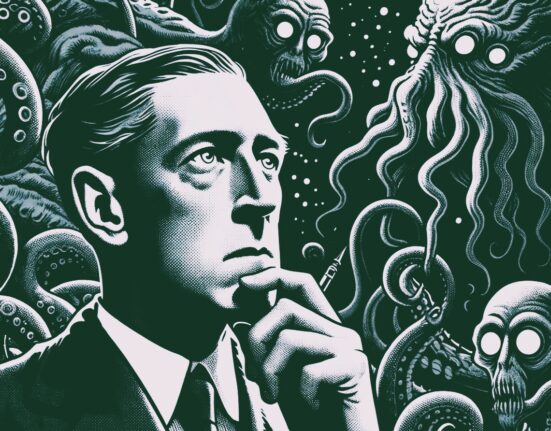
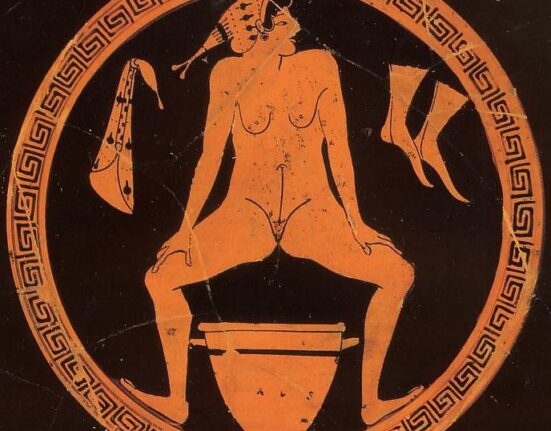
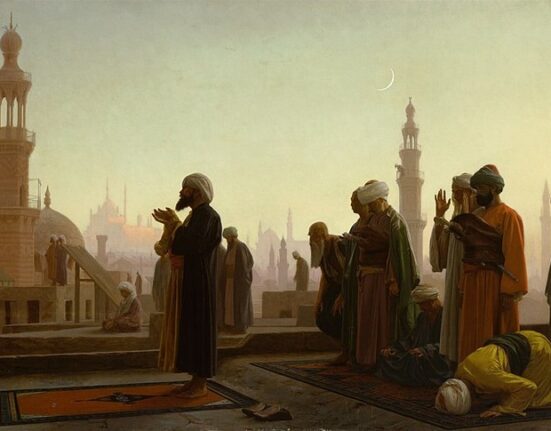
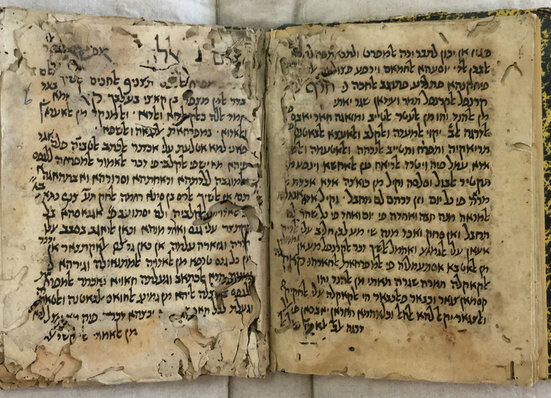
1 Comment