Nicoletti e colleghi scrivono: “Il linguaggio umano e l’uso che ne facciamo è forse la caratteristica determinante del comportamento mentale della nostra specie. Nessun’altra forma di comunicazione di altre specie viventi si avvicina alla complessità e alla flessibilità del linguaggio umano. Il linguaggio è una funzione che pervade la nostra attività mentale e molte delle attività cognitive, come il pensiero, la soluzione di problemi, i giudizi. Il linguaggio e il suo uso coinvolgono molti aspetti delle nostre capacità cognitive, come è facilmente intuibile se si pensa alla produzione e alla comprensione di materiali linguistici, alla memorizzazione e al recupero dei significati, alla gestione della dinamica comunicativa”.
Il linguaggio verbale sembra essere:
- Congenito: è una facoltà mentale che nasce con l’organismo, è registrato nel suo patrimonio genetico e rimane a livello potenziale finché uno stimolo la fa emergere. Bambini allevati da animali avevano la capacità di linguaggio ma non hanno avuto stimoli per cui non hanno potuto svilupparlo e quindi mai usarlo;
- Inapprendibile: essendo una facoltà mentale innata, non viene insegnato né imparato;
- Incancellabile: non si perde il linguaggio come facoltà mentale;
- Universale: caratterizza allo stesso modo tutti i membri della specie, indipendentemente dalle condizioni sociali, storiche e geografiche in cui essi vivono;
- Immutabile.
Il linguaggio potrebbe non manifestarsi ma non cancellarsi. In caso per esempio di malattie degenerative o incidenti.
Le lingue (storico-naturali) sono una delle possibili realizzazioni del linguaggio.
Esse sono un prodotto sociale del linguaggio: le lingue non esistono come oggetti indipendenti dalle comunità che le usano. Una lingua è un codice, cioè un sistema di segni; in altre parole, è un insieme di convenzioni adottate da una comunità di parlanti.
Le lingue sono sistemi simbolici attraverso i quali possiamo comunicare e che rivestono di SIGNIFICATO (contenuto simbolico) dei SIGNIFICANTI (vibrazioni dell’aria o della luce).
Invece le lingue storico naturali sembrano così:
- Non sono congenite;
- Sono apprendibili; ogni essere umano impara una o più lingue:
- Sono cancellabili, si dimenticano;
- Non sono universali: sulla terra oggi sono parlate oltre 6000 lingue:
- Sono mutevoli, cambiano continuamente, nel tempo, nello spazio.
Pertanto una lingua è un sistema di segni organizzato in un insieme di suoni, che si combinano in unità dotate di significato, che si combinano in parole, che si combinano in frasi che rimandano a significati convenzionalizzati all’interno di una comunità umana.
Nel nostro cervello le basi genetiche del linguaggio e le parole apprese di una lingua sono immagazzinati nel Lessico Mentale. Il lessico mentale è una struttura complessa che contiene le conoscenze morfologiche, ortografiche, fonologiche, sintattiche e semantiche associate ai costituenti linguistici. Esso fa parte della memoria semantica, un deposito di tutte le conoscenze linguistiche che si sono succedute nella nostra vita.
Dalla metà del Novecento è prevalsa l’idea che la mente umana operi su rappresentazioni che avrebbero le seguenti caratteristiche:
- Le rappresentazioni mediano tra stati di sistemi intelligenti contenenti informazioni;
- I sistemi cognitivi necessitano di rappresentazioni permanenti nel tempo;
- Queste sono caratterizzate anche da simboli;
- Esistono rappresentazioni tipiche dei vari sistemi percettivi specifici e altre amodali (cioè astratte);
- Le funzioni cognitive sono indipendenti dal sistema fisico dell’agente che le porta avanti.
La psicologia distingue, entro la memoria a lungo termine, una memoria semantica (i concetti che tutti noi depositiamo nella mente) e una memoria episodica (i fatti della nostra biografia). In realtà è una distinzione più artificiosa che altro: i dati mnestici, infatti, sono tra di loro correlati. In ogni modo la memoria semantica, cioè la nostra conoscenza, viene spiegata in due maniere differenti:
- Ci sono modelli in cui la conoscenza sarebbe formata da sistemi diversificati. Pensiamo al Modello del Doppio Codice di Paivio, che prevede due sistemi entro la memoria semantica, uno verbale e uno non verbale, che collaborano insieme. Quando noi ci formiamo l’idea di un oggetto, il sistema visivo (non verbale) si fa una immagine che poi viene elaborata da quello linguistico. Su questa linea pensiamo anche al Perceptual Symbol System di Barsalou, basato sulla ipotesi che il sistema concettuale elabori e manipoli simboli percettivi, modali e analogici.
- Altri modelli sostengono che la nostra conoscenza è formata da un sistema unico. I primi modelli fanno pensare a un sistema di elaborazione analogico (cioè che mima i vari tipi di sensazioni), invece il modello unico fa pensare a un sistema amodale (cioè astratto).
Il problema della memoria semantica riguarda anche il problema del ragionamento, perché noi ragioniamo con i dati che abbiamo immagazzinato in memoria. Il pensiero è solo verbale o abbiamo anche un pensiero immaginale? Il primo avrebbe la sua sede d’elezione nell’emisfero sinistro, il secondo nell’emisfero destro. Gli scienziati oggi ravvisano delle differenze tra pensiero deduttivo e induttivo anche a livello cerebrale. Nei compiti che hanno a che fare con il pensiero deduttivo si attiva la parte posteriore dell’emisfero dentro, invece in quelli riguardanti il pensiero induttivo si attiva l’emisfero sinistro in una regione della corteccia frontale nota per essere implicata nello stimare la quantità delle cose. Non solo, ma pare che la corteccia orbito-frontale sia implicata nella valutazione delle conseguenze delle proprie azioni.
Le scoperte recenti dei neuroni specchio e dei neuroni canonici dimostrano come la nostra cognizione sia basata su strutture neurali collegate alla visione e al movimento. Di solito si pensa che le funzioni motorie siano inferiori a quelle più elevate del pensiero. In realtà oggi si sa che noi pensiamo tramite rappresentazioni mentali che includono informazioni provenienti dal sistema motorio e da quelli sensoriali, soprattutto il visivo.
I neuroni specchio si attivano quando si compie l’azione e/o si vede che la compie qualcun altro. Invece i neuroni canonici si attivano quando si compie l’azione e/o quando si vede l’oggetto in questione. L’esistenza dei neuroni specchio dimostra la simulazione, cioè una risonanza motoria nel nostro cervello quando qualcuno compie una azione. L’esistenza de neuroni canonici dimostra la affordance, proposta da Gibson, cioè che gli oggetti sono strutturati relazionalmente con il nostro cervello a far sì che quest’ultimo li consideri invitanti. Una bella donna è strutturalmente congegnata per far sì che il nostro cervello la consideri invitante per la procreazione. Sui neuroni specchio e sui neuroni canonici si basa la teoria che il sistema motorio abbia in sé lo scopo, cioè uno schema mediante il quale eseguire il movimento e che viene rispecchiato in noi guardando l’ambiente esterno. Ora, in noi gli schemi dello scopo sono schemi cognitivi perché siamo esseri pensanti, cioè sono rappresentazioni mentali. Quando nell’uomo si parla di cognizione non si può non pensare al linguaggio verbale, che struttura gran parte del nostro pensiero inconscio e conscio. Quindi, in base a questi studi, esisterebbe uno stretto legame tra movimento, visione, pensiero e linguaggio verbale.
Rizzolatti e Sinigaglia affermano che “il cervello che agisce è anche e innanzitutto un cervello che comprende”. Le aree motorie sono fondamentali non solo nella esecuzione dei movimenti ma anche in compiti superiori come il pensiero, la comprensione e il linguaggio. Secondo la scienza cognitiva precedente vi era una distinzione netta tra sistema cognitivo e sistema motorio: ognuno svolgeva compiti autonomi. Oggi invece in base alla scoperta dei neuroni specchio e dei neuroni canonici si teorizza un sistema unico nel quale le aree motorie del nostro cervello servono anche per il pensiero più sofisticato. C’è un famoso esperimento nel quale una scimmia al buio sente il rumore di una noce che si rompe: nel suo cervello scarica lo stesso neurone specchio che scarica quando la scimmia rompe la noce e quando la scimmia vede rompere la noce. Questo dimostra che esiste un solo sistema neuronale deputato al concetto astratto del rompere che si attiva tanto nella azione quanto nella percezione visiva e uditiva.
Il sistema dei neuroni specchio e dei neuroni canonici servirebbe altresì per farci apprendere per imitazione ciò che vediamo fare negli altri. sarebbe questa la base evolutiva del linguaggio umano. Noi impareremmo a parlare per questa ragione: se vediamo che qualcuno parla, si accende in noi il neurone specchio che poi ci consente di imitare quel gesto.
C’è da dire altresì che gli studi sui neuroni specchio e sui neuroni canonici tendono a prenderli in esame singolarmente. Questo approccio non è in linea con le tendenze attuali delle neuroscienze. Non si pensa più, infatti, che l’unità funzionale del cervello sia il neurone bensì la sinapsi. Per di più oggi non si pensa che il funzionamento del corpo in generale sia basato sulle cellule bensì sulla Matrice Extracellulare, cioè sullo spazio tra le cellule, nel quale queste inviano i prodotti del metabolismo e da dove assumono i nutrienti indispensabili per svolgere le loro attività. Oltretutto, oggi il funzionamento del cervello non è più demandato ad aree specifiche, ma a un intero sistema tra aree diverse in tutti e due gli emisferi detto network. Pensiamo al linguaggio verbale: esso funziona grazie a due network, quello delle strutture più profonde (i gangli basali, connesso alla fonazione e al controllo motorio) e quello delle aree superiori (corteccia, responsabile delle funzioni astratte e cognitive più elevate). Insomma oggi non si accetta più la mera suddivisione tra emisfero destro e emisfero sinistro, ma si propende verso il modello di Lieberman, il quale vede il cervello a strati, dal più interno al più esterno.
In ogni modo, anche se il modello a singola cellula proposto per lo studio dei neuroni specchio e dei neuroni canonici non è in linea con le tendenze attuali delle neuroscienze, bisogna dire che le neuroscienze non hanno stabilito ancora nessuna verità assoluta sul funzionamento del cervello. Quindi si continua a fare ricerca per scoprire cose nuove, e, come è sempre stato, si trovano come migliori guardando dove gli altri non si aspettano di guardare!
Facciamo questo esempio. Oggi molti studi dimostrano come la comprensione del linguaggio comporta una attivazione delle aree motorie e influenza il comportamento motorio esplicito. Citiamo un recente studio di Scorolli che dimostra come il pattern motorio del sollevamento di un oggetto sia influenzato dal tipo di frasi ascoltate durante l’atto. Nello specifico, i partecipanti all’esperimento sono più lenti quando il peso suggerito dalla frase e quello reale dell’oggetto da sollevare corrispondono. Questo effetto va a sostegno della teoria della simulazione, elaborata a partire dai neuroni specchio. È proprio vero che cercando non si finisce mai di trovare!
La scienza cognitiva classica immaginava le attività della mente umana come rappresentazioni astratte di tipo logico-matematico, quindi pensava che tutta la mente fossa strutturata in base al linguaggio verbale. Invece la scienza cognitiva di seconda generazione è fondata su neuroscienze, modelli biologici come quelli del connessionismo, etologia, psicologia della sviluppo: questa nuova prospettiva “incarnata” sembra allontanarsi dal modello della natura linguistica della mente umana. Ma questo abbandono non è totale: il linguaggio verbale è sempre importantissimo nell’uomo, anche se non rappresenterebbe ogni sorta di processo psichico. Evidentemente l’essere umano ha alcune percezioni non concettuali che strutturano l’esperienza linguistica. Non solo, ma il bambino condivide parzialmente conoscenze di tipo non linguistico con i primati. Quindi oggi si sa che non tutto nell’uomo è linguaggio verbale, ma non è vero nemmeno il contrario. C’è sia il non verbale sia il verbale nella mente umana.
Il linguaggio non verbale è costituito da segni non verbali, come quelli corporei. Il linguaggio verbale è costituito da parole, cioè da segni linguistici. In ogni modo il linguaggio è sempre una attività simbolica della mente umana. Il simbolo è grossomodo un segno cioè un oggetto o un suono caricato di un valore ulteriore, cioè un significato. Si parla di homo symbolicus. In realtà l’uomo è polysymbolicus in quanto anche gli animali hanno dei segni altresì se non verbali, come l’odore, mediante i quali comunicano un messaggio. L’uomo ha anche il linguaggio verbale, quindi ha “più” di un tipo di simbolizzazione.
Animali e uomini hanno in comune anche una percezione intermodale, cioè non vediamo solo un falco in volo ma nella stessa percezione uniamo anche la sensazione del grido del volatile. In questo senso, come diceva Merleau-Ponty, “la sinestesia è la regola”. Quando parliamo di sinestesia, ci riferiamo a una figura retorica per cui “le note del pianoforte sono rosse” o l’”uva è intonata” o “le parole sono verdi”. La sinestesia fonde più modalità percettive. Quindi ogni animale è in fondo sinestetico.
Addirittura Cytowic ha ipotizzato scientificamente che la sinestesia sia la nostra vera natura. Nella cosiddetta sindrome sinestetica un malato neurologico vede le parole colorate o ascolta suoni che hanno odore. Per Cytowic la sindrome sinestetica sarebbe un emergere alla coscienza del malato della nostra vera natura animale. Questa nostra vera natura sarebbe celata all’uomo normale. Cytowic spiega la sindrome sinestetica con un interessamento del sistema limbico, escludendo la corteccia. Dato che la corteccia è sviluppata soprattutto negli uomini, invece il sistema limbico è presente ben sviluppato sia negli uomini sia negli animali, lo studioso conclude che la sinestesia sia la nostra vera natura animale. Ipotesi assai interessante, anche se gli studiosi non sono tutti d’accordo. Durante i primi mesi di vita il bambino ha un numero di sinapsi maggiore di quello dell’adulto, poi esse vengono potate durante lo sviluppo. Maurer e Harrison ipotizzano che la sindrome sinestetica dipenda da una difettosa potatura delle sinapsi. Invece Grossenbacher la spiega chiamando in causa il contatto tra aree cerebrali differenti per via di un ritardato processo di mielinizzazione.
Nell’uomo i simboli non solo comunicano qualcosa ma creano quell’universo simbolico mediante il quale egli acquisisce consapevolezza della realtà che lo circonda. Come scriveva Fromm, se noi vediamo una particolare oscillazione energetica e la chiamiamo “tavolo”, è perché la cultura ce lo ha insegnato sin da piccoli, altrimenti daremmo altra significazione a quella oscillazione energetica. È l’universo simbolico nel quale siamo inseriti, costituito da segni non verbali e da segni verbali, che struttura il nostro modo di stare al mondo.
Quando il bambino impara a parlare, ha una vocazione simbolica che lo spinge a denominare le cose. Questa conquista della denominazione ha tali conseguenze:
- Il bambino cambia la sua posizione rispetto alla realtà divenendo “soggetto” verso gli “oggetti”;
- Dato che nel bambino l’oggetto e il nome coincidono, egli mediante il nome possiede l’oggetto.
In seguito il bambino diviene sempre più padrone delle parole. A 2 anni è in grado di esprimere i propri stati mentali e percettivi con parole tipo “volere”, “vedere”, “sentire”. A 3 anni sa esprimere stati cognitivi e quindi compaiono parole come “pensare”, “sapere”, “ricordare”. A 4 anni comprende le false credenze. Ma sin dai 2 anni ha una teoria della mente, cioè riconosce le intenzioni degli altri: per esempio, se la mamma non gli toglie bene la scarpetta, comprende lo scopo e porta a termine l’azione di sua iniziativa.
Il linguaggio verbale è il prodotto della evoluzione nel senso che l’uomo ha acquisito la parola per rispondere in maniera raffinata alle raffinate esigenze che si affacciavano. Ma il linguaggio è anche il frutto della particolare interazione sociale tipica dell’uomo: con la parola l’uomo trasmette agli altri la sua conoscenza e li aiuta nella costruzione dei significati di una certa cultura.
Una parola si compone di due unità minime (doppia articolazione, presente solo nel linguaggio verbale degli umani):
- Il MORFEMA è l’unità minima dotata di significato (come la O di “gatto” che indica il significato grammaticale, cioè il genere e il numero, oppure GATT-, che veicola il significato semantico, per il quale pensiamo all’animale a quattro zampe con la coda che fa le fusa);
- Il FONEMA (i morfemi sono costituiti dalle singole lettere dell’alfabeto italiano, che vanno intese come unità minime di suono).
A loro volta i fonemi possono realizzarsi nelle varie lingue in maniera diversa e quindi si parla di ALLOFONI. La C di cane è diversa dalla C di ciccia: le due C sono due allofoni di uno stesso fonema.
Le frasi hanno tra loro relazioni di due tipi:
- Relazioni sintagmatiche (in presenza): quando diciamo che “Il gatto rincorre il topo” colleghiamo il soggetto (che esprime l’agente, cioè chi fa l’azione) con il verbo (che esprime l’azione). Quindi gatto e rincorrere sono due parole collegate dentro la frase in un rapporto in presenza in quanto sono scritte.
- Relazioni paradigmatiche (in assenza): quando diciamo “Il gatto rincorre il topo” la parola topo si apre a una serie potenzialmente infinita di variabili, come “Il gatto rincorre la lucertola” o “Il gatto rincorre la foglia”, per cui la parola topo e la parola lucertola sono in un rapporto non scritto (cioè non in presenza) ma solo virtuale, potenziale (cioè in assenza).
In realtà non abbiamo ancora una definizione precisa di parola:
- dal punto di vista tipografico è quella cosa che su un libro sta tra due spazi bianchi;
- dal punto di vista fonologico è quella cosa che ha almeno un accento primario;
- dal punto di vista morfologico è quella cosa all’interno della quale non si può mettere/aggiungere altro materiale linguistico (“capostazione” non si può spezzare).
Quindi una parola è la minima combinazione di morfemi che può essere considerata, da sola, un segno linguistico.
Il segno è la unione di un significato con un significante: il triangolo stradale è un pezzo di plastica (significante) che indica che il veicolo è fermo lungo la strada per un guasto (questo è il significato). Il segno può essere non verbale (come il triangolo) oppure linguistico o verbale. Il segno linguistico è quel particolare segno adottato da una lingua, cioè grossomodo una parola.
Peirce osservava che ogni processo di semiosi ha una natura vaga o generale: ogni volta che evochiamo un segno, un representamen, insieme ad esso evochiamo una serie di interpretanti, cioè altri segni, che individuano in modo soggettivo l’oggetto di quel segno. La soggettività è data dal fatto che la memoria procedurale non evoca sempre gli stessi segni interpretanti. Facciamo un esempio. Quando diciamo la parola “tavolo”, nella nostra mente si affacciano immagini di altri tavoli perlopiù rispondenti a una idea generale che abbiamo e che categorizzano l’oggetto tavolo nella idea astratta che abbiamo di un tavolo. Ma questa idea è soggettiva sulla base della nostra memoria che si basa a sua volta sulla nostra esperienza. Le persone cioè possono avere altre idee di tavolo, mettiamo una idea astratta di un oggetto più alto, più piccolo, di altro colore, e così via. È su questa vaghezza o generalità della semiosi che si basa la “semiosi illimitata” del segno linguistico. Un classico letterario è “opera aperta” (Eco) in quanto non smette mai di produrre significati nel corso dello stesso tempo e dei tempi successivi. Ora, Fedeli ipotizza che la vaghezza o indeterminatezza del segno linguistico stia alla base anche del mutamento di una lingua. È certamente uno dei possibili fattori che fanno evolvere una lingua sia sincronicamente sia diacronicamente.
Noi possiamo parlare fondamentalmente in base a due aree cerebrali dell’emisfero sinistro: quella di Broca permette l’articolazione motoria, quella di Wernicke permette la comprensione (semantica). Ma queste scoperte del passato non sono sufficienti. Il linguaggio verbale è reso possibile da un insieme complesso di sistemi fisiologici e neurali (vie uditive e visive; vie motorie), la cui estensione va ben oltre le aree di Broca e di Wernicke dell’emisfero sinistro. Oggi grazie a sistemi sofisticati di analisi del cervello sappiamo che nel linguaggio verbale vengono coinvolti entrambi gli emisferi.
L’emisfero sinistro è coinvolto principalmente nelle abilità linguistiche (produzione di suoni, formazione di parole, formazione di frasi, comprensione) e prassiche (uso della penna, uso di gesti simbolici che accompagnano il parlato). L’emisfero destro è coinvolto maggiormente in compiti di elaborazione spaziale e percettiva, ad esempio la percezione di una melodia, di configurazioni non verbali e di relazioni spaziali. Recenti studi chiariscono che l’emisfero destro è chiamato in causa per l’elaborazione degli aspetti paralinguistici (tono di voce, gesti), prosodici, affettivi del linguaggio, per le caratteristiche semantiche di larga scala (non di singole parole), per descrizioni, aspetti narrativi, rappresentazioni simboliche, e così via. Mentre secondo la vulgata la differenza tra emisfero sinistro e emisfero destro è assoluta, in realtà gli studi dimostrano sempre meglio che pressoché in ogni funzione (e non solo il linguaggio verbale) le differenze non sono mai nette.
Oltre 100 muscoli esercitano un controllo durante la produzione delle onde sonore che trasportano il flusso della voce. Queste onde sono prodotte dalla interazione di tre elementi: il flusso d’aria che esce dai polmoni, le modificazioni di tale flusso all’altezza della laringe e ulteriori modificazioni tramite la lingua e altre parti (labbra, mascella, …).
I suoni non giungono alla nostra percezione come sono ma come li immaginiamo. È il fenomeno della percezione categoriale, per cui un suono ad esempio oscilla sempre tra DA e TA, non è mai lo stesso, ma entro certi valori lo percepiamo DA, mentre per valori più lunghi lo percepiamo TA.
Nella lettura succede qualche cosa di analogo. Nessuno di noi legge tutta una pagina né tutta una frase, ma solo alcune sezioni che la nostra mente completa mediante l’esperienza già acquisita. È per esempio il fenomeno della anteprima foveale, per cui i lettori sono in grado di ottenere informazioni utili alla comprensione del testo solamente da un’area ristretta dello stesso colta da quella piccola porzione di retina che sta attorno alla fovea, la zona retinica specializzata per la visione ad alta acuità.
Invece nella scrittura ci serviamo di aree muscolari e cerebrali non deputate solo per la scrittura, al contrario del sistema vocale che è specializzato solo per la funzione di emettere suoni. Inoltre il sistema per il controllo motorio dell’arto superiore è più integrato e localizzato rispetto al tratto vocale. La velocità media della scrittura tende ad aumentare o diminuire in proporzione alla grandezza delle lettere (principio di isocronia) e a seguire, modificandosi, i gradi di curvatura delle lettere che vengono tracciati, a parità di grado, con tempi simili (principio di isogonia).
Noi siamo in grado di riconoscere una parola, cioè una sequenza di lettere con senso compiuto, grazie a:
- Frequenza con cui le parole sono utilizzate;
- Loro pronunciabilità;
- Contesto: è il contesto che rende ragione di un fenomeno detto effetto di superiorità della parola, che fu osservato inizialmente da Reicher nel 1969. Reicher condusse un esperimento molto elegante nel quale misurava il tempo con cui si riconosceva una lettera in tre forme: singola lettera, parole di 4 lettere, non-parole sempre di 4 lettere. Per esempio la lettera D, la parola WORD e la non-parola ORWD. Dall’esperimento emerse che i partecipanti riconoscevano più velocemente la lettera critica quando stava entro la parola anziché la lettera isolata e la non-parola. Questo dimostra come il contesto influenzi grandemente la capacità di riconoscere i segni linguistici. Morton ha elaborato un modello di riconoscimento delle parole detto logogen, che è una sorta di vocabolario mentale che costituisce il contesto nel quale le parole sono allocate.
Quando per l’italiano usiamo la espressione “grammatica tradizionale” ci riferiamo all’insegnamento della lingua basato su analisi grammaticale, analisi logica e analisi del periodo, cioè riguardanti categorie e sottocategorie di diversa complessità delle quali si compone una lingua. Tuttavia da più parti si evidenzia che imparare una lingua in questa maniera fa focalizzare il discente su alcuni aspetti a volte marginali e fa dimenticare di riflettere su aspetti più importanti. Per esempio con la grammatica tradizionale non si presta attenzione adeguata a lessico e semantica; non si considera affatto le funzioni della lingua, per cui non si enuclea la differenza tra frasi del tipo “io compro il libro”, “il libro lo compro io”, “lo compro io, il libro”; non si pone riguardo a fenomeni che interessino strutture superiori alla frase o al periodo, come l’anafora o i connettivi testuali; e così via. I teorici della lingua quindi si pongono il problema di quale grammatica insegnare. Qual è la migliore?
Oltretutto la grammatica in sé serve per imparare una lingua? C’è anche da dire che ogni tipo di grammatica svolge la funzione di insegnare a scrivere e a parlare correttamente e con proprietà soltanto a un livello avanzato, diciamo con il diploma di scuola media superiore. Però tutto il lavoro che viene prima, dalle elementari alle scuole medie inferiori, serve a insegnare a far riflettere sulla lingua.
Oggi le neuroscienze forniscono un quadro sempre più completo, ma non definitivo, riguardo l’educazione in genere e anche quella linguistica. Le scienze dell’educazione beneficiano di questi nuovi apporti per svolgere una formazione migliore. Il nostro cervello funziona mediante i collegamenti tra i neuroni, che sono detti sinapsi. Ogni nuova esperienza si sedimenta nel nostro cervello mediante la sua memorizzazione, che vuol dire creazione di nuove sinapsi (teoria di Hebb). Si tratta in sostanza di un apprendimento, che dura tutta la vita. In ogni apprendimento, quello della vita e quello scolastico, si avvia un processo di selezione della informazione mediante l’attenzione: vuol dire che noi memorizziamo, quindi apprendiamo, determinate informazioni su cui si focalizza la nostra attenzione e scartiamo le altre. In questi diversi processi svolge un ruolo chiave il movimento. La nostra mente non sarebbe astratta ma incarnata nel corpo e nei suoi movimenti, quindi il buon apprendimento dovrebbe coniugare le lezioni teoriche con i movimenti del corpo, in modi molto variegati, per esempio tramite giochi di ruolo e sedute teatrali, che consentono di drammatizzare la nozione e di acquisire una esperienza più a largo spettro. I processi dell’apprendimento richiamati beneficiano anche della emozione: una informazione caricata di emozione è meglio memorizzabile. Non solo, ma si memorizza meglio mediante le immagini, quindi una lezione non dovrebbe essere una scaletta astratta bensì accompagnata da esempi concreti.
Anche l’apprendimento specificatamente linguistico beneficia dei risultati delle neuroscienze. Il nostro cervello è predisposto a creare sinapsi su base genetica ma sempre mediante esperienza appresa, ma anche sinapsi solo mediante l’esperienza appresa. Vale a dire che ci sono circuiti neurali più automatici, che si formano con un minimo di esperienza appresa, come il pianto del neonato che egli utilizza per chiedere qualcosa, mentre altri circuiti che necessitano di una maggiore esperienza perché non su base genetica. Secondo questa distinzione, ci sono “processi che attendono l’esperienza” (i quali attivano il potenziale genetico utilizzando informazioni ambientali largamente accessibili a tutti i membri della specie, come la capacità di ascoltare suoni linguistici distinguendoli da altri rumori) e “processi che dipendono dall’esperienza” (che fanno leva su informazioni ambientali che variano a seconda dei contesti). Quindi apprendere una lingua straniera in un contesto scolastico è un processo che dipende dall’esperienza, facendo leva su alcuni processi che attendono l’esperienza e che sono usati per imparare la lingua materna in famiglia (per esempio l’imitazione). Questi processi che dipendono dall’esperienza, cioè che sono insiti nell’ambiente e che devono essere potenziati dall’insegnate, si annoverano perlomeno: il grado di esposizione alla lingua straniera, l’opportunità del suo utilizzo in contesti significativi, la presenza di figure di riferimento che incoraggino l’uso della lingua straniera.
Chomsky ha introdotto il concetto di Grammatica Generativa, in base al quale le persone hanno un modello innato su base genetica-biologica mediante il quale apprendono la lingua madre. Lo stimolo ambientale è utile per avviare il processo, ma da solo non è sufficiente affinché la specie umana cominci a parlare. Chomsky scriveva che si tratta di una: “… teoria dei meccanismi innati, una matrice biologica sottostante che fornisce un quadro all’interno del quale si sviluppa la crescita della lingua”.
Studi recenti pongono attenzione alle basi neuroanatomiche dell’aspetto emotivo del linguaggio. Quando parliamo esprimiamo un aspetto razionale e un aspetto emotivo: il primo è costituito dal contenuto delle parole, il secondo dalla intonazione e dai movimenti che accompagnano l’eloquio. Una parola può avere un significato diverso sulla base del tono della voce con la quale la pronunciamo, esprimendo in questa maniera un aspetto emotivo ben diverso. Se diciamo a un amico “ti spacco la faccia” usiamo un tono diverso rispetto a quando lo diciamo a chi ci ruba il portafogli. Sembra che l’aspetto emotivo del linguaggio sia localizzato nell’emisfero destro e rispecchi le aree del linguaggio dell’emisfero sinistro, per cui una lesione a destra in corrispondenza dell’area di Wernicke produce un eloquio formalmente ineccepibile ma con deficit nella comprensione dell’aspetto emotivo. Quindi per parlare e capire correttamente sono importanti entrambi gli emisferi. Nell’insegnamento delle lingue straniere è stato proposto da Danesi un modello che stimola entrambi gli emisferi, alternando tecniche centrate sull’uno o sull’altro: l’emisfero destro è chiamato in causa con immagini e dialoghi e giochi (nei quali si esprime emotività), l’emisfero sinistro con la riflessione grammaticale e la traduzione.
L’apprendimento non è un processo lineare (accumulo di informazioni) ma circolare: ciò che si apprende prima costituisce la base per i successivi sviluppi innovandosi di volta in volta in un processo circolare. La memoria non è mai come aprire un cassetto, bensì una riconfigurazione della traccia precedente sulla base di quella successiva, e così via.
Quindi secondo Bateson esistono tre livelli di apprendimento: apprendimento zero (quando si raggiunge il massimo delle informazioni da immagazzinare, in questa maniera le altre non risultano pertinenti e si forma una abitudine); apprendimento di primo livello (quando si migliora la competenza iniziale, per esempio velocizzando l’esecuzione); apprendimento di secondo livello (quando l’apprendimento si applica a nuovi contesti). Nell’apprendimento esiste una gerarchia. Applicando questa gerarchia all’apprendimento di una lingua straniera, possiamo dire che il livello zero è il primo approccio alla lingua, fatto nella prima scuola; il livello uno è il perfezionamento della lingua, fatto nella seconda scuola; il livello due è l’acquisizione di una abilità ancora maggiore in un contesto più ampio, come nel trasferimento nel paese dove si parla comunemente la lingua appresa.
Secondo Mereu, ci sono tre risorse grammaticali (in cui il termine “grammaticale” va inteso in senso lato, diciamo dei sistemi linguistici) attestati nelle varie lingue del mondo per individuare chi fa che cosa, eventualmente, a chi; cioè per individuare le relazioni tra gli elementi della frase.
Non tutte le lingue del mondo usano gli stessi sistemi per queste relazioni. Si individuano tre sistemi e varie possibilità combinatorie:
- Il caso morfologico: è il sistema che si trova nelle lingue molto flessive, che hanno i casi;
- L’ordine sintattico: la sequenza/disposizione dei vari elementi indica qual è la loro funzione sintattica;
- L’accordo sul verbo (o flessione verbale): la forma verbale viene arricchita da una serie di suffissi, o comunque viene modificata, per esprimere le relazioni con gli altri elementi della frase.
Quando ci troviamo una frase davanti dobbiamo considerare alcuni elementi:
- Il livello prettamente formale, ed è il livello in cui individuiamo i costituenti che formano una frase. Ci può essere un sintagma nominale, preposizionale, aggettivale, verbale e frase;
- Il secondo livello è quello delle funzioni grammaticali/sintattiche: verbo, oggetto, soggetto, complemento diretto, una frase completiva (quindi complemento frasale);
- Il terzo livello è quello dei ruoli semantici: i costituenti partecipano all’evento messo in gioco dal verbo ognuno con un suo ruolo. Ognuno nella frase fa/è indicatore di qualcosa.
Il termine costituente nasce con lo strutturalismo statunitense, soprattutto con Bloomfield e quelli venuti dopo di lui, che, essendo dediti alla descrizione delle forme linguistiche, analizzavano quali erano gli elementi costitutivi della frase. Hanno elaborato una serie di test chiamati test di costituenza: sono una serie di processi applicabili a una frase grazie ai quali si possono individuare i costituenti.
Cosa vuol dire sintagma? È un elemento formato da più cose messe insieme: è un raggruppamento sintattico. All’incirca i sintagmi corrispondono ai costituenti. Il sintagma è un’unità di livello sintattico (unità della struttura frasale) costituita da una combinazione minima di parole (ma può essere formato anche da una sola parola, es. il sintagma verbale “mangia”). I sintagmi vengono spostati in blocco dalle regole di movimento e hanno una coesione interna.
Nella classificazione tradizionale abbiamo un soggetto, un predicato e una serie di complementi. Nella linguistica moderna il complemento oggetto si chiama oggetto diretto. Il complemento di termine si chiama oggetto indiretto o complemento indiretto. Qualsiasi complemento introdotto da preposizione che non abbia la funzione di oggetto indiretto è obliquo (“Maria ha mandato il fratello al cinema”).
Dal punto di vista del primo livello, nella frase “Il gatto mangia il topo”, “Il gatto” è un sintagma formato da articolo e sostantivo; dal punto di vista del secondo livello il soggetto è il sostantivo gatto.
Dal punto di vista del terzo livello, quando parliamo di semantica della frase parliamo della relazione strettissima che esiste tra piano sintattico e piano semantico, cioè del significato. Il ruolo semantico è il significato che ciascun partecipante all’evento o all’azione espressa dal verbo ricopre nella frase. Dobbiamo immaginare che la frase sia un evento, il quale si incentra sul verbo. Perché sia descritto un evento di senso compiuto ci devono essere una serie di partecipanti, ognuno col suo ruolo.
Tradizionalmente definiamo un verbo transitivo dal punto di vista:
- Semantico: è l’azione compiuta da un soggetto (Agente) che passa/transita sopra un complemento oggetto (oggetto diretto) che subisce l’azione. Una definizione semantica, però, restringe molto la classe di quello che possiamo chiamare effettivamente transitivo, perché non tutti i verbi transitivi hanno soggetti sintattici che sono Agenti.
- Sintattico: spostandoci sul versante sintattico/formale/grammaticale posiamo dire che i verbi transitivi sono quelli che hanno un complemento oggetto/oggetto diretto. Senza questo oggetto diretto non possono stare; le frasi sono agrammaticali. Di conseguenza, un verbo intransitivo non ammette un complemento oggetto.
Ci sono delle proprietà sintattiche delle frasi formalmente transitive che ci permettono di capire se si tratta di frasi transitive vere e proprie. Queste proprietà sintattiche le usiamo come test diagnostici. Il test più ovvio per le frasi transitive vere e proprie è il test della passivizzazione: solo una frase veramente transitiva può assumere forma passiva,
- L’idraulico aggiusta il tubo / Il tubo è stato aggiustato (dall’idraulico) = frase transitiva.
Vediamo che ci sono strutture apparentemente transitive che non possono essere volte al passivo:
- Il libro costa 10 euro / *10 euro sono costati dal libro
- La pizza pesa 3 etti / *3 etti sono pesati dalla pizza.
Questo significa che non si tratta di vere frasi transitive. Inoltre, anche dal punto di vista della semantica, siamo ben lontani dall’azione che transita da un Agente su un Paziente (pizza e libro poi sono Temi, neanche Agenti).
Anche quella dei verbi intransitivi è una classe organizzata in modo prototipico. Infatti, non tutti i verbi intransitivi sono uguali: si parte da uno schema base, che assumiamo essere quello più caratteristico di un verbo intransitivo, per poi a poco a poco allontanarci da questo centro di intransitività e andare verso l’area della transitività. Immaginiamo una scala con due estremi: da una parte abbiamo ciò che è prototipicamente transitivo, dall’altra ciò che è prototipicamente intransitivo, sia a livello semantico che a livello sintattico.
I verbi intransitivi si distinguono in inergativi e inaccusativi: all’interno della classe dei verbi intransitivi c’è questa divisione riconosciuta in modo concorde dagli studiosi, ma c’è da tenere conto che questi due grossi sottogruppi non si manifestano nello stesso modo nelle varie lingue del mondo.
Verbi inergativi: es. lavorare, camminare, ridere. Comportamento sintattico: il soggetto ha le proprietà sintattiche tipiche del soggetto dei verbi transitivi. Comportamento semantico: in qualche modo si avvicina all’Agente tipico di un verbo transitivo, ma non del tutto. Quindi eserciterà spesso un controllo sull’azione, che compie in modo intenzionale.
Verbi inaccusativi: es. arrivare, cadere, scoppiare, affondare;. Comportamento sintattico: il soggetto è caratterizzato da proprietà sintattiche tipiche dell’oggetto dei verbi transitivi. Comportamento semantico: il soggetto ha caratteristiche semantiche più simili al Paziente.
A livello formale, i due gruppi sono distinti dall’ausiliare:
- Gli inergativi hanno avere (es. Mario ha lavorato, riso, dormito, ecc.)
- Gli inaccusativi essere (es. Mario è arrivato, caduto, sparito, ecc.). Gli inaccusativi comprendono anche i verbi pronominali (pentirsi, ammalarsi, commuoversi), dove il pronome è un elemento obbligatorio nella flessione: in questi casi, infatti, l’ausiliare è sempre essere. Nel passivo: troviamo sempre l’ausiliare essere + il soggetto è ovviamente più simile a un Paziente che a un Agente = corrisponde alle caratteristiche che abbiamo dato di verbi inaccusativi. Nell’ambito delle lingue romanze, l’italiano è ricchissimo di verbi inaccusativi. I soggetti dei verbi inaccusativi condividono caratteristiche sintattiche (quindi formali) con gli oggetti diretti di verbi transitivi. Ci sono tantissimi test che si possono fare, qui ne vediamo alcuni; comunque, questi test non funzionano in tutte le lingue per le stesse categorie di verbi. Sostituzione con ‘ne’ partitivo possibile nei verbi inaccusativi ma non in quelli inergativi: es. Mario ha mangiato molti panini / ne ha mangiati molti; Sono arrivati molti panini / ne sono arrivati molti; Mario ride spesso / ne ride spesso. I verbi inaccusativi possono avere il soggetto dopo il verbo, proprio in costruzioni non marcate, mentre gli inergativi no (molto discussa dagli studiosi): Sono arrivati i libri; Sono partiti tutti; È morto il bisnonno; *hanno dormito i bambini
Differenze tra inergativi e inaccusativi a livello semantico:
- Per quanto riguarda gli aspetti semantici, nella letteratura sull’argomento (Van Valin 1990; Levin e Rappaport Hovav 1995) si osserva che i verbi intransitivi esprimono una gamma eterogenea di eventi. Però, esistono correlazioni tra proprietà semantiche e le caratteristiche azionali e le classi di verbi intransitivi.
- I verbi inergativi esprimono prevalentemente attività intenzionali del soggetto, però (e questo è l’aspetto interessante) possono anche esprimere funzioni o reazioni corporee non propriamente controllate, colte nel loro procedere es. dormire, respirare, piangere, ridere, russare.
- I verbi inaccusativi sono tipicamente verbi che esprimono: Un cambiamento di stato del referente del soggetto, es. cadere, guarire, sparire, morire. Questi verbi implicano mancanza di intenzionalità del soggetto. Un cambiamento di posizione a seguito di un moto direzionato (qui c’è l’intenzionalità, ma in questo caso non è il controllo il tratto semantico che fa sì che questi verbi abbiano una costruzione di tipo inaccusativo, ma è il fatto che il soggetto comunque non è agentivo perché si caratterizza più come Tema), es. arrivare, entrare, fuggire. Uno stato, es. restare, rimanere. In uno stato non abbiamo il cambiamento che caratterizza un Paziente.
Passiamo ora a una proposta teorica detta Grammatica delle costruzioni. Nasce nell’ambito della Linguistica cognitiva, perché Fillmore, insieme a Kay e O’Connor, ha pubblicato negli anni Ottanta un saggio molto famoso sulle espressioni idiomatiche, che sono centrali per la Grammatica delle costruzioni (in inglese si chiamano idioms). Da lì quindi è partito questo grosso impeto di studi che ha visto però tanti approcci diversi (si riconoscono almeno cinque diversi indirizzi della Construction Grammar e adesso ci sono persino i neo-costruzionisti). Hilpert (2014), uno dei grandi studiosi della Construction Grammar, afferma che la Grammatica delle costruzioni (GC) non è tanto un modello di grammatica, ma piuttosto un’area vasta di possibilità teoriche proposte in successioni negli ultimi vent’anni in varie parti della grammatica di una lingua.
Tra i vari approcci, a noi qui interessa soprattutto quello che è stato sviluppato da Adele Goldberg, che ha pubblicato due monografie fondamentali: nel 1995 (Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure) e nel 2006 (Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language).
La cosa importante che dobbiamo ricordare è che con la Construction Grammar, ma in realtà già da prima con la Semantica dei frame e la Linguistica cognitiva, il verbo e i suoi argomenti (o comunque i costituenti che co-occorrono con un verbo in un enunciato) sono considerati nella prospettiva dell’uso, della contestualizzazione e della concettualizzazione che ne fa il parlante.
L’approccio costruzionista non è più proiezionista: nel momento in cui il verbo viene attualizzato ed entra a far parte di una costruzione, è la costruzione che contribuisce al determinarsi della semantica del verbo (e quindi anche alla particolare struttura argomentale). Quindi non è più il verbo che proietta, ma è nella costruzione in cui si inserisce il verbo che si determina la semantica verbale e quindi la struttura argomentale.
Goldberg all’inizio fa quello che avevano fatto Fillmore e O’Connor, cioè ha interesse per le costruzioni idiomatiche, poiché queste hanno un significato di tipo non composizionale. Per esempio, “Ada ha vuotato il sacco” nel senso di “Ada ha detto cose che non avrebbe dovuto dire”: se sommiamo i singoli elementi non arriviamo a questo significato, quindi non è di tipo composizionale, ma figurato. Invece, “il computer è sopra la scrivania” ha un significato di tipo composizionale perché risulta dalla somma dei singoli elementi che costituiscono questa frase.
Secondo Goldberg c’è una costruzione se e solo se c’è una coppia forma-significato tale che qualche aspetto della forma o qualche aspetto del significato, non è strettamente prevedibile dalle parti componenti o da altre costruzioni precedentemente stabilite.
All’inizio, come costruzione si intendeva una struttura argomentale che si manifestava in un’espressione idiomatica tale che dal significato e della forma c’era qualcosa che non rispondeva alla normalità della lingua e il significato non era prevedibile composizionalmente, come abbiamo visto nella espressione idiomatica. Goldberg (così come la Construction Grammar) parte dallo studio delle espressioni idiomatiche, ma poi la studiosa non considererà più costruzioni soltanto quelle idiomatiche, ma qualsiasi coppia convenzionalizzata di forma e significato.
“Una coppia convenzionalizzata di forma e significato” vuol dire che a forza di ripetersi nell’uso dei parlanti quell’associazione di funzione e significato, si è convenzionalizzata, cioè si è radicata nelle menti dei parlanti di una stessa comunità linguistica. Ha acquisito lo status di costruzione vera e propria e non di occorrenza casuale.
Quindi sono degli schemi che si vengono a immagazzinare come costruzioni anche se sono totalmente prevedibili nella misura in cui occorrano con frequenza sufficiente.
Non importa più che siano prevedibili o meno, l’imprevedibilità fa riferimento alla caratteristica delle espressioni idiomatiche e non è più importante, possono essere anche prevedibili. La loro semantica può essere di tipo composizionale, la loro forma può non presentare delle deviazioni: quello che conta è che siano convenzionalizzate; così frequenti da creare nella nostra mente schemi che prevedono, nelle costruzioni/strutture argomentali, l’associazione di una forma e di un significato. Anche le strutture base, quindi, sono costruzioni, e come tali vengono analizzate da questi studiosi.
Un altro approccio interessante è quello di Perek perché più di tutti mette in luce la componente uso e frequenza d’uso, infatti si dice che è un approccio usagebased (cioè “basato sull’uso”). Questo tipo di fenomeni può essere analizzato grazie ai corpora linguistici: i corpora sono raccolte di testi che possono essere orali o scritti, di epoche differenti, e i lemmi al loro interno sono descritti con un linguaggio semantico ontologico particolare. La linguistica dei corpora raccoglie i testi del parlato e sono quelli più interessanti perché non solo danno uno spaccato della lingua viva, ma anche della sua variabilità.
La sua opera è del 2015: Argument Structure in Usage-Based Construction Grammar. Sono quattro principi di base:
- Possibile uso creativo dei verbi da parte dei parlanti: è possibile che i parlanti, in base alle loro esigenze di comunicazione (sempre attingendo al frame di base), combinino l’uno o l’altro elemento.
- Le costruzioni possono selezionare un sottoinsieme di argomenti del verbo, o possono contribuire loro stesse ad aumentare il numero degli argomenti: un verbo ha una sua costruzione canonica, ma può avere anche altre possibilità.
- La frequenza d’uso dipende dalla loro frequenza di occorrenza e dell’immagazzinamento di un ampio numero di esemplari nella mente dell’utente di una lingua: tanto più una costruzione sarà frequente, tanto più verrà a radicarsi nella nostra mente, tanto più la useremo.
- Un verbo può combinarsi con una costruzione in due modi: o in base a una compatibilità inerente (il significato del verbo elabora il significato della costruzione: la costruzione non aggiunge nulla alla semantica del verbo, c’è un incastro perfetto che non comporta un arricchimento di alcun tipo) oppure in base a un arricchimento semantico (il significato del verbo è direttamente portato dalla costruzione: il significato del verbo si amplia/arricchisce grazie al significato che viene portato dalla costruzione. È la costruzione ad apportare al significato del verbo una nuova componente semantica).
Le varie lingue del mondo adottano molte risorse originali e uniche accanto a espedienti che sembrano ripetersi in più lingue.
Per esempio, l’infinito compare in molte lingue. In italiano, l’infinito si forma aggiungendo il morfo -re al tema (am-a-re, ved-e-re, sent-i-re). Questo morfo -re, dal proto-latino *-si, anticamente aveva una funzione locativa (“nell’amare”, “nel vedere”, “nel sentire”): quando dunque diciamo “voglio sentire”, intendiamo: “la mia volontà (= voglio) (è) nel sentire (= sentire)”. Conseguentemente, l’infinito serve a trasformare un predicato verbale in un complemento, cioè un verbo in un nome. In questo modo, il verbo può comportarsi come un nome e ricevere tutte le preposizioni che i nomi ricevono, svolgendo tutte le funzioni che i nomi possono svolgere in una frase: soggetto, “mi piace andare al mare”, oggetto, “voglio andare al mare”, moto a luogo, “vado a dormire”, fine, “scrivo per chiedere un’informazione”, limitazione, “bello da vedere”, comparazione, “come bere un bicchier d’acqua”, specificazione, “paura di volare”, etc. Tutte queste subordinate rette dall’infinito vengono chiamate “implicite”, al pari di qualsiasi subordinata retta da un modo indefinito (participio, congiuntivo, infinito). Se non esistesse l’infinito, tutti questi significati andrebbero espressi tramite proposizioni subordinate che sfrutterebbero modi finiti (indicativo o congiuntivo), ossia “esplicite”: “mi piace che io vada al mare”, “voglio che io vada al mare”, “vado laddove io possa dormire”, “scrivo affinché io chieda un’informazione”, “bello nella misura in cui lo si vede”, “come quando si beve un bicchier d’acqua”, “paura mentre si vola”, etc., rendendone l’enunciazione notevolmente più complicata. In italiano, questa seconda opzione diventa obbligatoria quando il soggetto del verbo reggente non è più lo stesso del verbo subordinato: “voglio dormire” (io voglio, io dormo), ma “voglio che tu dorma” (io voglio, tu dormi), “chiedo per sapere” (io chiedo, io so), ma “te lo dico perché tu lo sappia” (io dico, tu sai), e così via. In altri termini, la costruzione implicita è possibile, e in certi casi obbligatoria, in identità di soggetto, mentre la costruzione esplicita è obbligatoria in caso di mancata identità di soggetto – mentre fanno eccezione i verbi iussivi, cioè quelli che prevedono una qualsiasi forma di comando, col destinatario del comando al dativo: “le ho detto di farsi i fatti suoi”, “gli ho chiesto di chiamarmi”, “ti ordino di tacere”, etc., e il verbi causativi: “l’ho fatto venire”, “l’ho lasciato parlare” etc. – anche se in questi ultimi è possibile, per quanto meno frequente, la costruzione esplicita: “ho fatto sì che venisse”, “ho lasciato che parlasse”.
Ci siamo mai chiesti quale sia il ruolo del sostantivo? Il sostantivo è il nucleo del sintagma nominale e dunque costituisce il fulcro del complemento (soggetto, oggetto, termine, specificazione etc). I complementi, o sintagmi nominali, orbitano attorno ai verbi specificando i partecipanti dell’azione. Nella frase “il servo mangia fichi sotto il sicomoro”, i complementi o “attanti” sono “il servo” come soggetto, “fichi” come oggetto e “sicomoro” come complemento di stato in luogo, indicando che il “mangiare” è compiuto dal servo nei confronti dei fichi in un luogo situato sotto il sicomoro. Gli aggettivi fungono da modificatori del sintagma nominale: nella frase “il vecchio servo mangia dolci fichi sotto il grande sicomoro”, “vecchio”, “dolci” e “grande” sono qualità dei sostantivi presenti nella proposizione, cosicché sono concordati con quei sostantivi nei due parametri del nome italiano, ossia il genere (maschile o femminile) e il numero (singolare o plurale). In italiano, il nome e l’aggettivo conoscono quattro classi nominali o “declinazione”: classe A o “prima declinazione”, femminile (“la porta, le porte”), e maschile (“il tassista, i tassisti”), classe O o “seconda declinazione”, maschile-femminile (“il lupo, i lupi”, “la mano, le mani”), e neutra (“il ciglio, le ciglia”), classe E (“il cane, i cani”), classe 0, ossia dei nomi identici al singolare e al plurale e in cui rientrano i sostantivi tronchi e i forestierismi (“il re, i re”, “il bar, i bar”). Gli aggettivi o seguono la classe A per il femminile (“bella, belle”), la classe O per il maschile (“bello, belli”) e la classe O nel singolare neutro (“lungo ciglio”) e la classe A femminile nel plurale neutro (“lunghe ciglia”), oppure seguono indistintamente la classe E (“fedele amico/a, fedeli amici/he”).
Facendo un collegamento con un’altra lingua, in egiziano antico, il nome e l’aggettivo si comportano allo stesso modo, ma non sono distinti per classi nominali. La radice non possiede dunque una vocale tematica (non come nell’italiano lup-a-, lup-o-, can-e-), ma si annette direttamente ai morfi del maschile, del femminile, del plurale e del duale.
In egiziano antico, la radice nella sua forma non modificata vale come singolare maschile: bAk, “servo”, copto bok, da una forma non attestata *bà’ik. Nelle lingue imparentate più prossime, a questo punto si trova una desinenza di caso, /u/ per il nominativo, /a/ per l’accusativo e /i/ per il genitivo e per tutte le forme con preposizione: accadico sharru, “il re (sogg.)”, sharra, “il re (ogg.)”, sharri, “del re”, itti sharri, “col re”, etc. L’egiziano non scrive le vocali, quindi non abbiamo prove dirette che esso conservasse queste desinenze di caso nelle forme assolute, cioè quando il nome era da solo. Tuttavia, quando al nome segue un pronome enclitico, che fa in modo che la vocale finale del sostantivo non sia più finale, osserviamo in copto una /e/ o una /a/, entrambi risultati copti di una /i/ in egiziano, che sarebbe appunto la -i- del genitivo-preposizionale: ehrà=k, “sopra di te”, cioè r-Hr=k, “verso il tuo volto”, *ura-Harì=ka, ehrè=ten, “sopra di voi”, r-Hr=Tn, *ura-Harì=ciunu. Dunque, è probabile che, almeno all’inizio, si avesse una forma *bà’iku, “servo (sogg.)”, *bà’ika, “servo (ogg.)”, *bà’iki, “del servo”. Con la caduta delle vocali brevi finali, si ebbe un’unica forma *bà’ik indistinta per caso. Quando però si aggiungeva un pronome enclitico, questo caso riemergeva: *bà’iku=k, “il tuo servo (sogg.)”, *bà’ika=k, “il tuo servo (ogg.)”, *bà’iki=k, “del tuo servo”. Quando infine tutte le vocali non toniche si centralizzarono in schewà, anche in questo caso la differenza si neutralizzò: *bà’eke=k, “il tuo servo”, sopravvivendo solo in quei casi dove, per motivi prosodici, l’accento finiva sull’antica desinenza di caso, come nell’esempio di ehrà=k.
Sempre in egiziano antico, aggiungendo alla radice il morfo pluralizzante -w-, scritto con le tre linee del plurale dopo il determinativo del nome, si ottiene il plurale: bAk.w, “servi”. Questo morfo .w era pronunciato /u/, come sappiamo dalle lingue imparentate (-uu è il plurale in accadico, -ùùn è il plurale in arabo) e dai casi in cui sopravvive in copto (tò, “terra”, tòu, “terre”). Alle origini del sistema di scrittura geroglifica, i plurali si scrivevano triplicando l’ideogramma. Alcuni plurali di sostantivi molto antichi e sacri mantengono questa forma: il plurale “dei”, in egiziano neter.w, si scrive triplicando il segno che indica il dio, cioè un’asta con una bandiera.
Se alle forme viste finora si aggiunge un morfo femminilizzante -t-, si ottiene il femminile corrispondente: bAk.t, “serva”, copto bòki (da una forma non attestata *ba’àkat), bAk.wt, “serve”. In copto, questa desinenza perde la /t/ finale, mentre la vocale finale, a seconda del dialetto, si presenta come schewa o come /i/, ma ciò non ci dice nulla sulla vocalizzazione originale, a causa della centralizzazione. Più utili a questo fine sono le lingue imparentate, dove appunto questa vocale si presenta come /a/: in arabo abbiamo kààtib-, “scrittore”, kààtibat-, “scrittrice”, in accadico shàrr-, “re”, shàrrat-, “regina”, etc. Questa /a/ sopravvive in trascrizioni greche di nomi egiziani, ad esempio la città di tA-nTr.t, “quella della Dea, è trascritta come Tenthyra, e in arabo Dendàra: *ti’-naciàrat. Tuttavia, se la radice termina in /j/, questa /j/ può assorbire la /a/ e diventare /i/: in egiziano antico p.t, “cielo” si è poi evoluto nella forma non attestata *pìjat , quindi si è semplificato in *pit, che alla fine ha dato luogo alla forma copta: pe.
Nel plurale femminile, la -w- del plurale era pronunciata /aw/, come possiamo capire dal copto rempòwe, “anni”, egiziano rnp.wt attraverso una forma *ranpàwat.
Ricordiamo che il copto è la fase finale dell’egiziano antico. La lingua egiziana sopravvive 5000 anni, fino ai nostri giorni con il copto. Quando si parla di “egiziano antico” si fa riferimento alle fasi precedenti il copto, e corrisponde soprattutto al medio egiziano, considerato l’egiziano classico.
Come abbiamo visto le lingue sono spesso imparentate tra loro. L’egiziano antico viene considerato da alcuni una lingua isolata, come il sumerico o l’etrusco, cioè senza parentela, mentre da altri viene accostata alle lingue afroasiatiche, come accadico, arabo, ebraico e così’ via. Invece l’italiano è una lingua indoeuropea che deriva dal latino: le lingue che derivano dal latino sono dette romanze, come il francese e lo spagnolo. L’inglese è un’altra lingua indoeuropea ma che non deriva dal latino, appartiene infatti al ceppo indoeuropeo germanico, come il tedesco.
Il latino che oggi studiamo nelle scuole è il latino cosiddetto classico o letterario, probabilmente diverso da quello parlato quotidianamente dai romani. Oggi si discute se vi fosse, entro questo tipo di latino classico, anche una lingua tipica della poesia.
È veramente possibile parlare di una lingua poetica romana? Come si deve intendere questo concetto? Della lingua dei poeti va detto, più che di qualunque altro tipo di lingua, che essa è estremamente soggettiva. Non è tanto comunicazione quanto piuttosto espressione. Il suo scopo non è tanto quello di essere comprensibile, quanto invece quello di suscitare un’impressione di bellezza. Il poeta è costretto ad attenersi fino a un certo punto alla consuetudine dominante costruita dalla lingua dell’uso. Ma d’altra parte è proprio dal comune e dal quotidiano che egli deve rifuggire, per far convergere tanto più intensamente l’attenzione del suo pubblico sui pensieri e sulle immagini espresse.
La lingua dei poeti si presta a una considerazione diacronica? Questa lingua si adatta a uno schema storico? Nessuno negherà che nella lingua poetica la parte dell’espressione individuale e soggettiva è molto grande. Questo però è solo un aspetto del problema. È possibile e necessario considerare la lingua poetica anche da un altro punto di vista, non soltanto come ‘parole’, ma anche come ‘langue’, non soltanto come ‘linguaggio’, ma anche come ‘lingua’. Il fattore centrale nel costituirsi delle lingue poetiche è la imitatio. Dove questo fattore è più attivo, più chiaramente si porranno in evidenza anche le caratteristiche essenziali della lingua poetica collettiva. Questo è senza dubbio il caso della poesia epica, perché qui il poeta si nasconde al massimo dietro la sua materia, e in tal modo la forza della tradizione si fa sentire con la massima intensità. La tradizione gioca un ruolo estremamente importante in tutto il campo dell’espressione artistica antica. Nella poesia questo si rivela nel fatto che dagli antichi poeti i loro più recenti imitatori riprendono in candida innocenza particolari psicologici e drammatici, immagini poetiche e similitudini, e così pure determinati elementi linguistici, anzi intere formule e persino frasi.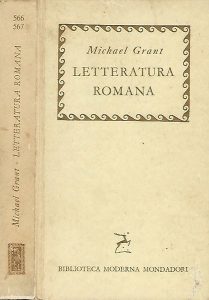
La imitatio non era una colpa, ma una legge. L’effetto della tradizione non si limita all’imitazione di precedenti autori latini. Sia Virgilio che Ennio attingono a modelli greci e in particolare a Omero. Questi è il grande modello anche dei poeti romani; anche a Roma egli veniva letto nelle scuole. Senza voler far torto al merito proprio della letteratura romana, si può affermare con sicurezza che essa è dipendente da quella greca in tutti i punti essenziali. L’influsso greco penetrò nel mondo letterario romano per varie vie. In primo luogo attraverso la lettura, la traduzione e la rielaborazione dei prodotti della poesia greca antica, soprattutto di Omero, ma accanto a lui anche di Esiodo e dei tragici. La sua principale caratteristica è che essa porta testimonianza di una tradizione vecchia di parecchie generazioni, per cui si spiega la presenza di arcaismi nel lessico. Di non minore importanza è la sua seconda caratteristica, quella di collocarsi al di sopra dei dialetti locali. È certo che la lingua dei poemi omerici contiene suoni e forme che indubbiamente non sono mai stati in uso nella lingua parlata. Arcaismi, glosse, forme linguistiche artificiali sono le caratteristiche essenziali della più antica lingua poetica greca. Possiamo ancora aggiungere l’uso frequente di parole composte. Un secondo focolaio che irradiò a Roma le tradizioni della poesia greca fu costituito dalle opere dei poeti alessandrini. I principali esponenti di questa corrente erano, come i loro seguaci romani, oltre che poeti anche eruditi. Come tali essi facevano uno studio accurato dei modelli dei loro predecessori. È importante osservare che i poeti romani arcaici Livio Andronico, Ennio, Lucilio, Accio e altri furono al tempo stesso grammatici, che accanto alle loro creazioni artistiche scrissero anche opere teoriche e insegnarono la teoria nella pratica. Il principale maestro dei Greci e dei Romani è Aristotele, che, come risulta evidente dai suoi esempi, a sua volta opera con i dati tratti dall’antica poesia greca, specialmente da Omero e i tragici. A Roma furono conosciute in maniera diretta solo tardi.
In poesia, e nel modo più univoco nella lirica, contenuto e forma sono reciprocamente compenetrati e indissolubilmente intrecciati; l’opera poetica ci appare come qualcosa di unico, e la forma linguistica, conformemente, come creazione e realizzazione di un poeta individuale. Con l’espressione ‘lingua poetica’ invece non si intende qualcosa di individuale, e neppure la somma di forme linguistiche individuali di un poeta, ma piuttosto un possesso linguistico collettivo.
A questi due orientamenti metodologici, rivolti all’individuale e al collettivo, corrispondono le due posizioni essenziali di fronte al problema base circa la funzione della lingua: l’una la concepisce come espressione, l’altra come comunicazione; unendo l’una e l’altra si parla della funzione espressiva e comunicativa della lingua.
La lingua poetica è un rampollo laterale sull’albero della lingua, essa conduce una esistenza speciale con tradizione propria. E in modo del tutto particolare questo vale nell’antichità. Poiché nelle letterature antiche due principi soprattutto vigono e sono coscientemente seguiti: quello della costanza della forma linguistica all’interno dei generi letterari e quello dell’accettazione di modelli; in forza di quest’ultimo l’imitatio vale non come vizio o divieto, ma come virtù e diritto, anzi addirittura come legge.
Lingua poetica latina è dunque la lingua dei poeti augustei e dei loro successori; si può già aggiungere anche la lingua del neotero Catullo, almeno nei suoi carmi maggiori. Il sorgere, l’esistenza e lo sviluppo di una lingua poetica è in greco un effetto di tradizione letteraria, dell’imitazione di modelli. In latino non può essere stato altrimenti. L’avvenimento più importante per la lingua poetica latina fu incontestabilmente l’opera di Ennio (239-169 a.C.), quando per il suo epos nazionale romano degli Annali riprodusse in latino l’esametro omerico. Così possiamo ora delineare approssimativamente gli inizi della lingua poetica latina. Per il verso e la conformazione linguistica il creatore è Ennio con i suoi Annali; il naufragio di quest’opera, il cui posto nella cultura romana toccò più tardi l’Eneide di Virgilio, è una delle perdite più gravi nell’ambito della letteratura romana. Inoltre ha molto contribuito allo stile sublime e al lessico poetico dell’epos anche la tragedia latina arcaica, da Ennio in poi.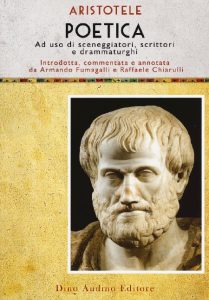
Lingua poetica e lingua prosastica, dopo che tutte due hanno trova la loro norma specifica e la loro forma classica, sono separate da un largo fossato; tuttavia non per lungo tempo. Appena giunta alla perfezione, la lingua poetica da parte sua mise a disposizione di tutti gli interessati i suoi pregi e i suoi ornamenti per un loro proprio libero impiego. E a questi suoi interessati appartengono subito alcuni prosatori: come uno dei segni distintivi della latinità argentea si indica proprio l’affluire di parole e forme di espressione poetiche nella prosa. Al poeta è concessa una maggiore libertà di espressione linguistica che non all’oratore; questo rilevano Cicerone e Varrone già prima dell’esistenza di una lingua poetica latina classica. Il loro primo sforzo è quello di rendere la lingua più elevata con le loro variazioni delle forme di espressione, a cui è posto un limite assoluto solo nell’esigenza della comprensibilità. Nel lessico servono a questo intento le parole rare, che se non sono mai dialettali come in greco, sono però arcaiche e solenni, tratte per esempio dalla lingua religiosa, poi metafore, infine neoformazioni poetiche. I poeti cercano di suscitare tensione per mezzo dell’insolito, così come ne facevano esperienza nei modelli greci; al contenuto non ordinario deve corrispondere una forma straordinaria.
Oggi siamo passati da una forma straordinaria a un uso “deterritorializzato” della lingua. È questa la tesi di Deleuze e Guattari. La vera letteratura “controeffettua” il linguaggio, lo trasforma da mezzo a fine, da simbolo da interpretare a semplice letterarietà da esperire, cosa che lo rende idoneo a far sì che il linguaggio esprima un piano della vita che non sia semplice imitazione. Per i due autori un mirabile esempio di questo uso del linguaggio è l’opera di Kafka. Kafka passa da un piano individuale del linguaggio verbale a un piano collettivo. Kafka fa un uso originale di una lingua così da variarla e forzarla. Quando Kafka usa il tedesco mette in pratica una “defunzionalizzazione” di questa lingua allargandola al collettivo: usa frasi influenzate dal ceco che appaiono zoppe e presenta un vocabolario scarno e prosciugato.
La parola può essere studiata anche da un punto di vista filologico, che vuol dire entro il testo e lo stile di un autore. Chi sono gli scrittori più importanti dell’umanità? Fare queste classifiche è sempre problematico per via dei giusti parametri da considerare.
Il libro più letto al mondo è la Bibbia, che secondo il canone cattolico è costituita di 73 libri (46 l’Antico Testamento, 27 il Nuovo Testamento). È scritta in ebraico biblico, aramaico biblico e greco biblico. L’Antico Testamento soprattutto in ebraico, con sezioni in aramaico e alcuni libri in greco, mentre il Nuovo Testamento ci è giunto tutto in greco. È stata composta in un arco temporale che va dal X secolo a. C al I secolo d.C. L’Antico testamento è stato composto in tutto il I millennio a. C., invece il Nuovo entro il I secolo d. C.
Omero invece è il primo scrittore della letteratura occidentale con l’Iliade. I due poemi omerici (Iliade e Odissea) sono scritti in un greco arcaico che fonde vari dialetti (una base ionica con tratti eolici e tardi atticismi). Secondo alcuni Omero si collocherebbe nel VIII secolo a. C.
Dante (1265-1321) è il poeta che ha posto le basi della lingua italiana, che si fonda sul dialetto toscano. La Divina Commedia è intrisa di spiritualità cristiana: le sue fonti principali sono la Bibbia e Alberto Magno. Ha anche un forte afflato classico. Oggi si confronta la Divina Commedia persino con l’escatologia arabo-spagnola e con lo sciamanesimo. Il viaggio sciamanico, per cui l’anima del mago stregone lascia temporaneamente il corpo e va nei vari luoghi dell’oltretomba, sarebbe alla base della grande opera di Dante. Jorge Luis Borges ha scritto: “Leggendo Dante, scivolo in un tempo senza tempo, e la mia immaginazione — impercettibilmente, a momenti — coglie l’eterno. Forse significa che l’Eterno esiste. Questa elegante speranza rallegra la mia solitudine. Cogliere l’eterno, penetrare in un tempo senza tempo: ecco la risposta alla domanda Perché leggere la Divina Commedia?. Può valere anche per noi”.
Shakespeare (1564-1616) dedicò tutta la sua vita al teatro, con l’eccezione di alcune sporadiche, splendide escursioni nella poesia. È considerato uno dei massimi scrittori di ogni tempo, anche se alcuni contemporanei definivano le sue opere silly, “sciocche”. Tuttavia Shakespeare godette di grande fama già in vita, secondo solamente, nell’opinione dei contemporanei, al rivale ben Jonson, considerato più colto, raffinato e misurato. Shakespeare è considerato oggi il massimo esponente del teatro elisabettiano e del teatro di tutti i tempi e luoghi.
Nel vasto canone dei quaranta testi teatrali pervenuti e nei sonetti Shakespeare studia la natura umana nei suoi limiti e nelle sue inclinazioni in un repertorio di temi e motivi versatile e poliedrico.
L’esperienza del teatro elisabettiano era costituita da una scena convenzionale, spoglia di ogni arredo superfluo, ma articolata secondo un dispositivo architettonico che prevede aree diverse per il gioco dell’attore (il palcoscenico, la scena interna, le porte, il balcone) e che senza rappresentare direttamente alcun luogo è in grado di evocare le situazioni previste nel testo.
In Shakespeare è presente una propria scenografia verbale, basta più sulla descrizione del testo che non sul luogo fisico del teatro. D’Amico passa in rassegna i geniali espedienti con cui Shakespeare maturo si serve per collocare una scena:
- Luoghi chiamati col loro nome geografico o topografico (II Enrico VI);
- Ripetizione ossessiva di un nome di una località (Tito Andronico. Riccardo III);
- Scena immaginaria che contiene un commento divino a quanto accade (Racconto d’inverno);
- Stesso ambiente mostrato in modo diverso a seconda dello stato d’animo dei personaggi (Riccardo III, Re Giovanni, I Enrico IV, Giulio Cesare, Livio Andronico);
- Ambienti la cui presenza fornisce lo spunto per considerazioni di vario carattere (Riccardo II, II Enrico IV);
- Apostrofi a luna, sole;
- Descrizione di nuvole (Amleto, Antonio e Cleopatra);
- Rapporto simbolico tra scena e avvenimento (II Enrico VI, III Enrico VI, Giulio Cesare, Troilo e Cressida, Antonio e Cleopatra, Misura per Misura); e così via.
Oggi è stata rivisitata la figura e l’opera di Shakespeare. Non è soltanto il grande poeta universale da porre accanto a Dante, Goethe, Cervantes o Rabelais, e non è soltanto il bardo della nazione inglese. Oggi si studia la sua opera come una meravigliosa produzione di teatro, come rilevava nel 1968 uno dei maggiori critici shakespeariani, Muriel Bradbrook. Il teatro elisabettiano serviva certamente la Corte ma era anche l’unico mezzo di intrattenimento disponibile su larga scala, ciò rendeva quegli scrittori, primo fra tutti Shakespeare, uomini attivi entro la vita sociale del tempo.
Anche se il cosiddetto teatro elisabettiano non fu una esperienza univoca. Ci riferiamo al periodo tra il 1570-1590 (quando furono costruiti a Londra i primi edifici adibiti esclusivamente alle rappresentazioni teatrali) e il 1642 (quando il Parlamento puritano decise la chiusura dei teatri). In realtà in quel lasso di tempo vi furono almeno due fasi: fino al 1603 (cioè fino alla morte di Elisabetta I), e poi gli anni a venire. Certamente la transizione tra i due periodi non fu brusca, prova ne sia che Shakespeare, che fu attivo a cavallo delle due fasi (dal 1590 al 1616) si colloca come esponente di un teatro di cerniera e non di ponte.
Furono variegati i fattori che portarono alla nascita del teatro elisabettiano, da quelli storici allo sviluppo di spazi teatrali diversificati e al variare della composizione del pubblico, ma non ultimo anche quello per cui, salvo alcune eccezioni, i copioni del teatro non venivano considerati opere letterarie, quindi testi fissi e esemplari, bensì erano “vivi”, per cui le varie rappresentazioni si basavano su quelle tracce elaborandone e diversificandole di volta in volta.
Le opere di Shakespeare sono dense della immagine del mondo degli elisabettiani. Nel mondo inglese di quel periodo storico si accavallarono molti tipi di ideologie ma con certe idee ricorrenti. Quando nel discorso di Ulisse Shakespeare chiama “grado” la “scala verso tutti gli alti disegni”, alludeva alla cosiddetta catena dell’essere, cioè il mondo per gli elisabettiani era formato in maniera grandiosa come una serie di gradi gerarchicamente disposti, dagli inanimati, agli animali, all’uomo fino alle sfere celesti e a Dio. Ogni classe di elementi può eccellere in qualche cosa. In ogni classe poi esiste un primate. Questa catena funziona sul piano verticale, ma ne esisteva anche una analoga sul piano orizzontale, vale a dire che alcuni gradi della catena dell’essere hanno tra di loro delle corrispondenze, spesso sono delle coppie, per cui ad esempio tra l’universo (macrocosmo) e la struttura politica umana vi sono dei richiami.
Nel 1490 Caxton si lamentava che a Londra si diceva egges, ma il parlante poteva essere frainteso da una persona che si esprimeva alla maniera nordica e quindi diceva eyren. Aggiungeva che era indispensabile un compromesso affinché tutti gli inglesi si capissero. Questo compromesso fu rivelato qualche anno dopo da Puttenham che scriveva: “Voi dovete prendere perciò la parlata abituale della Corte” riferendosi soprattutto a quella della Corte di Londra. In questo modo si decise la uniformità della lingua letteraria inglese, diffusa enormemente dalla allora nascente stampa, mentre le parlate quotidiane continuavano a sussistere sempre diversificate, come in parte lo sono ancora oggi. Pertanto le forme grammaticali della lingua inglese letteraria finirono con l’irrigidirsi, però non cessando mai del tutto la loro evoluzione. Il Rinascimento inglese servì a congelare le forme principali della lingua inglese che sono adottate ancora oggi. Scrive Pei: “La principale caratteristica linguistica dello straordinario periodo in cui Shakespeare e Spenser posero le basi dell’inglese moderno (mentre Elisabetta, dal canto suo, stava creando l’impero britannico) può essere individuata nella consapevolezza della gente, che aveva finalmente preso coscienza della lingua grazie ad un processo di crescente educazione e alfabetizzazione e grazie all’incremento della produzione letteraria”.
Il linguaggio verbale non si presta solo a uno studio linguistico e filologico, ma anche psicologico. Le parole, infatti, sono lo specchio della nostra mente, sia cosciente sia incosciente.
Freud ha applicato il metodo psicoanalitico altresì allo studio dell’Amleto di Shakespeare. Secondo le sue numerose esperienze, i genitori hanno la parte principale nella vita psichica infantile di tutti i futuri psiconevrotici: amore per l’uno, odio per l’altro dei genitori, fanno parte di quella riserva inalienabile di impulsi psichici che si forma in quel periodo ed è così significativa per la semeiologia della
futura nevrosi. A sostegno di questa conoscenza, l’antichità ci ha trasmesso un materiale leggendario. Freud ntende la leggenda del re Edipo e l’omonimo dramma di Sofocle. Edipo, figlio di Laio re di Tebe e di Giocasta, viene esposto lattante perché un oracolo ha predetto al padre che il figlio non ancora nato sarà il suo assassino. Edipo viene salvato e cresce come figlio di re in una corte straniera, sinché, incerto della propria origine, interroga egli stesso l’oracolo e ne ottiene il consiglio di star lontano dalla patria, perché sarebbe costretto a divenire l’assassino di suo padre e lo sposo di sua madre. Sulla strada che lo porta lontano dalla presunta patria, incontra il re Laio e lo uccide nel corso di una repentina lite. Giunge poi davanti a Tebe, dove risolve gli enigmi della Sfinge che sbarra la via; per ringraziamento i Tebani lo eleggono re e gli offrono in dono la mano di Giocasta. Per lungo tempo regna pacifico e onorato, genera con la madre a lui sconosciuta due figli e due figlie, finché scoppia una pestilenza che induce ancora una volta i Tebani a consultare l’oracolo. Qui comincia la tragedia di Sofocle. I messi portano il responso che la pestilenza avrà fine quando l’uccisore di Laio sarà espulso dal paese. Ma dove si trova costui? Ora, l’azione della tragedia non consiste in altro che nella rivelazione gradualmente approfondita e ritardata ad arte – paragonabile al lavoro di una psicoanalisi – che Edipo stesso è l’assassino di Laio, ma anche il figlio
dell’assassinato e di Giocasta. Travolto dalla mostruosità dei fatti commessi inconsapevolmente, Edipo si acceca e abbandona la patria. L’oracolo si è avverato. Il suo destino ci commuove soltanto perché sarebbe potuto diventare anche il nostro, perché prima della
nostra nascita l’oracolo ha decretato la medesima maledizione per noi e per lui. Forse a noi tutti era dato in sorte di rivolgere il primo impulso sessuale alla madre, il primo odio e il primo desiderio di violenza contro il padre. Il re Edipo, che ha ucciso suo padre Laio e sposato sua madre Giocasta, è soltanto l’appagamento di un desiderio della nostra infanzia. Ma, più fortunati di lui, siamo riusciti in seguito a staccare i nostri impulsi sessuali da nostra madre, a dimenticare la nostra gelosia nei confronti di nostro padre.
Nello stesso terreno dell’Edipo re si radica, per Freud, un’altra grande creazione tragica, l’Amleto di Shakespeare. Ma nella mutata elaborazione della medesima materia si rivela tutta la differenza nella vita interiore di due periodi di civiltà tanto distanti tra loro, il secolare progredire della rimozione nella vita affettiva dell’umanità.
Nell’Edipo, l’infantile fantasia di desiderio che lo sorregge viene tratta alla luce e realizzata come nel sogno; nell’Amleto permane rimossa e veniamo a sapere della sua esistenza soltanto attraverso gli effetti inibitori che ne derivano. Amleto può tutto, tranne compiere la vendetta sull’uomo che ha eliminato suo padre prendendone il posto presso sua madre, l’uomo che gli mostra attuati i suoi desideri infantili rimossi. Il ribrezzo che dovrebbe spingerlo alla vendetta è sostituito in lui da autorimproveri, scrupoli di coscienza, i quali gli rinfacciano che egli stesso, alla lettera, non è migliore del peccatore che dovrebbe punire.
Gli psicologi successivi hanno studiato molto approfonditamente anche la scrittura in sé. Perché si scrive? Secondo una teoria, la scrittura è un modo per placare le angosce e per elaborare il lutto, cioè la scrittura è un atto simbolico di riparazione.
Dello stile come modalità della riparazione si è parlato anche in relazione a Proust. Infatti non solo l’impianto e il progetto della Recherche appare come un’immensa metafora del lavoro del lutto, ma la stessa concezione proustiana dello stile come lavoro oltre che come visione è del tutto convergente con questa impostazione.
Si può definire lo stile come il lavoro psichico compiuto dall’autore mediante la creazione artistica, intesa sia nella sua progettualità che nella concreta materialità della sua realizzazione, al fine di scaricare oppure di neutralizzare e controllare gli affetti connessi a determinati contenuti, utilizzando appunto i due meccanismi complementari del lavoro del lutto: l’abreazione e la ripetizione.
Se è vero che l’artista esprime nell’opera il suo privato, i suoi prepotenti desideri inconsci, questo avviene solo perché egli sottopone tali contenuti a un’efficace opera di deformazione e rielaborazione, al fine di attenuare, velare, negare il carattere privato di quelle fantasie. A patto, cioè, che siano rispettate le condizioni della censura. Il lavoro artistico si servirà della condensazione, dello spostamento, della raffigurazione indiretta, della negazione, tutte modalità che possono essere assimilate a quelle di una vera e propria retorica dell’inconscio. Vale la pena di ricordare una volta di più che il compito della censura, o meglio, il suo effetto, non è tanto quello di cancellare e occultare l’inconscio, impedendogli di esprimersi, ma soprattutto quello di rivelarlo, benché camuffato.
Lo stile non è propriamente il lavoro dell’inconscio, cioè un fatto esclusivamente interno e privato del singolo artista: è lavoro psichico, nel senso che esso collega natura e cultura, privato e pubblico, soggetto e oggetto: è il margine ideale che connette mondo interno e mondo esterno.
Se lo stile esprime, da un lato, una modalità interna del lavoro psichico, che riguarda i percorsi privati del singolo autore, dall’altro, la nozione di stile rinvia a qualcosa di più generale e universale, a un assetto di norme e canoni storicamente e culturalmente consolidati, con cui il singolo artista si deve confrontare. Da questo punto di vista lo stile si può anche configurare come il lavoro di adeguamento, sentito come più o meno vincolante, a qualcosa che è fondamentalmente esterno all’individuo.
Bibliografia
- AA.VV., Atkinson&Hilgard’s. Introduzione alla psicologia, Padova 2017;
- G. Basile, La conquista delle parole. Per una storia naturale della denominazione, Roma 2012;
- G. Bateson, Verso una ecologia della mente, Milano 2011;
- G. Berruto, M. Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2017;
- C. Cacciari, Psicologia del linguaggio, Bologna 2011;
- V. Cardella, D. Bruni (a cura di), Cervello, linguaggio, società. Atti del Convegno 2008 del CODISCO, Roma 2014;
- N. Chomsky, Regole e rappresentazioni, Milano 1981;
- C. Corti (a cura di), Il Rinascimento. I contesti culturali della letteratura inglese, Bologna 1994;
- M. D’Amico, Scena e parola in Shakespeare, Roma 2007;
- M. Daloiso, I fondamenti neuropsicologici dell’educazione linguistica, Venezia 2009;
- M. Danesi, Il cervello in aula! Neurolinguistica e didattica delle lingue, Perugia 1998;
- G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, Macerata 1996;
- M. E. Favilla, E. Nuzzo (a cura di), Grammatica Applicata: Apprendimento, Patologie, Insegnamento, Milano 2015;
- G. C. Fedeli, Indeterminatezza e mutamento linguistico, ILIESI 2017;
- S. Ferrari, Scrittura come riparazione. Saggio su letteratura e psicoanalisi, Roma-Bari 2005;
- S. Freud, L’interpretazione dei sogni, Milano 2014;
- J. J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston 1979;
- E. Jezek, Lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna 2011;
- P. Lieberman, Toward an Evolutionary Biology of Language, Harvard 2006;
- L. Lotto, R. Rumiati (a cura di), Introduzione alla psicologia della comunicazione, Bologna 2007;
- A. Lunelli (a cura di), La lingua poetica latina, Milano 2011;
- M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia, Dalla questione Molyneux a Jakobson, Macerata 2005;
- G. Melchiori, Shakespeare, Roma-Bari 2005;
- L. Mereu, Semantica della frase, Roma 2020;
- R. Nicoletti, R. Rumiati, L. Lotto, Psicologia. Processi cognitivi, teoria e applicazioni, Bologna 2017;
- G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Milano 2006;
- G. Rizzolatti, L. Craighero, The Mirror Neuron System, in Annual Review of Neuroscience 27 (2004) pp. 169-192;
- S. Sinisi, I. Innamorati, Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie storiche, Milano 2003.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha dato alle stampe 39 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli.







