Se un corpo è libero solo quando esso obbedisce alla sua anima, non ad un’anima eterogenea — allora riceve un senso profondo di verità l’affermazione di Federico II, secondo la quale gli Stati che riconoscono l’autorità dell’Impero sono liberi, mentre schiavi sono quelli che alla Chiesa — esponente di un’altra spiritualità si sottomettono.Julius Evola |
Completiamo la nostra sintetica rassegna della sovversione guelfa in Italia con uno sguardo al peculiare modo di atteggiarsi di essa nel nostro Mezzogiorno.
Il regno del Sud sorse come impossibile feudo concesso ai Normanni dal Papato, al quale non competeva conceder feudi in Italia, bensì soltanto somministrare i riti e impartire il messaggio di una religione di salvezza; e si consolidò quindi, in uno spirito prevaricante di rivolta alla legittima Autorità imperiale della Corte staufica di Palermo, quale regno bastardo, nato dall’impuro connubio del re fellone Carlo d’Angiò con la curia papale dell’epoca, entrambi specificazioni storiche dell’allegoria dantesca del Gigante e della Prostituta (Purg. XXXII, 148-160).
Il regno del Sud, dunque, nacque e si consolidò come stato vassallo della Chiesa e quindi, per usare il duro linguaggio federiciano, fu uno stato schiavo. Come tale, era irrinunciabile compito ghibellino l’abbatterlo. Data la premessa guelfa, la conclusione ghibellina segue con la stessa intrinseca necessità di un teorema matematico.
Il compito di liberare l’Italia dall’intollerabile vassallaggio del Sud nei confronti del Papato, fallito dai Principi della Casa staufica, per una serie di circostanze avverse, fu raggiunto, molti secoli dopo, dal condottiero Garibaldi, che lo conquistò nel nome del re ghibellino Vittorio Emanuele II di Savoia. Il re guelfo Ferdinando II di Borbone, invece, malgrado le sollecitazioni dei suoi fedeli, non volle mettersi a capo del movimento unitario nazionale per rispetto al Papa ((Più esattamente egli rispose che non accettava la corona d’Italia “per non sapere che cosa fare del Papa” (in: VITTORIO GLEIJESES, La storia di Napoli, Napoli 1974, p. 765.)). Con tale atteggiamento egli si mostrò perfettamente coerente con le “tradizioni” guelfe del suo regno. Regno guelfo, dunque, da eliminare, come è stato fatto, quale corpo estraneo alla struttura unitaria della Tradizione Italica, intollerabile proiezione della Teocrazia usurpatrice sul territorio sacro della Saturnia Tellus.
Che poi a ciò si sia giunti troppo tardi (per colpa della curia papale e dei suoi vassalli) e quindi con tutti gli effetti traumatici che comporta il somministrare in grave ritardo un farmaco necessario, è cosa che non tocca l’assoluta esattezza del principio: un regno vassallo della Chiesa non aveva in Italia ragione né diritto di esistere.
Ma v’é di più. La curia papale, volendo, contro la politica imperiale degli Staufen, un regno del Sud diviso e separato dal resto dei possedimenti imperiali dell’Italia del Nord, attuò la separazione del Settentrione dal Mezzogiorno d’Italia, i cui effetti negativi si notano ancor oggi, ma le cui cause la parte guelfa cerca di fare dimenticare.
Si impone quindi una riflessione di fondo. Roma, unificando le antiche e diverse genti italiche, ebbe nei loro confronti un effetto aggregante. La curia papale, separandole ed allontanandole esercitò su di loro una efficacia disgregante. Essa si pose quindi, nella storia d’Italia, come l’Anti-Roma per eccellenza. E poiché se pensiamo all’Anti-Roma il pensiero non può non correre a Cartagine, la politica temporale guelfa ed antievangelica del papato attraverso i secoli fu in qualche modo simile a quella di una Nuova Cartagine nel suo avere ostacolato lo sviluppo della storia nazionale italiana.
Riteniamo di aver fornito sufficienti “chiavi” per la interpretazione, lo smascheramento e la condanna degli interessi guelfi e disgreganti che si celano dietro l’artificioso “revival” borbonizante al quale da qualche tempo si assiste.
Non sarà tuttavia inutile, per l’utilità dei lettori, analizzare rapidamente i testi dottrinali ai quali fanno riferimento quanti danno appoggio a questa ennesima insidia guelfa alla unità della Tradizione Italica.
Viene innanzitutto in considerazione, per il livello di pensiero che la ispira e la formazione culturale che la nutre, l’opera di Francisco Elias de Tejada. Questo scrittore spagnolo non fu guelfo per temperamento, ché anzi mostrò di appartenere interamente, per il suo sentire, alla tradizione monarchica delle Spagne, la quale, all’occorrenza, non fu affatto tenera con il papato, come dimostra la brutale vicenda del sacco di Roma del 1527. Egli fu quindi il tipo, di monarchico cattolico tradizionalista iberico ed incarnò, nella vita e nelle opere, la bella figura dell’hidalgo.
Questo fu il suo pregio ed il suo limite. Infatti, la mancanza di alcuni essenziali punti di riferimento ghibellini e romani ha fatto sì che la sua opera, non guelfa nelle intenzioni, sia in realtà da collocarsi interamente nell’ambito della pubblicistica guelfa.
Troviamo infatti, anche nel de Tejada, il caratteristico errore che pone tutta l’impostazione guelfa al di fuori della vera Tradizione Italica: il disconoscimento del perenne mistero imperiale e quindi superreligioso di Roma, e del perpetuarsi nei secoli, fino ai nostri giorni, della Tradizione Classica che lo custodisce. Da questo svisamento della verità essenziale discendono i vari errori contenuti nella concezione dottrinale del de Tejada.
Nel considerare la sua opera prendiamo quindi le mosse da un suo scritto fondamentale, “La monarchia tradizionale” ((Francisco Elias de Tejada, La monarchia tradizionale, Torino 1966.)), apparso con il sottotitolo “Il fascismo superato a destra”, il quale deve essere apparso ghiotto all’anima guelfa di tanta parte della c.d. destra italiana, la quale, abbandonando ogni prudenziale ritegno, ha svelato in questi ultimi anni il suo vero volto.
Ecco le affermazioni di Elias de Tejada che rivelano la sua incomprensione di fondo del “senso” della storia italica: “… Mussolini vide la Tradizione italiana nel solco di quella Roma, che, per gli Italiani del XX secolo, non poteva essere altro che un remoto e venerato resto archeologico” ((Ibid, p. 12.)); “L’equivoco del fascismo, riducente la Tradizione italiana alla chimera dorata e morta di una tradizione romana evanescente…” ((Ibid, 12-13.)); “Accorrere a Roma cercando resuscitare un paganesimo più che morto…” ((Ibid, 25.)); “… sogno della resurrezione della tradizione pagana di Roma …” ((Ibid, 25.)). Come si vede, sono espressioni dalle quali risulta che la verità della continuità perenne della Tradizione romana classica all’interno della storia d’Italia è ignorata, misconosciuta, considerata equivoco, sogno, tentativo necromantico ((Arturo Reghini è di diverso avviso, quando afferma: “Vogliamo solo attestare con la nostra opera l’esistenza e l’azione della tradizione iniziatica romana…”, IGNIS, Gennaio 1929, p. 5.))).
Chi ci segue sa che questa Rivista non risparmia al fascismo pesanti critiche e severi giudizi. Ma esso, almeno, malgrado fosse intriso di guelfismo, non giunse mai a dichiarare formalmente estinta la Tradizione Classica, come invece si ricava dalle affermazioni del de Tejada. Il suo libro, pertanto, più esattamente avrebbe dovuto recare come sottotitolo “Il fascismo superato in guelfismo”. Tanti equivoci sarebbero stati allora evitati.
Da questo fondamentale errore guelfo di prospettiva nasce il disconoscimento, da parte del de Tejada, del profondo significato positivo, per la storia d’Italia, dei due grandi momenti storici nei quali maggiormente rifulse l’incrollabile fedeltà della parte migliore della sua stirpe alla Tradizione classica: il Rinascimento e il Risorgimento.
Così per quanto riguarda il Rinascimento, il grande e nobile sforzo di Niccolò Machiavelli di riaccendere negli Italiani il ricordo del loro passato “romano” è considerato “una chimera umanistica, e non il programma concreto che era naturale sperare dal suo realismo politico. Il dolore d’Italia s’ammanta di irrealizzabile sogno. Come l’Alighieri risolse la sua passione italiana nella formula dell’Impero d’Occidente, Niccolò Machiavelli risolve la sua nell’impossibile resurrezione della Roma morta mille anni fa” ((F. Elias de Tejada, Il Risorgimento nella tradizione italiana, in: Per una cultura giusnaturalista, Palermo 1981, p. 63 (il corsivo è nostro).)). È proprio questo l’errore capitale del de Tejada: Roma non muore, perché, platonicamente, è un’idea eterna nella Mente di Dio ed è massimo titolo di gloria del Rinascimento l’avere riportato alla luce quella sapienza platonica che costituisce il naturale involucro e sostegno di questa e di altre verità tramandate dalla Tradizione classica. Ma di questo nel de Tejada non v’è, né può esservi cenno.
Sfugge al de Tejada la profonda nobiltà insita nella fedeltà delle aristocrazie italiche al retaggio di Roma antica, fedeltà che si tradusse nel Rinascimento in un religioso amore posto nella riscoperta e nello studio delle antichità classiche, vissuti come un rinnovato contatto con le radici più profonde della propria anima e del proprio sangue; e, nel Risorgimento, nella precisa volontà di restaurare, nella Penisola, quell’unità politica e statuale delle genti italiche che Roma aveva realizzato e che era andata perduta con il tramonto del mondo antico. La Tradizione italiana, quindi, contrariamente a quanto pensa il de Tejada, è inscindibile dalla Tradizione romana, la quale non è affatto “evanescente” né costituisce una “chimera dorata e morta” ((F. Elias de Tejada, La monarchia tradizionale, pp. 12-13.)). Essa è, al contrario, ben viva, come sanno i guelfi che se la trovano sempre di fronte ogni qual volta passano il limite che essa riconosce loro.
Non una parola vi è nel de Tejada circa la tenace e prevaricante opposizione esercitata dalla curia vaticana all’unità politica delle genti della Penisola, unità rispondente ad un elementare diritto naturale che nemmeno i guelfi possono disconoscere. Ed è curioso che il de Tejada, pur avendo notato tale mostruosa anomalia, non ne identifichi la causa, che pure è nota. Scrive infatti il de Tejada: “Nella penisola iberica fu possibile un processo di unificazione culminato nel 1580, mentre in Italia una serie di ostacoli impedisce l’attuazione del processo unitario, anche nella forma iberica di federazioni personali o reali” ((F. Elias de Tejada, Il Risorgimento, ecc., p. 73 (il corsivo è nostro).)). Eppure non ci voleva molto ad indicare nella prava volontà di conservare il proprio potere temporale, da parte della curia vaticana, l’essenza di quella serie di ostacoli dei quali il de Tejada riconosce l’esistenza. E quindi è soltanto patetico l’accenno del de Tejada alla ipotesi che avrebbe visto realizzarsi l’unità d’Italia intorno al Regno di Napoli: “l’unità d’Italia intorno al trono del Regno avrebbe potuto realizzarsi in accordo con la struttura propria della Monarchia Cattolica; cioé alla maniera di una federazione nell’ambito della quale ogni componente avrebbe conservato la propria personalità politica e culturale, senza pregiudizio per l’unione di tutti nelle imprese comuni” ((Ibid., p. 67.)). Il vizio di tale ragionamento consiste infatti nel trascurare la vera natura del Regno di Napoli quale stato vassallo del Papato, risalente alle poco limpide origini del patto stretto dal papa Urbano IV con il re fellone Carlo d’Angiò. Come poteva un regno schiavo (la dura espressione, lo abbiamo visto, è dell’Imperatore Federico II) ribellarsi contro il suo padrone? E il suo padrone, il papato, aborriva da ogni forma di Stato unitario della Penisola italiana, che prima o poi avrebbe posto sul tappeto la “questione romana” ed avrebbe guardato a Roma come alla sua capitale naturale, considerando la cessazione del potere temporale dei papi come un evento, oltre che giusto, altrettanto naturale.
Certo, un’Italia debole e divisa ha fatto il gioco delle altre Potenze europee, che hanno trovato la via libera su tale lato. Non sorprende quindi che il de Tejada, sincero amico dell’Italia, ma pur sempre celebratore della potenza della grande confederazione monarchica delle Spagne, si faccia dell’Italia una idea femminea, vedendola “dolce come una sposa, graziosa come una sirena, sottile come un brusio discreto e fervidamente appassionata come una preghiera risonante nell’alba di un giorno di battaglia” ((F. Elias de Tejada, La monarchia tradizionale, p. 8.)) (in altre parole, la bella che sta in chiesa a pregare, mentre il suo uomo va in battaglia). Oppure quando le riserva soltanto il ruolo di bottega d’arte, laddove, criticando Mussolini, afferma che egli “Non vide che la penisola italiana, durante gli ultimi 7 secoli, aveva disimpegnato il ruolo, che, nell’orbe classico, corrisponde alla Grecia: il culto del bello e non l’arte della guerra, l’essere vivaio di poeti ed artisti, preferire nuove conquiste nell’arte a nuove conquiste di terre” ((Ibid., p. 12.)). Vien da pensare che davvero Spagnoli, Francesi, Inglesi, Olandesi, Portoghesi dovrebbero accendere ceri quotidiani davanti alle effigi dei Papi che, usando la potentissima arma della religione nei confronti di un popolo, l’italiano, di pie tradizioni, lo hanno diviso e mortificato nella sua anima storica, che era pur sempre un’anima imperiale. Se si pensa a quello che riuscirono a compiere le Repubbliche Marinare italiane, piccole e per di più in acerrima lotta tra loro, si deve pensare che la flotta militare di un’Italia che fosse stata unita nel XV secolo avrebbe dominato i mari ed oggi, con ogni probaoilità, si parlerebbe italiano in India come in America!
Occorre infine dire che, così come è sfuggito ad Attilio Mondini ((v. Il Ghibellino, Dicembre 1981, pp. 17-18.)), il de Tejada non sembra rendersi conto che, affinché vi sia egemonia di un popolo sugli altri, e quindi un nazionalismo occulto di esso, non occorre certo la presenza di una ideologia nazionalistica apertamente e dichiaratamente conclamata. Basta che, di fatto, vi sia l’egemonia di una stirpe sulle altre. Quindi non ci convince il de Tejada quando si dice avversario del nazionalismo, ma poi esalta la grande confederazione monarchica delle Spagne, comprendente il Regno di Napoli, cioé una buona parte dell’Italia. Proviamo a rovesciare i termini della questione: anche noi ci dichiariamo avversari del nazionalismo, però proponiamo una grande confederazione monarchica delle Italie, comprendente anche la Spagna, retta da un Imperatore avente il trono in Italia! Crediamo che nessun nazionalista italiano abbia mai osato vagheggiare un sogno “nazionale” così ambizioso. Eppure i titoli storici non mancano: la Spagna fu provincia romana, tanto che in un suo borgo, Italica, fondato da Scipione Africano, ebbe i natali l’Imperatore Trajano, colui che condusse il nostro Impero alla massima espansione! Non crediamo che ad Elias de Tejada sarebbe piaciuto l’idea si indurre la Spagna a far parte delle Italie! Stranamente dovrebbe essere sempre l’Italia a fare le spese, rinunziando alla sovranità su ampie parti del suo territorio, a favore delle pretese “tradizionali” (non nazionalistiche, per carità) di filoiberici, austriacanti, ecc. Non si immaginerà certo che gli Italiani, benché frastornati da quindici secoli di chiacchiere pseudoteologiche e pseudogiuridiche guelfe, siano tanto ingenui da accettare simili punti di vista!
Concludiamo con Elias de Tejada, trattando in breve della sua posizione critica nei confronti della lingua italiana, che egli chiama “idioma toscano coltivato artificialmente da caste di letterati” e “toscano straniero” ((F. Elias de Tejada, La monarchia tradizionale, pp. 14.15. Una delle fissazioni ricorrenti della pubblicistica guelfa è l’avversione nei confronti della lingua italiana. Già alcuni anni fa, sulla rivista “Solstitium” del Centro di formazione tradizionale “Julius Evola”, qualcuno era giunto a magnificare la possanza dello spagnolo “yo”, contrapponendola alla debolezza dell’italiano “io” (!).
La misura è stata tuttavia colmata dallo scritto di un polemista guelfo del quale questa rivista si è già occupata (cfr. di Ezzelino, Del “Rogo” e d’altro, sui nn. 0 e 1 de “Il Ghibellino”). Sul nr. 2/1979 del “Rogo”, infatti, il guelfo Ottone (metallo, peraltro, assai facile da piegare), criticando l’articolo di Jacopo da coreglia Ghibellinismo dantesco e Tradizione italica (Arthos, aprile 78 gennaio 79) contenente, tra l’altro, una esaltazione dell’idioma italico, definito da Dante volgare illustre, forniva di esso una “originale” interpretazione, definendolo “la lingua parlata dal volgo”, con palese intento denigratorio. Eppure sarebbe bastato che, anziché farsi accecare dai suoi umori antitalici, fosse andato a leggere quanto scrive al riguardo il Guénon, con esattezza filologica e profondità di ermeneutica tradizionale: “L’essenziale, qui, è di sapere cosa intende Dante con l’espressione volgare illustre la quale può sembrare strana o addirittura contraddittoria se ci si attiene al senso ordinario delle parole, ma diventa comprensibile se si tien conto che per lui volgare è sinonimo di naturale: cioé la lingua che l’uomo impara direttamente per trasmissione orale (come il bambino, che dal punto di vista iniziatico rappresenta il neofita, apprende la propria lingua materna), vale a dire, simbolicamente, la lingua che serve da veicolo alla tradizione, e che, sotto questo rapporto, può identificarsi con la lingua primordiale e universale” (Rivista di studi tradizionali, n. 31, luglio-dicembre 1969, p. 101). Come si vede siamo ben lontani dalla ottonata definizione di “lingua parlata dal volgo”. Ma anche per chi non intendesse seguire così, lontano il Guénon, rimarrebbe il fatto che “volgare” significa “naturale” e, soprattutto, che l’idioma italiano è una lingua aristocratica, perché si formò a corte, nella reggia federiciana di Palermo. Così questa nostra lingua asciutta, signorile ed elegante, che nacque in Sicilia, fu giovane in Toscana ed è divenuta matura con l’apporto di tutte le genti d’Italia, è, fra le lingue vive più belle e nobili del mondo, forse la prima, come molti stranieri non stentano a riconoscere.
Resta da appurare perché Ottone ce l’abbia tanto con essa e quale altro idioma, in definitiva, le preferisca. Forse il tunisino?
A quanto pare, ciò che è toscano non riscuote le simpatie della stampa guelfa. In proposito menzioniamo l’articolo di Gabriele Fergola, Ma gli italiani chi sono?, apparso su il CONCILIATORE, dicembre 1975. In esso spira una singolare ostilità verso la Toscana, nella quale si vede, tra l’altro, “l’Etruria che rinasce ancora con Galileo, il negatore del tradizionale sistema tolemaico, in polemica con la Roma non più dei Cesari ma dei Papi” (volevamo ben dire!). Non è nostro compito svolgere una difesa d’ufficio della terra di Marsilio Ficino e di Arturo Reghini, oltre che, naturalmente, di Dante Alighieri. Ci basta citare il passo di un autore, che non dovrebbe essere sgradito al Fergola, dal quale risulta che la moderna Etruria, sul piano dello stile, non si è poi, al momento della prova, comportata così male: “Dopo la fine della guerra un ufficiale americano, a chi gli chiede quale città italiana gli sia piaciuta di più, risponderà: « Firenze, perché è l’unica città dove ho veduto degli italiani che hanno avuto il coraggio di spararci addosso «Malaparte dedicherà un’indimenticabile pagina della « Pelle » alla descrizione della fucilazione di franchi tiratori e franche tiratrici fiorentine, ragazzi e ragazze di quindici o sedici anni che muoiono beffando i loro carnefici e gridando: « Viva Mussolini! ». E l’unica pagina pulita e luminosa in quel libro così tetramente sudicio e opaco, l’unica nella quale il nome italiano esca onorato” (Adriano Romualdi, Le ultime ore dell’Europa, Roma 1976, p. 20).)), che a torto si sarebbe sostituito al napoletano. Egli dimentica, infatti, che la lingua italiana è idioma che nacque alla corte siciliana di Federico II, quindi lingua aristocratica e patrimonio comune di tutti gli italiani, e niente affatto “toscana”, come bene insegnò Dante nel “De vulgari eloquentia”. Che poi i grandi trecentisti toscani (Dante, Boccaccio e Petrarca) l’abbiano innalzata a vette sublimi è un dato storico che nulla ha a che vedere con pretese egemoniche regionali od altro. Di fatto, la lingua purissima dei grandi trecentisti si pone in rapporto di continuità con la lingua della Scuola Siciliana e non con qualsiasi dialetto italiano, napoletano o di altra parte. Ogni stirpe che abbia un destino comune (e se non lo ha, a rigore, non è “stirpe”, ma accozzaglia di etnie) ha anche un comune linguaggio e il de Tejada è costretto implicitamente a riconoscerlo laddove ricorda che finché rimase in piedi l’ideale del primato italiano di Napoli (fino alla fine del XVI secolo) ci si servì in quel regno del “toscano” (cioé dell’italiano). Oppure si preferisce un’Italia priva di un linguaggio comune, nella quale un napoletano debba ricorrere al vocabolario per leggere un giornale triestino, e viceversa? Ci sembra di sognare a dover sprecare tempo ed inchiostro per dover confutare, nell’anno di grazia 1982, simili assurde ipotesi.
Anche in casa guelfa, tuttavia, le opinioni non sempre collimano. Non se la prende con il “toscano” lo scrittore Carlo Alianello, che tra l’altro dimostra di maneggiare con perizia la lingua italiana, ma si dimostra fautore dei Borboni, cosa che avrebbe fatto inorridire Elias de Tejada. Intendiamo riferirci al libro “La conquista del Sud”, del quale non ci saremmo occupati, data la scarsa consistenza storica delle tesi esposte, se esse non fossero state presentate in uno stile suggestivo che può far sempre colpo sulla mentalità da perpetui emarginati del sottobosco della c.d. destra italiana, sempre in caccia di sconfitte storiche nelle quali stemperare l’amaro dei propri fallimenti individuali. Diciamo “scarsa consistenza storica” delle tesi sostenute dall’Alianello, unicamente perché egli attinge prevalentemente ad autori “di parte guelfa”, come egli ha in un caso l’onestà di dichiarare apertamente (a pag. 138, a proposito del libro del cavalier Farnerari “Della monarchia di Napoli e della sua fortuna”), oppure addirittura ad opere di Anonimi, come nel caso delle citatissime “I napoletani al cospetto delle nazioni civili” e “Cronaca degli avvenimenti di Sicilia, dall’aprile 1860 al marzo 1861”. Sarebbe un po’ come se si volesse scrivere un libro antiborbonico fondandosi sul libro, realmente esistente, di Anonimo, I delitti della famiglia Borbone dacché regna nelle due Sicilie (1734-1860). Cenni cronologici, Asti, Raspi 1860.
Fatta questa premessa, il libro offre soltanto l’interesse di un pamphlet guelfo, scritto bene ma intriso dei soliti errori che la parte guelfa ripropone oggi, nell’ignoranza generale, come punti di vista nuovi ed anticonformisti, ma che in realtà ripetono vecchie ubbie con una monotonia che rasenta il tedio. Così troviamo il “pio” Re Ferdinando II, che avrebbe potuto “mettersi a capo del movimento unitario. Ma non volle, per rispetto al Papa” (p. 31; come volevasi dimostrare!); un Re che rivela ancora una volta la bieca intolleranza guelfa, quando ha il potere, decretando: “L’unica religione dominante nello Stato sarà la Cattolica, Apostolica, Romana; e non vi sarà tolleranza di altri culti” (p. 46; il bravo vassallo del papa ci tiene a far bene il suo lavoro!); il trasparente rimpianto per la “gloria” che avrebbe baciato il generale borbonico tedesco Von Moechel se avesse “schiacciato, dentro e sotto Palermo, Garibaldi e i Garibaldesi” (pp. 68-69; purtroppo, per lui, il von Moechel fu baciato dalla sconfitta nella battaglia del Volturno); la jattura di non avere posseduto, i Borbonici, i moderni cannoni rigati all’assedio di Gaeta, cannoni posseduti invece dagli odiati Piemontesi (p. 75; ma allora, dov’era la tanto vantata superiorità del Regno di Napoli nel progresso tecnologico ?); il “coraggioso” Re Francesco II di Borbone che, a differenza di Vittorio Emanuele III di Savoia, non fuggì dalla sua capitale (p. 98; e da chi avrebbe dovuto fuggire? Non aveva certamente alle calcagna i nazisti, bensì soltanto il buon Vittorio Emanuele II, che non gli avrebbe torto un capello) ((Le suggestioni dell’Alianello, ancorché fondate su prospettive storiche errate e prive di un reale fondamento tradizionale, non sono rimaste prive di una certa eco. A parte i polpettoni televisivi con cattivi ufficiali dei bersaglieri muniti di berretti con improbabili piume color verde pisello, tanto graditi alla cultura radical-chic che scorge nelle tematiche guelfe un ghiotto strumento per rendere la situazione italiana ancor più confusa e ingovernabile di quanto già lo sia, si possono anche leggere imprudenti affermazioni. Così Carlo Terracciano, nella presentazione del libro di Otto Rahn, Crociata contro il Graal, 1979, accosta “Il colonialismo piemontese nel mezzogiorno d’Italia” alla infame e sanguinosa crociata cattolica contro i Catari della Francia del Sud. E non si accorge che è vero esattamente l’opposto. L’abbattimento del regno di Napoli da parte italiana non fece che vendicare la civiltà cortese e “trovadorica” del Sud federiciano e svevo, distrutta dalla crociata cattolica voluta dal papa Urbano IV e dal fellone Carlo d’Angiò.)); il lamento per il sacrilegio dei Piemontesi, che incamerarono “mense vescovili, le terre e i beni delle disciolte congregazioni religiose” (p. 127; peccato che non vi sia stata sottomano una falsa donazione di Costantino per dimostrarne la proprietà); e così via. Sul finire del libro l’Alianello si pone la fatidica domanda sul perché vi fu “tradimento in massa di generali, di alti ufficiali, della flotta” (p. 225). Giusta domanda, perché in effetti le forze militari borboniche avrebbero potuto schiacciare, con la loro potenza immensamente superiore, i garibaldini appena sbarcarono in Sicilia. Vorremmo azzardare una risposta pedestre alla domanda di Alianello: forse perché avevano le tasche piene de “lu Re”, de “lu Papa” e di un assetto della Penisola arcaico ed ingiusto, che spaccava in pezzi l’Italia, perpetuando antiche divisioni escogitate dalla libidine di potere temporale di teologastri falsari.
Con questo facciamo il punto. La confutazione dei monotoni errori guelfi ci è venuta a noia e speriamo che l’abbia a noia anche il lettore, il quale saprà rispondere con un salutare sbadiglio ogni qualvolta si imbatterà nelle trite argomentazioni di “borbonici”, “papalini”, “asburgici”, “filoispanici”, ecc. Almeno tutti gli scritti che abbiamo citato hanno la dignità dell’intelligenza e della cultura e quindi meritano il rispetto che sempre si deve alle manifestazioni del pensiero. Nessun rispetto merita invece la trista schiera di quella feccia di emarginati e falliti che, in preda alla Schadenfreude, al piacere di tutto insozzare, si scaglia contro la Patria italica, alla quale vorrebbe negare Unità ed Indipendenza per sostituirle, secondo i suoi gusti da servi, con una soggezione a potentati stranieri. Il suo disegno è fallito fortunatamente sul nascere. Ma ne abbiamo preso buona nota, almeno per contare quanti, presso di noi, hanno lo stesso nostro passaporto pur discendendo in linea retta dai numerosi schiavi punici, teutonici, gallici ecc. che i nostri padri Romani ebbero l’imprudenza di trapiantare nella Penisola.
Di una cosa comunque siamo certi. Per quanto si adoperino questi squallidi neoguelfi di borgata, al soldo del loro padrone di sempre, non riusciranno mai a mistificare, come desiderano, il sacro simbolo dell’Aquila Romana. L’Aquila Romana, ci ricorda Dante (Epistola VI, 12) è un’aquila in auro terribilis, un’aquila terribile in campo d’oro, e l’oro in cui si manifesta è il cielo aureo della metafisica imperiale classica. La quale, per analogia, ha bisogno, per essere contemplata, di intelletti acuti ed intrepidi, di intelletti aquilini. Si sia pur certi, quindi, che là ove tale metafisica è assente, l’Aquila Romana, sacra a Giove, non vola. Volerà forse qualche altro pennuto, che non ci riguarda e non ci interessa.
Gherardo Donoratico
Pubblichiamo col consenso dell’autore e con l’aiuto dell’amico Massimo Chiapparini Sacchini le quattro parti del presente saggio uscito per la storica rivista Il Ghibellino (1979 – 1983).
Questa quarta parte era compresa nel Numero 7-8 (ottobre 1982 aprile 1983 e.v.)

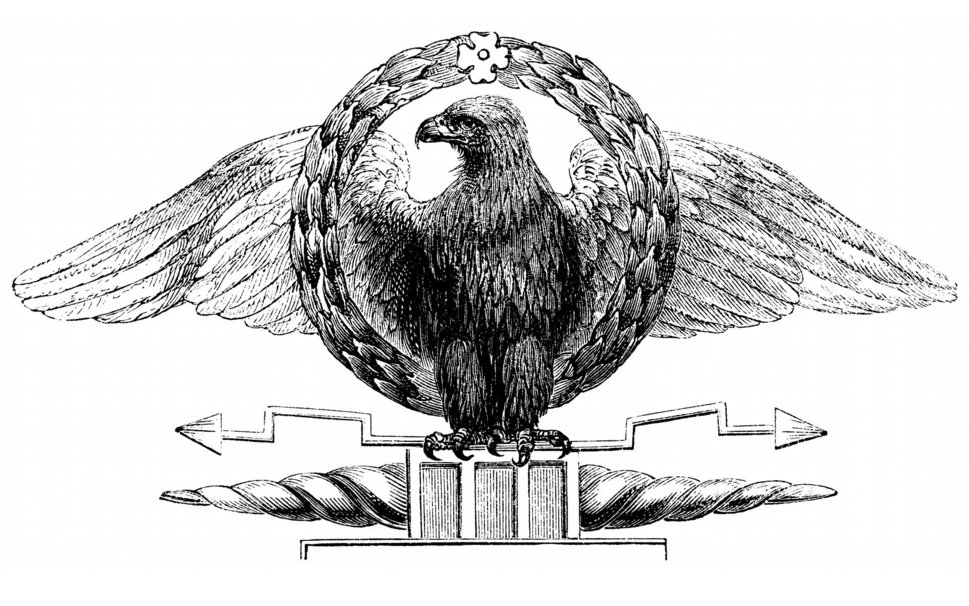



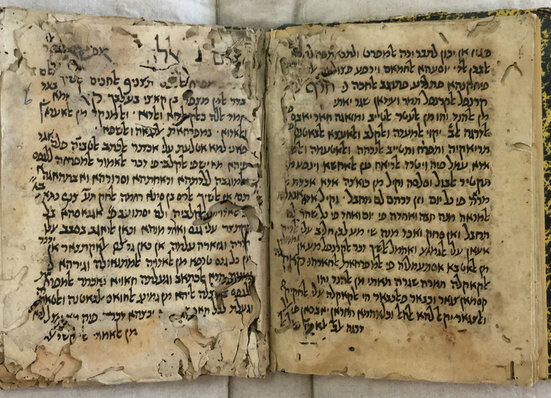
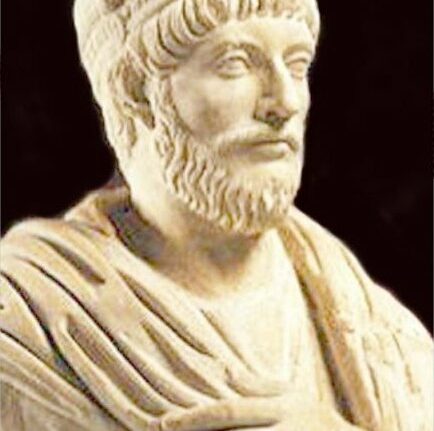

2 Comments