“In un mondo che/ prigioniero è/ il mio canto libero sei tu… “Non ci restano che Mogol e Battisti, il rifugio nel privato e nell’intimo, sottoposti al bombardamento continuo della menzogna, della manipolazione, del capovolgimento della verità. Il resto lo fa il bollore, il fastidio fisico e psicologico della stagione. Serve leggerezza, una licenza temporanea dai temi pesanti.
Ma quale canto può essere libero in un’affollata stazione ferroviaria, in mezzo alla folla transumante “a tutti i suoi retaggi indifferente”, il cui unico obiettivo esistenziale sembra essere il treno delle vacanze? Se pensiamo a come potrebbe essere l’inferno, andiamo a colpo sicuro: è assai simile alla stazione ferroviaria di Milano in estate. Migliaia di persone accalcate che trascinano le valigie, zaino in spalla, in tutte le direzioni, in mezzo a un toboga di negozi carissimi che vendono cattiva merce, ma con il santo marchio. Un’umanità provvisoria, sudaticcia e brandizzata si aggira nei corridoi di quello che fu il capolavoro di Ulisse Stacchini. Plebi umane transumanti, multietniche, unite dalla fretta, dal sudore e dallo straniamento, corrono verso i binari per raggiungere la meta, il treno delle vacanze.
Viene da sorridere alle raccomandazioni che ci raggiungono ovunque, agli altolà terrorifici sul distanziamento sociale, la sanificazione e il rischio dell’orribile contagio. Il morbo infuria, a sentire le gazzette, la situazione è grave, ma non seria. Maledetto il vostro scrivano che non viaggia per necessità o per ferie, ma per presentare un suo libro, l’invito amorevole di amici cui è difficile dire no. Vanità, in fondo, un sentimento umanissimo ma negativo dal quale metteva in guardia Ezra Pound: “strappa da te la vanità, ti dico strappala”. Ecco la punizione: coazione a ripetere, la tendenza incoercibile a porsi in situazioni penose o dolorose senza rendersi conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze. Così recita la definizione, consultata in fretta sul fidato smartphone, di cui ormai siamo la propaggine.
Un viaggio che somiglia all’inferno, folla, chiacchiericcio scomposto, promiscuità, l’inutile tentativo, chiudendo gli occhi, di restare con noi stessi. Ci inseguono, tra gli altri rumori, i continui messaggi dall’altoparlante. Oltre al solito stucchevole benvenuto- ripetuto ad ogni stazione- e alle altrettanto seriali raccomandazioni sull’uso della mascherina FFP2- colpisce l’invito a sottoporre ogni problema al “train manager”. Sì, proprio a codesta strana figura professionale che non è altri che il vecchio capotreno. E dire che il vettore ferroviario si chiama Italo…
Alla terza o quarta ripetizione del messaggio relativo al train manager, scatta l’intuizione. Abbiamo scoperto- o creduto di scoprire- la ragione profonda di questa transumanza, dei comportamenti di massa, delle idee che all’improvviso diventano calamite, di condotte collettive che chi scrive – troppo vecchio e ignorante per capire – non riesce ad accettare. Non è solo lo spirito gregario, la riduzione a sciame umano, la manipolazione subita senza fiatare, la potenza dell’apparato pubblicitario. C’è qualcosa di più e ci sembra di averlo individuato: è la colonizzazione. Dell’immaginario, delle parole, dei comportamenti, dei modi di vita, delle parole.
Non sussiste speranza di riscatto per un popolo che chiama green pass il passaporto vaccinale, lockdown la chiusura della nazione e la prigionia di fatto, week-end il sacro sabato e domenica della corsa al “divertimento”, delle code in autostrada e al gelato nelle località turistiche. Il biglietto diventa ticket e, mannaggia, train manager il ferroviere munito di apparato elettronico per controllare i biglietti su treni simili a siluri o astronavi, ma all’interno scomodi trespoli per viaggiatori trattati come merce immagazzinata. “O macchinista, metti il carbone, quel macchinone fallo partir”. Altri tempi, la cultura popolare sorridente e ingenua è finita, sostituita dal colonialismo- esistenziale e culturale.
L’’identità coloniale è psicologicamente distruttiva. Infatti ci impedisce di essere noi stessi, riconoscere le manipolazioni e soprattutto fa credere di essere uomini – e popoli- di serie B. Il che è purtroppo vero: si può perdere una guerra e non essere colonizzati dal vincitore, continuare a considerarlo un oppressore e un intruso. Oppure – è capitato ai popoli d’ Europa e in particolare al nostro, privo di anticorpi culturali – si può collaborare con il nemico di ieri, lasciarsi assimilare e, per imitazione, servilismo o subalternità, assumere le idee, i modi di essere, vivere e parlare del colonizzatore.
Si desidera essere come lui, diventare indistinguibile, ma l’imitazione è maldestra, il prodotto fallato, un surrogato come la cicoria al posto del caffè. Il mondo coloniale rimane dimezzato, spesso ridicolo nella sua smania mimetica, nella brama comica di essere uguale al modello che si crede scelto ed è invece un’imposizione, una violenza ahimè non più percepita. Alcuni ricorderanno il personaggio di Alberto Sordi Moriconi Nando, ammiratore sperticato di tutto ciò che proveniva dall’America vincente, liberatrice ed occupante. Moriconi vorrebbe farsi piacere il cibo americano, non ci riesce e attacca un succulento piatto di spaghetti. “Maccarone, m’hai provocato e me te magno “fu l’indimenticabile dialogo tra Nando e la pasta.
Erano gli anni Cinquanta del secolo scorso, un’era giurassica. Oggi, se andiamo al cinema, siamo inseguiti dall’odore insopportabile dei popcorn diventati obbligatori compagni della visione. Colonizzazione dell’immaginario, diceva Serge Latouche, che diventa irruzione nei gesti quotidiani, incapacità di vivere la propria esistenza in maniera difforme da quanto prescritto dalla società dello spettacolo organizzata dai colonizzatori. Pare addirittura che certi gesti, determinate attitudini e modalità di vita siano quello a cui aspiravamo segretamente.
Guardiamo il mondo con l’occhio di chi ci ha infilato il cappio al collo- pardon di chi ci ha insegnato nuovi modi di vivere – e finiamo per parlare come lui, in maniera più ridicola. Il capotreno si trasforma in train manager, l’esposizione commerciale in show-room e per qualche ministro di incerta alfabetizzazione anche il virus diventava “vairus”, alla “mericana”. Quasi tutti pronunciano “tiutor” senza ricordare che la parola tutor è latina, non anglosassone. Ignoranza più servilismo più snobismo spicciolo. Snob: parola composta, acronimo latino, s.nob. Sine nobilitate, senza nobiltà.
Parliamo come loro, ma da servi. I più anziani ricorderanno il doppiaggio dei vecchi film americani, in cui gli schiavi delle piantagioni parlavano in maniera macchiettistica, elementare, cercando di adottare il linguaggio dei padroni senza riuscirci, in un penoso grammelot non troppo dissimile dal nostro grugnito che pretende di essere globale, multilingue e avanzato ed è invece una penosa regressione al primitivo. E’ dimenticato chi e come eravamo, anzi non ci poniamo più la domanda, immersi nel presente, assoggettati nei pensieri, nelle parole, nelle opere e perfino nei tic.
L’oppressore diventa modello di riferimento: colpa nostra se non riusciamo ad essere come lui. Sorridiamo pensando alla nostra infanzia, la passione per i film western visti due, tre volte di seguito nei cinema di periferia, un tempo in cui il nostro eroe, John Wayne, lo chiamavamo “vàine”, all’italiana, e i cowboys, in un miscuglio di inglese, italiano e dialetto, diventavano “caiboi”. Non eravamo ancora colonizzati del tutto e il massimo della trasgressione era la gomma da masticare, venduta in esemplari rotondi multicolori dentro recipienti a maniglia. Il chewing gum a Genova si chiamava “ciùngai”, in Toscana “cingomma”: forse i prodotti made in Usa sciacquavano i panni in Arno.
I colti hanno la parola giusta, il concetto sociologico che spiega tutto: siamo passati dall’inculturazione all’acculturazione. In parole semplici, anziché assimilare la cultura della comunità d’appartenenza durante l’età della crescita individuale, abbiamo assorbito, a seguito della conquista e della sovrapposizione-imposizione di modelli estranei, la cultura di un altro popolo. L’ultimo atto, quello decisivo, è assumere- sia pure in maniera derivata e mimetica- la lingua del colonizzatore, un simil inglese raffazzonato, il globish, Colonizzati nell’anima e nella parola, nei comportamenti e nelle abitudini, lo diventiamo anche nelle parole, sebbene in modo ridicolo, come dimostrano il “train manager”, il “dealer” (il venditore, non più commesso o rappresentante) e il “barman”, di cui non si capisce che cos’abbia di più e di diverso dal nostro amico barista.
Il colonizzato è per definizione portatore (in)sano di subalternità e spirito gregario. Non si spiega altrimenti il dilagare di mode prive di significato, tipo i tatuaggi, la dipendenza dall’alcool e dalla droga. Nelle società tradizionali, l’alcool aveva finalità legate al gusto alimentare e alla socializzazione domestica e comunitaria. Oggi è uno strumento di sballo a basso costo. La droga era un pericoloso strumento di sperimentazione culturale per nicchie d’élite o un elemento di liturgie di carattere magico religioso. Adesso si tratta di sostanze utilizzate a scopo di trasgressione (finta), di fuga dalla realtà o di ricerca della prestazione, della “performance”.
I tatuaggi erano indicatori corporei di identificazione, di appartenenza a un particolare ambiente o status. Attualmente non sono che moda estranea ad ogni simbolizzazione, privi di ogni indicatore di distinzione, o addirittura una forma di costruzione del Sé fisico, l’autocreazione attraverso un’individualizzata deprivazione di significati. Un altro elemento che favorisce la colonizzazione culturale è l’ignoranza, a partire dal disconoscimento delle proprie radici e dalla preferenza modaiola per comportamenti o scelte considerate più moderne, “internazionali”. La scuola, sino all’università, ha smesso di trasmettere una cultura e si limita a addestrare a compiti professionali e all’uso degli apparati tecnologici.
Tuttavia, temiamo che esista un elemento in più, che finisce per permeare e contenere ogni altro: la stupidità perseguita, una cretineria di massa sapientemente favorita e manipolata dai pastori del gregge umano. Ne era convinto un economista, Carlo Maria Cipolla, autore del delizioso Le leggi fondamentali della stupidità umana.
I pupari sanno che il gregge è conformista, non guarda oltre il suo naso; se qualcuno indica la luna, invariabilmente osserva il dito e non l’astro del cielo. Non resta che favorire in ogni modo la stupidità attraverso l’uso delle neuroscienze, della programmazione neurolinguistica e della propaganda. Il cretino è imposto come modello comportamentale nella specifica variante del colonizzato: nell’immaginario, nella parola e nei gusti. Cipolla ha involontariamente fornito un formidabile strumento alla classe dei manipolatori. Chi meglio di loro ha preso atto delle cinque leggi della stupidità enunciate dal professore pavese?
La prima è che il numero di persone stupide è sottostimato. In alto lo sanno, e l’errore più grande che possiamo fare è escludere noi stessi dal computo. La seconda legge spazza le illusioni sulla cultura e sul ceto di appartenenza: la probabilità che una persona sia stupida è indipendente dalle altre caratteristiche. Nessun privilegio etnico, di educazione, reddito o idee: la percentuale di stupidi è costante, dal Forum di Davos a noi gente della strada.
La terza legge spiega che uno stupido crea problemi agli altri senza trarne alcun beneficio. E’ la caratteristica più pericolosa. Pensiamo ai delatori, agli “odiatori” delle reti sociali, ai buoni cittadini pronti a seguire alla lettera le indicazioni del potere. Quarto: i non stupidi sottostimano i danni che possono fare gli stupidi. La quinta legge – che riassume le altre- è che lo stupido è la più pericolosa delle categorie umane.
La conclusione è disarmante: se tra la popolazione non stupida la proporzione di mascalzoni e di chi agisce contro i propri interessi è troppo elevata, “allora il paese diventa un inferno”. Stupido e ingenuo, ignorante e manipolato, docile perché disidentificato dai colonizzatori: è il ritratto del cretino coloniale, il più diffuso esemplare umano contemporaneo. Ultimamente, costui ha manifestato un’altra delle caratteristiche gregarie: il bisogno di essere comandato, la ricerca dell’uomo della provvidenza. In Italia il ruolo- non sappiamo se suo malgrado- è esercitato da Mario Draghi.
Sindaci, corporazioni, associazioni professionali, gli ambienti più diversi lo invocano, lo implorano perché resti, affinché – pensando per tutti con l’avallo delle centrali coloniali- ci liberi da ogni responsabilità. Cretini coloniali: sì, siamo davvero all’inferno.

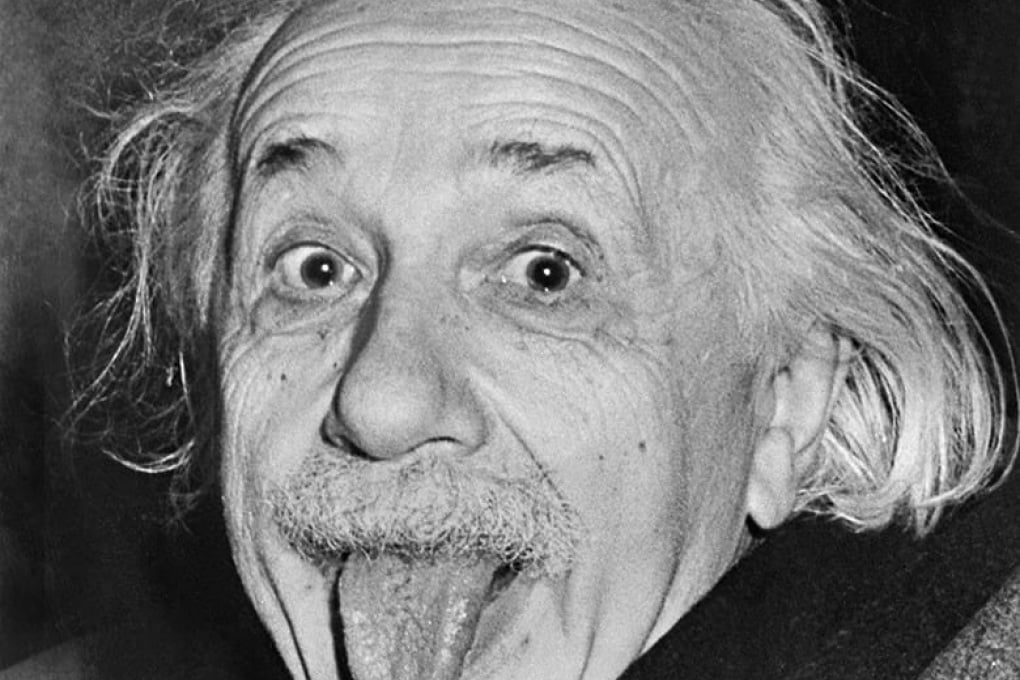



1 Comment