Della serie: anche da credenti e da ferventi cattolici si può essere buoni patrioti. E’ più o meno questo il senso del libro di memorie belliche scritto dal marò del battaglione Fulmine Giovanni Schinetti “Le piume e i rovi – Un cattolico nella Decima Mas”, Novantico editrice, pag 243, compreso un corposo archivio fotografico e una cronologia dei fatti. Un’opera che nell’assenza pressoché totale di dialoghi e di trama assume a volte i connotati del saggio, se non addirittura del diario di guerra. Il teatro d’azione è quello dell’Italia di nord est, Veneto e Friuli Venezia Giulia in primo luogo, avamposti di strenua resistenza – a Fascismo ormai caduto e a Repubblica Sociale agonizzante – da parte di un pugno di italiani e di tedeschi contro il terribile IX Corpus titino lanciato all’assalto del nostro inerme confine orientale.
e stava per morire lo portarono in paese come un trofeo e lui che era di statura dritta e imponente camminava a stento e molto curvo. Suo figlio che era tra la folla imbestialita si avvicinò al padre urlando e chiedendo perché gli avessero fatto quelle torture; Marcello Piccinini si girò verso il figlio e gli accarezzò il volto sul quale rimase un’impronta di sangue. Ormai Marcello non ce la faceva più a stare in piedi. Lo caricarono su una carriola e lo portarono al comune per impiccarlo al pennone della bandiera. Ma questo fu giudicato troppo poco e così lo portarono verso casa sua, che stava addossata alla Rocca Bolognese. Suo padre, seduto su una sedia, davanti alla porta, vide il figlio trapassato dalle scariche dei mitra e dopo pochi mesi morì di crepacuore. Il medico accertò che il corpo di Marcello Piccinini era stato maciullato dalle torture e colpito da più di 40 pallottole>. Ma c’è dell’altro. L’eccidio di Schio, la strage di Bomporto, la vicenda della “corriera fantasma”.





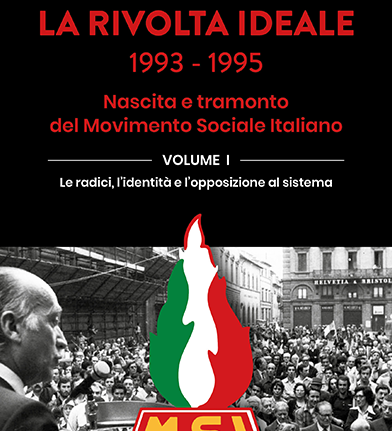
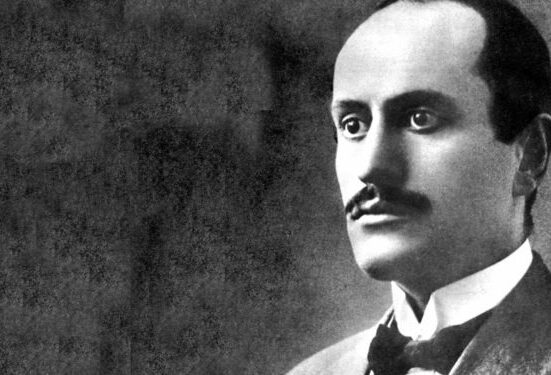
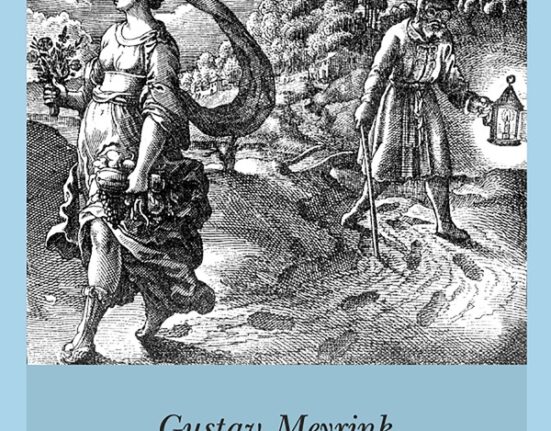
2 Comments