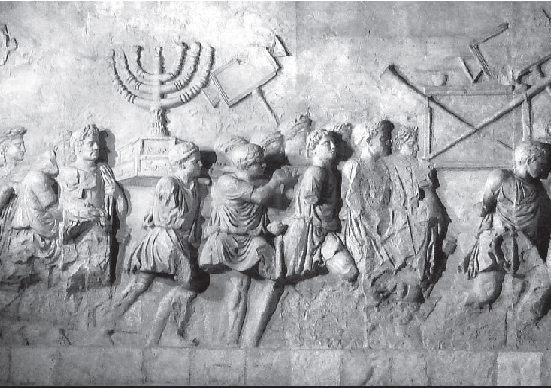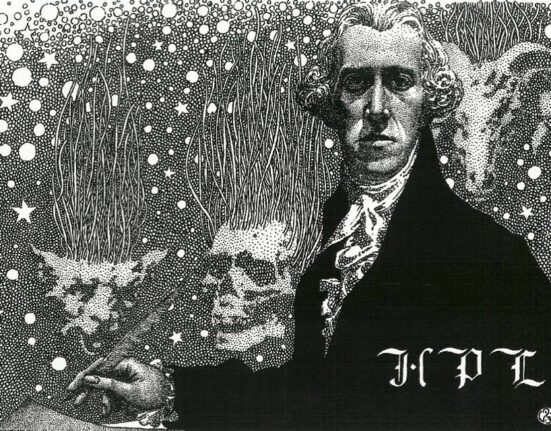Questa testata non è nuova nel pubblicare piccoli racconti segnalatici da estemporanei collaboratori alla ricerca di un piccolo spazio pubblicitario. Il più delle volte siamo costretti a respingere le richieste perchè non cogliamo l’Animus che serve a trascendere il proprio stato d’animo.
Afrit… il racconto breve di Gianluca Padovan è qualcosa di diverso perchè in primis lo abbiamo cercato noi incoraggiandolo e sollecitandolo visto che è un nostro storico collaboratore, a volte polemico, certamente scomodo, ma sappiamo che le sue ricerche, le sue indagini sono frutto di un lavoro meticoloso e ricchissimo di dettagli e non a caso si trova censurati interi lavori degnissimi di finire nelle rotatorie tipografiche. E già, il Nostro caro Gianluca non poco fastidio dà a benpensanti e nostalgici rannicchiati penzoloni come pipistrelli in un angolo buio di una grondaia per non svelare qualche scheletrino che si portano incuranti.
Ai nostri tanti lettori il giudizio finale augurandoci che altra censura non si abbatta inesorabile.
La Redazione
* * * * *
Il Balosso ne masticò la parola, ne assaporò l’essenza fino a ripetersela sommessamente tra le labbra: «Karma… karman… Sì, karman. Chissà che cos’hanno fatto costoro… Meglio dire, forse, cosa non hanno fatto…», ma non andò oltre perché non era in vena di filosofie che lasciano, comunque, il tempo che trovano.
E con il pensiero tornò indietro all’accadimento della mattina. Sembrava quasi che si fosse chiuso un cerchio, con quella frenata, ma in realtà se n’era appena aperto un altro. Maledizione, quando s’apriva un cerchio lo si doveva poi sempre chiudere… quel cerchio!!!
Figure geometriche a parte, ogni tanto, ultimamente in questi mesi, qualche convoglio della Metropolitana Milanese frenava più o meno bruscamente. Soprattutto quelli della Linea Rossa e Verde. Ovvero quelli dei colori della bandiera.
E quando il convoglio in corsa “inchiodava” all’improvviso… la gente veniva proiettata in avanti, ammucchiandosi una sull’altra come in un cartone animato della serie “Gatto Silvestro”.
Il Balosso, come lo chiamavano gli “amici” della Ringhiera, la quale era una delle poche case veramente popolari e di ringhiera rimaste dalle parti nord est di Milano, era per l’appunto su di un convoglio sferragliante nel sottosuolo. Ed ecco che si ritrovò spiattellato tra la fine del vagone metropolitano e un africano enorme che aveva perso la presa e gli era rovinato addosso.
Come dire: tra l’incudine e il martello.
Il Balosso si tirò su come una molla, nonostante gli anni, perché temeva che l’anzianissimo africano palandrato nella tunicona dai colori sgargianti si fosse rotto la testa… dal botto che aveva udito. E invece no, non sanguinava. Ma come inebetito continuava a ripetere con voce stridula: «… L’afrit!… L’afrit!… Aaafrit!» e intanto faticava a tirarsi a sedere nonostante lui lo strattonasse con forza.
«Calma, calma! Non vedo sangue… non s’è fatto niente…» sbraitava nel soccorrerlo. Ma intanto quella parola, “afrit”, non gli era certo sfuggita. L’aveva sentita anni prima, tanti anni prima e per molte volte nei trascorsi, da suo padre, il Cecco. E adesso gli martellava nel cervello. Un po’ come i colpi della mitragliatrice che il suo genitore simulava negli incubi notturni.
La gente attorno, scossa, frastornata, ma soprattutto infuriata, ne stava sbraitando d’ogni colore.
«Ma non è possibile! Ancora!» ululò quello che pareva un punk-bestia un po’ passato di moda e ingrigito nei capelli oramai radi, ma pur sempre irrigiditi nella mistura di gel dall’odore pungente.
«Ah… se mi sentono, diamine se mi sentono appena torno su…» biascicava la signora di mezza età mentre si ricomponeva la lunga e folta chioma scarmigliatasi per la frenata e il “tuffo” in avanti che s’era ritrovata a fare.
«Ma che diamine è successo?!?», lanciò lì un signore tirandosi in piedi e apparentemente senza danno.
Afrit.
Quell’articolazione di suoni l’aveva udita più che chiaramente uscire dalle labbra dell’africano.
Afrit: quella parola faceva tornare il Balosso all’infanzia.
Mano a mano che cresceva scaldando i banchi di scuola, il Balosso aveva imparato ad apprezzare una materia: “Storia”. Difatti una curiosità lo stimolava, ovvero quella di sapere che avesse fatto il padre da giovane, ovvero il Cecco, per non volerne parlare. L’unica cosa nota era che aveva combattuto in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale.
Quindi da grandicello il Balosso cominciò a frequentare la bibliotechina di quartiere per raggranellare ulteriori informazioni su quel teatro di guerra africano tanto distante, eppure sempre vicino agli incubi paterni. La migliore fonte d’informazione avrebbe potuto essere la madre… ma anche lei si dimostrava reticente. Eppure era insegnante di “Storia” e doveva ben saperle quelle cose che a lui tanto premeva di conoscere.
Gli pareva che il “destino” gli giocasse, anche e soprattutto in casa, i soliti scherzi. Una mamma insegnante di “Storia” che non voleva parlare di Storia al proprio figlio!
Il colmo!
«Dai, Ma’, racconta degli incubi di guerra di Pa’…» la incalzava il Balosso quando il genitore era assente.
«Ma dai tu, Giovanni, tira via…» faceva di rimando sua madre.
Fu solo dopo la dipartita del Cecco, a onor del vero un po’ prematura, che sua moglie aveva sciolto i lacci della borsa dei ricordi, tanto rapidamente quanto candidamente, come per liberare la zavorra d’una mongolfiera dalla tanta sabbia e volare poi via, per raggiungerlo.
Sia come sia, una sera, davanti al piatto di brodo di pollo, con gli “occhioni” gialli di grasso che vi galleggiavano dentro, si sciolse.
«Soffriva d’incubi ricorrenti, il tuo povero padre…» gli disse con un filo di voce portando il cucchiaio alle labbra e soffiando piano sul brodino rovente.
«Sì, Ma’, questo lo so digià… ma vai avanti…» biascicava il Balosso ficcandosi in bocca un gran pezzo di pane inzuppato nella minestra e incurante del bollore.
«S’era appena sposati… Talune notti, sdraiato nel letto, quasi rigido, con le mani strette a pugno aveva gl’incubi e tremava… sognava e s’agitava tutto…».
«E allora?!», impietoso il Balosso.
«Allora niente… gli pareva d’avere ancora tra le mani la mitragliatrice e faceva con la bocca il tatatatatatam… mentre “sparava”…».
Il padre aveva proprio fatto la guerra.
Il Cecco frequentava la scuola professionale e si era nel 1940, quando fece cambiare direzione alla propria vita. Durante una lezione un professorone dai radi capelli impomatati affermò pomposamente che il suolo d’Italia… «… il Sacro suolo dell’Impero! Perdincibacco …» andava difeso.
Lui, il Cecco, si era sentito come investito d’un obbligo ancestrale. E aveva risposto arruolandosi, ma falsificando la sua data di nascita perché aveva solo 16 anni. Andò in quelli che la storia avrebbe ricordato da una parte e bollato dall’altra come i “ragazzi di Mussolini”. O, più correttamente, i “Ragazzi di Bir el-Gobi”.
Già, difatti Mussolini li aveva in urta perché loro, il loro cuore, volevano veramente “gettarlo oltre l’ostacolo”!
Circa ventiquattromila se n’erano arruolati volontari, tant’è che il Partito Nazionale Fascista rimase seriamente impensierito al punto che dopo averli sfiancati sui campi d’addestramento e fatti sparare con quei fuciletti ridicoli con cui s’era armato il “bellicoso sulla carta” Regio Esercito, li volevano rimandare a casa a nettarsi il moccio.
Dopo qualche parapiglia s’era pervenuti all’italica soluzione, quella del compromesso: duemila vennero arruolati e spediti al fronte, ma non subito. Ai restanti ventiduemila furono rilasciati attestato e medaglietta come se avessero partecipato alla “Stramilano”. Suo padre fu tra coloro che partirono per il fronte, per l’Africa del Nord. Suo padre, il Cecco, s’era fatto proprio il “Nordafrica” e fin quasi alla fine… poveraccio!
«Dai, Ma’!», ripeteva il Balosso, «Possibile che non t’abbia raccontato altro?».
«Sì, mi diceva che per giungere in Africa fecero un calvario, la sua nave colò a picco per un siluro inglese e una volta tra la sabbia… fu un vero disastro. Si rendevano conto che erano messi male e anche se giovani le cose le vedevano ben chiare».
Nel 1941 il tutto e per tutto si stava giocando a cavallo tra Libia ed Egitto, con a sud l’indomabile presidio di Giarabub, o meglio Jaghbub, tenuto da un pugno di soldati italiani coadiuvati da arabi locali. Quelli sì che ne avrebbero visti di “Afrit”… e parecchi!
A metà novembre, sempre del 1941, le truppe inglesi e del Commonwealth scatenarono una prima offensiva, denominata “Operazione Crusader”, la quale non doveva sortire grande effetto in quanto non sarebbe riuscita a liberare le proprie truppe accerchiate a Tobruk. S’avviava così la “Battaglia della Marmarica”.
Cucchiaio dopo cucchiaio, continuando a soffiare sulla minestra, la mamma del Balosso borbottò tenuamente: «Ricordo bene che il 28 novembre 1941 le truppe italiane dietro ordini superiori del Comando R.E.C.A.M., ovvero quello italiano, abbandonarono senza spiegazione l’importante caposaldo di el-Duda, lasciando il generale tedesco Erwin Rommel del D.A.K., ovvero della Division Afrika Korps, sbalordito e infuriato». Fece una pausa e sollevò lo sguardo dolce, emanato da quegli occhi grandi e azzurrissimi, capendo forse che alla fin fine, prima d’andarsene, le cose al figlio avrebbe dovuto raccontargliele.
Solo che non sapeva se fosse il caso di raccontargliela proprio tutta… la Storia, e non già quella che aveva per tanti anni insegnato a scuola: quella era solo “storia”.
E così riprese: «Alla fine di novembre le truppe inglesi riuscirono a congiungersi con quelle assediate a Tobruk e le forze tedesche tentarono, a quel punto, di tamponare la falla nello schieramento e passare al contrattacco, assieme alle forze corazzate italiane mal guidate e peggio armate. L’unica cosa degna di nota era che gli equipaggi dei carri italiani erano capaci e agguerriti, rendendo meglio sul campo se gli “alti comandi” italiani se ne stavano in silenzio».
Emise un sospiro, forse ricordando il suo povero padre… carrista. Il nonno materno del Balosso, perché sottacerlo, era morto in Cirenaica, arso vivo nel suo carro armato e proprio in quell’inverno del ’41.
La madre gira e rigira il cucchiaio nel piatto oramai vuoto e riprende: «Nel frattempo il Gruppo Battaglioni Giovani Fascisti, composto da I Battaglione e II Battaglione, s’incamminava per attestarsi a Bir el-Gobi, giungendovi rispettivamente il secondo e il primo giorno di dicembre».
“Bir” indicava l’esistenza di un pozzo d’acqua potabile, preziosissimo in quel mare di sabbia e di rocce calcinate; accanto vi era una baracca di legno e muratura, misera ma resistente al Ghibli, il vento del deserto.
«L’accerchiamento di tutti quei ragazzi da parte delle truppe avversarie avvenne rapidamente e tuo padre lo ripeteva sempre… E qualcheduno affermava, con rabbia, che nelle “alte sfere” italiane qualcheduno, o tutti, volevano vederli cancellati, tolti di mezzo il più rapidamente possibile…».
Forse perché il loro spirito rischiava di essere contagioso facendo correre il rischio alle “alte sfere” di vedere l’Italia vittoriosa, anche se mai e poi mai avrebbe dovuto entrare in guerra.
La seconda offensiva inglese prendeva così il via e il pomeriggio del giorno 3 dicembre le postazioni scavate a Bir el-Gobi sulle quote 182, 184 e 188 vennero cannoneggiate. Per i Giovani dei due battaglioni sarebbe stato il “battesimo del fuoco”, il primo scontro della loro vita.
E anche gli Inglesi lo sapevano, ironizzando alla radio che l’Italia non aveva più uomini e mandava al fronte, in Marmarica, i ragazzi, degli “sbarbati” con in testa il berretto con la nappina, ovvero il fez.
Qualcheduno poi scrisse che il generale sir Claude Auchinleck affermava che gli Italiani avrebbero disertato la lotta, lasciando che se la vedessero i Tedeschi, i quali sarebbero stati inevitabilmente accerchiati e schiacciati una volta per tutte ponendo fine alla guerra tra le dune.
D’altra parte, perché negarlo, il comandante in capo italiano, il generale Gastone Gambara, era quello che aveva fatto infuriare Rommel facendogli urlare fuori di senno: «Dove diavolo è finito quel b…?!?».
Intanto Gambara aveva ordinato al generale Piazzoni d’interrompere il contatto con gl’Inglesi e di ripiegare su Bu-Cremisa, forse per non “contraddire” Auchinleck. E ovviamente tra comunicati italiani, dispacci e chiacchiere da salotto non si accennava minimamente al fatto che i “Giovani Fascisti” erano appena stati accerchiati e attaccati niente meno che dal generale Anderson. Costui era a capo dell’11a Brigata Indiana, forte di qualche migliaio di uomini, con carri armati, autoblindo, artiglierie, etc., seguita da rinforzi costituiti dall’8th Royal Tank Regiment, il 7th Medium Regiment Artillery e un sacco di soldati ancora.
In pratica il silenzio dei comandi italiani era semplicemente e inequivocabilmente il requiem ben architettato che infine si suonava.
Fine 1^ parte