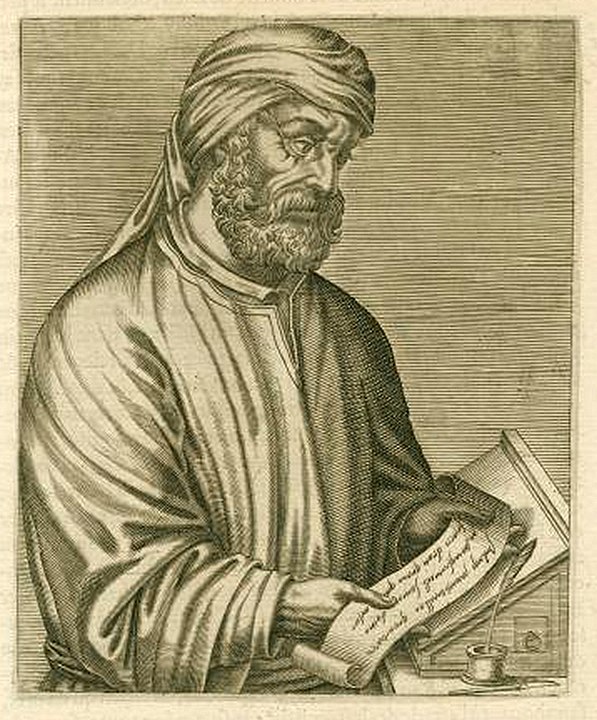Leggiamo il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 10:
1 “In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. 2 Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. 3 Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. 4 E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. 5 Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 6 Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro.
7 Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. 8 Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9 Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 10 Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 11 Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 12 Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; 13 egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. 14 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15 come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore (…)”.
Si tratta del discorso di Gesù Buon Pastore. Siamo nel giorno culminante della Festa delle Tende, commemorazione ebraica che ricorda il passaggio miracoloso del popolo giudaico nel deserto vivendo nelle tende e che la Presenza di Dio era discesa nel deserto abitando nella Tenda dell’Incontro. Non si possono capire a fondo i vangeli senza approfondire il sottofondo costituito dalle feste ebraiche. Spesso gli evangelisti non spiegano questo sostrato in quanto i primi uditori del vangelo erano ebrei, i quali capivano i simboli di quella religione dalla quale proveniva lo stesso Cristo per poi distaccarsene.
In Giovanni 9 siamo nel giorno solenne della festività in questione, che tratta della guarigione del cieco nato, che venne cacciato fuori dal tempio dai giudei (versetto 35): quindi Gesù inizia a parlare (anche al cieco nato), e questo discorso continua nel capitolo 10, quindi gli studiosi sostengono che pure il discorso del Buon Pastore sia stato pronunciato nel giorno culminante della Festa delle Tende. I capitoli e i versetti della Bibbia non sono stati così stabiliti dagli autori, ma sono molto posteriori, quindi si pensa erroneamente che i capitoli contengano sempre tematiche diverse, ma in realtà spesso non è così.
Gesù pronuncia questo discorso davanti al cieco nato, che è stato cacciato fuori dal tempio, questo giustifica il richiamo al recinto delle pecore. Non sono i giudei i veri pastori in quanto sono ladri e briganti poiché cacciano chi ha bisogno di loro. Invece Gesù, che compie il miracolo nei confronti di quell’infelice, è il vero pastore. Gli esegeti osservano che Gesù sta parlando di una situazione negativa abituale, che da sempre affligge il gregge: così si spiega la mancanza dell’articolo e il singolare “ladro e predone”.
Gesù si rivela come vero pastore di fronte a una ingiustizia. L’espressione “in verità in verità” è tipica di Giovanni per introdurre una dichiarazione solenne, che deve essere creduta. Infatti abbiamo nel vangelo la ripetizione del termine ebraico amēn (traslitterato in caratteri greci), che deriva dal verbo ebraico emin, “credere”. In ebraico amēn è un aggettivo che significa “credente”. È significativo che in aramaico la stessa parola vuol dire “verità”.
Cristo rivela squisitamente sé stesso, con le opere e con la parola, quando il male compie il culmine della propria opera. È veramente significativo: e questo in quanto “il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo” (1Giovanni 3, 8).
Al versetto 4 di Giovanni 10 si dice che il Buon Pastore “caccia fuori” le pecore, si usa il verbo greco exballein, lo stesso che usa Giovanni in 9, 35 relativamente alla cacciata del cieco nato dal tempio ad opera dei giudei. Probabilmente si tratta di una classica ironia giovannea: i giudei compiono una ingiustizia e Gesù compie un’opera di salvezza specularmente opposta.
Gesù Cristo rivela di essere la Porta dell’ovile, e al versetto 7 Gesù dice loro che egli è la Porta delle Pecore. Il riferimento alla “porta” è tipicamente semitico: gli antichi ebrei consideravano la porta della città come una delle strutture più rilevanti, era un municipio sotto il quale fare contratti e compravendite varie; era vista quale un luogo santo che doveva essere protetto dai demoni, per questo si scagliavano frecce contro la porta, con lo scopo cioè di dissuadere i diavoli dall’entrare nella città; la porta è anche un simbolo della fede, di colui che dà la vera dottrina, gli ulema musulmani erano detti in arabo Bab, “porta”.
Ma l’espressione “porta delle pecore” è un passo in avanti, in quanto è sicuramente un riferimento, molto chiaro agli ebrei di allora, relativamente alla salvezza finale. In Neemia 3 è scritto che il popolo ritorna dall’esilio babilonese e ricomincia a costruire Gerusalemme precisamente dalla Porta delle Pecore, uno degli accessi alla città di Gerusalemme (citata anche in Giovanni 5). Solo due tribù fecero ritorno a Gerusalemme, le altre erano disperse: il Messia dovrà, secondo gli ebrei, far ritornare anche i dispersi e soprattutto ricostruire il tempio, come cantano ancora oggi nella importantissima preghiera della Amidah. È quello che prospetta Giovanni nell’Apocalisse dove si profetizza che alla fine dei tempi ci sarà una nuova Gerusalemme, quindi anche un nuovo tempio, e questo tempio altro non è che l’Agnello, Cristo stesso.
In Genesi 28 Giacobbe, mentre dorme, sogna una scala, ma il termine ebraico può indicare anche una strada o addirittura una porta, sulla quale salgono e scendono gli angeli di Dio, probabilmente una immagine della Presenza trascendente di Dio, quindi Giacobbe dice che quella è la Casa di Dio, la Porta del Cielo. secondo la tradizione, la pietra su cui dorme Giacobbe è quella centrale su cui verrà edificato il tempio di Gerusalemme. Ebbene in Giovanni 1, 51 Gesù stesso applica a sé tale mistero: “Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo»”. Attraverso Gesù si entra nel Cielo, nella salvezza. In ebraico il termine “Gerusalemme” è un duale, indica cioè due realtà: c’è una Gerusalemme terrestre (presente nell’Antico Testamento) e una Gerusalemme celeste, la salvezza finale offerta da Cristo, nuova e ultima Porta delle Pecore.
La Porta delle Pecore conduceva al tempio di Gerusalemme. Pertanto gli studiosi ipotizzano che, mediante una tipica metonimia del linguaggio semitico, Gesù, definendosi in questa maniera, sta dicendo di essere il nuovo tempio, quello perfetto. Si salva solo colui che passa attraverso Cristo. Giovanni 14, 6: “Io sono Via, Verità e Vita”.
Durante la traversata del deserto il Signore YHWH scendeva tra il popolo ebraico nella Tenda dell’Incontro, il santuario mobile che si spostava con quei nomadi. In Giovanni 1, 14 si dice espressamente che Cristo “venne ad abitare tra di noi”, nell’originale greco abbiamo eskēnōsen en ēmin, dove il verbo greco (aoristo) contiene la radice di skēnē, “tenda”, quindi letteralmente vuol dire “mise la tenda”: come YHWH scese nella Tenda dell’Incontro, così Cristo scese nell’umanità. Nel capitolo 10 Giovanni richiama certamente il passo di 1, 14: è Cristo il tempio nel quale fare esperienza della salvezza di Dio. Secondo alcuni autori, il verbo greco alluderebbe addirittura all’importante termine rabbinico Shekinah, la Presenza di Dio nel tempio di Gerusalemme. In Giovanni 2, 19 Gesù, riferendosi a sé stesso, dice: “Distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò”.
Il termine “recinto” è assai significativo, in greco aulē, che indica soprattutto il recinto di una abitazione (e raramente di un ovile) e nella versione greca della Settanta denota molto spesso l’atrio del tempio. Forse Gesù sta istituendo un doppio senso. Giovanni, infatti, dichiara al versetto 6 che Gesù sta facendo una “similitudine” (in greco paroimia), termine che traduce l’ebraico mashal, che ha accezioni molto più numerose, tra cui enigma.
“7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore … ” (in greco eipen oun palin o Iēsous, Amēn amēn legō umin oti egō eimi ē thura tōn probatōn): la lezione sahidica è “o poimēn”, “il pastore” (“io sono il pastore”), che trova un forte sostegno in P72, ed è inoltre attestata in due manoscritti copti. Quindi la lezione “io sono la porta delle pecore” dovrebbe essere una aggiunta posteriore. Ma non tutti concordano. Chi la ritiene posteriore, adduce come argomento che linguisticamente il genitivo tōn probatōn è irregolare; che non è giovanneo l’oti, che altrove manca sempre davanti a un egō enfatico. Si osserva anche che la figura della porta è una cara immagine gnostica. Tuttavia “la porta delle pecore” potrebbe essere un richiamo che Gesù fa del Salmo 118, 20: “Questa è la porta del Signore, soltanto i giusti vi possono entrare”, che dalla tradizione ebraica veniva già interpretato in chiave messianica.
Gesù chiama per nome le sue pecore: si tratta di una espressione semitica che indica dominio, come quando i progenitori diedero nome alle creature di Dio, agli animali. Ma dare nome è anche l’atto divino della creazione: nel mondo semitico il nome (in ebraico shem) è la persona stessa, la sua essenza, quindi dare il nome indica la creazione e pure la ri-creazione, come quando Cristo cambia nome dell’apostolo da Simone a Pietro. Non solo, si tratta anche di un gesto molto tenero, in quanto allude alla prassi dei beduini di dare nome alle proprie pecore. Per il beduino di allora il gregge era tutto quello che possedeva, rivestiva ai suoi occhi una importanza capitale, quindi provava affetto.
Inoltre Gesù “fa uscire” le pecore, in greco exagein (versetto 3), probabilmente è un riferimento all’esodo, la pagina capitale della storia del popolo ebraico, quando Dio strappa gli ebrei dalla schiavitù egiziana e li invita al servizio di Lui medesimo. Adesso Gesù inaugura l’esodo ultimo, Gesù trasporta i suoi fedeli in Cielo. Ci sarebbe anche un’altra sfumatura, tipicamente semitica: Gesù fa entrare (è la Porta) e fa uscire, si tratta di un polarismo, si esprimono due opposti (entrare-uscire) per indicare in realtà tutto ciò che sta in mezzo, quindi Cristo dona pienezza del bene, è il Buon Pastore che non si ferma solamente a donare la salvezza finale ma conferisce la Pace messianica (shalom), termine ebraico che indica etimologicamente la “perfezione”, la “totalità” delle realtà positive donate dal Messia, anche su questa terra. Non per nulla nel Talmud si dice che è un peccato privarsi dei piaceri leciti. Giovanni non parla di “buon pastore” ma usa l’aggettivo greco kalòs, che traduce l’ebraico tov, “bello/buono”, come condensato di tutte le realtà positive di una persona e delle opere che questa compie.
Interessante che Gesù Buon Pastore cammina davanti al gregge. La prassi nella pastorizia di allora è che il pastore camminasse dietro le pecore per tenerle d’occhio, anche se a volte la cosa è oscillante. Comunque sia camminare, davanti allude alla stretta unione tra pastore e gregge: per il beduino le pecore possedute costituiscono nientemeno che la vita, l’unica fonte di sussistenza.
Già il profeta Michea al capitolo 2 profetizzava:
“12 Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe,
certo ti raccoglierò, resto di Israele.
Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto,
come una mandria in mezzo al pascolo,
dove muggisca lontano dagli uomini.
13 Chi ha aperto la breccia li precederà;
forzeranno e varcheranno la porta
e usciranno per essa;
marcerà il loro re innanzi a loro
e il Signore sarà alla loro testa”.
Nel I Libro di Enoch, apocrifo dell’Antico Testamento redatto prima della nascita di Cristo, si tramanda un sogno in cui il popolo ebraico è paragonato a un gregge di pecore accecate che recuperano la vista per opera del Signore che dà loro acqua e luce (i due elementi fondamentali della Festa delle Tende). Sempre secondo Enoch, il Signore caccia i lupi che assediano le pecore e li acceca e quindi raduna le pecore nel cortile del tempio.
Pensiamo anche al Salmo 23:
“Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni”.
In questa breve lirica il salmista canta che Dio è il suo pastore, che ha deciso di partire spostandosi verso una nuova oasi, poi sorge una gola oscura, quindi abbiamo menzione del pericolo, ma il pastore procede sicuro. Pertanto il gregge che lo segue si aspetta di raggiungere le “acque tranquille”, letteralmente “acque di riposo”, in ebraico me menuḥot, dove il sostantivo ebraico “riposo” (menuḥah) non è quello idilliaco di Teocrito ma allude a quello eterno. In questa oasi si imbandisce un pasto, che allude al tempio di Gerusalemme: quando si sacrificava a Dio il rito prevedeva un pasto sacro. Il salmista quindi sta dicendo che Dio è il pastore che concede la salvezza nel tempio, in quanto esso è la Casa di Dio.
In Ezechiele 34 si contrappone il pastore (che è Dio) ai pastori, che sono i responsabili dello stato. Si tratta di una immagine nota nell’antichità, già Omero parlava di poimēnes laōn, “pastori di popoli” in riferimento ai governanti. Quando i governanti vedono la pecora umiliata e ferita la abbandonano, ma non così fa Dio.
Gesù afferma, infatti, che tra pastore e pecore c’è conoscenza, ma in ebraico il “conoscere”, espresso dal verbo yadà, non indica tanto un’attività intellettuale quanto piuttosto la relazione intima tra due entità, come è comune in tutto il Vicino Oriente. Nell’egiziano antico uno stesso verbo, rekh, indica sia il sapere sia l’amare, cambiando il determinativo.
La “conoscenza” che si instaura tra il pastore e il gregge fa sì che Gesù offra la vita per il gregge. L’espressione “offrire la vita” è ebraica, masar nafsho, letteralmente “dare la propria anima”, dove il verbo ebraico è più di un semplice “dare”, “offrire”, richiama il significato del verbo latino tradĕre, “consegnare” per sempre. Nei vangeli la espressione “dare la vita” compare solo in Giovanni: qui (“la vita di me consegno”, in greco tēn psuchēn mou tithēmi) e sulla croce, in questo ultimo caso con una leggera variante (19, 30: “consegnò lo spirito”, in greco paredōken to pneuma). Giovanni allude al IV Carme del Servo di YHWH di Isaia 53, in cui questo personaggio misterioso è pronto a offrire sé stesso, come un agnello che non emette beato condotto al macello.
In Osea 6, 6 Dio proclama in ebraico:
ḥesed ḥafasti velò zabaḥ
weda’at ‘Elohim me’olot
“Io desidero amore, non sacrifici,
e la conoscenza di Dio più degli olocausti”.
La conoscenza di cui parla Osea si spiega con l’amore (ḥesed) del primo membro del parallelismo.
Secondo una interpretazione, le religioni sono tutte la manifestazione di uno stesso Dio “pazzo di amore” per le sue creature, come dicono i mistici cristiani. Dio non si accontenta di avere degli automi ai quali dare ordini, ma vuole creature libere che, sperimentando la sua Provvidenza, si accorgano di questo Padre Buono e inizino ad amarlo con tutto il cuore.
È significativo a tal riguardo il rito del battesimo. Essere aspersi dall’acqua e quindi introdotti tra i cristiani.
In tutte le religioni l’acqua è un simbolo positivo, specie nella Bibbia, viste le condizioni geoclimatiche di aridità. In Ezechiele 47 dal tempio fuoriescono quattro fiumi le cui acque si espandono su tutta la terra e la rigenerano. Gesù stesso dirà di essere l’ “acqua viva” (Giovanni 4).
In India, dai primi Veda, i testi sacri dell’induismo, fino al mondo moderno, l’acqua è la dimora delle divinità. In Rg-Veda X.129.3 è scritto in sanscrito vedico in metro nicṛttriṣṭup:
tama āsīt tamasā gūḻham agre ‘praketaṃ salilaṃ sarvam ā idam
“In principio vi era solo tenebra nascosta dalla tenebra, acqua indistinta era tutto questo universo”.
Secondo la mitologia induista, l’universo, che contiene in sé innumerevoli mondi, segue dei cicli continui di nascita e dissoluzione, stabiliti da una energia divina onnicreatrice e eterna. Quindi dire che in principio vi era solo acqua significa dire che questa energia divina, il Brahman, abitava nelle acque.
Ancora nell’India moderna durante i riti casalinghi si pone vicino all’altare una bacinella colma di acqua e per tutta la celebrazione si crede che il dio dimori in quel liquido. Ricordiamo che l’induismo non è una religione politeistica come può essere quella greco-romana, si ritiene infatti che le diverse divinità del pantheon siano aspetti dell’unica energia divina.
Nell’induismo il simbolo dell’acqua è il serpente (nāga) ed è significativo che Viṣṇu, l’aspetto dell’unica divinità che più la esprime, viene raffigurato spesso come dormente sopra le spire di un gigantesco serpente.
Attualmente il culto di Viṣṇu è il più diffuso fra gli hindu; questo successo si può spiegare con il ruolo di Viṣṇu come reggente del cosmo, pertanto, essendo questa era cosmica un’era di mantenimento – non di creazione (Brahma) o distruzione (Shiva) – il ruolo di supervisione di Viṣṇu come amorevole signore gli garantisce un grande seguito. Viṣṇu è colui che preserva lo status quo, in una società conservatrice come quella indiana il mantenimento degli standard ortodossi contro le contaminazioni e le impurità è estremamente importante. Viṣṇu è l’incarnazione dei valori fondamentali della società hindu, è il capofamiglia ideale che protegge e promuove il bene della famiglia e della casta. Il grande successo di questa divinità è, infine, dovuto al suo carattere di dio di amore e devozione, caratteristiche associate in particolare ad alcune sue incarnazioni (avatara).
Il nome Viṣṇu viene dalla radice viṣ = “entrare”, “pervadere” ad indicare il suo carattere onnipervadente. Questo nome è già noto nei Veda, in cui appare come divinità benefica e aiutante di Indra, il dio più importante nella mitologia vedica. La dimora di Viṣṇu è nell’alto dei cieli, cosa che implica una connessione solare. Il Viṣṇu vedico è già connesso al mito dell’attraversamento dell’intero universo in soli tre passi che troveremo nel mito dell’avatara del nano.
La rappresentazione standard di Viṣṇu è quella di divinità stante in abbigliamento regale con quattro braccia. Il copricapo di Viṣṇu kiritamukuta è una alta corona. Nelle sue quattro braccia, il dio regge altrettanti attributi in ordine variabile, dando vita a 24 combinazioni possibili corrispondenti ad altrettanti aspetti particolari della divinità. I suoi attributi sono il disco (chakra), la conchiglia (shanka), la mazza (gada) e il fiore di loto (padma). Spesso una delle mani è vuota e nel gesto della generosità (varadamudra) o della rassicurazione (abhayamudra). Talvolta gli attributi delle mani inferiori sono rappresentati in forma antropomorfa di dimensioni nettamente minori rispetto al dio che gli tiene la mano appoggiata sulla testa. La conchiglia e il fiore di loto sono chiari simboli di una sua connessione con l’elemento dell’acqua.
L’asceta mendicante dell’induismo (l’iniziato) viene detto haṃsa, che in sanscrito vuol dire Oca. L’Oca è come Viṣṇu: galleggia sulle acque e vola fino al sole. È simbolo anche della doppia natura dell’iniziato: è un uomo ma ha accesso al potere superiore che gli conferisce il suo grado. Gli uomini hanno sia un io individuale (che è fittizio) sia il Sé, in sanscrito ātman, che costituisce l’anima, la essenza divina nell’uomo, la quale coincide con il Brahman. L’iniziato continua ad avere un aspetto individuale ma ha raggiunto un collegamento più potente con la propria anima.
Secondo un mito indiano, nel ripete “haṃsa, haṃsa …”, si finisce con il dire “so ‘ham” (abbiamo il fenomeno fonetico che i grammatici indiani denominano avagraha, elisione). So significa “questo” e aham significa “io”: “Io (sono) questo”, vuol dire che nell’iniziato l’io individuale sperimenta meglio del profano la presenza di Questo, Tad, denominazione sacrale dell’ātman/Brahman.
Ma le acque sono anche il simbolo del Male, del nulla e del caos. Nel luogo più sacro del tempio egiziano vi era una piccola imbarcazione che galleggiava in una vasca ricolma di acqua: la barca è il simbolo della creazione divina che si oppone e si staglia quasi contro l’Oceano primordiale che cerca di distruggere tutto e tutti. Nella Bibbia le “grandi acque” indicano il nulla che batte continuamente attentando alla creazione. Nei miti babilonesi Tiamat è il mostro-regina dell’oceano e dell’abisso, i quali tentano di scardinare l’ordine del creato. Da Tiamat deriva il termine ebraico tehom, “abisso”, che compare nelle righe iniziali della Genesi.
Nell’antico Egitto il re defunto veniva tumulato in una piramide le cui pareti erano incise con segni geroglifici, sono i cosiddetti Testi delle Piramidi. Quei segni avevano la funzione di guidare il re nel viaggio nell’oltretomba per la trasformazione in una divinità, nella fattispecie una stella, è il cosiddetto catasterismo. In uno di questi antichi testi (formula 214) è scritto in antico egiziano: zA.kw sj, “guardati dalle acque”.
Il verbo zA significa “guardarsi da, proteggersi da”. Nel passaggio dall’antico egiziano al medio egiziano fino al copto si perde la sonorità delle coppie sorde/sonore. La prima perdita che si verifica è il passaggio da /z/ a /s/, vale a dire che la /z/ dell’antico egiziano si muta in /s/ del medio egiziano, la fase classica della lingua. La forma zA.kw è un imperativo (zA) con pronome suffisso accusativo (-kw). Questa formula ricorre uguale in varie piramidi: quindi alcuni re hanno zA.kw, invece altri re hanno la forma zA.k. Perché? Errore scribale. Oppure può essere una riformulazione del verbo: nel primo caso abbiamo un imperativo con accusativo (guarda te stesso, forma riflessiva), nel secondo caso abbiamo un congiuntivo esortativo (guardati, sDm=f attiva).
Il sostantivo sj vuole dire “bacino, lago, piscina”. La formula dice di fare attenzione a sj in quanto nell’Aldilà la materia acquosa è un potente strumento malvagio contro il catasterismo del re. Il re risorge non per ritornare sulla terra ma per indiarsi, cioè per diventare completamente una divinità e risiedere nel mondo dei beati, nell’Aldilà, dove ci sono anche entità negative e il Male.
Cantico 8, 7 declama in ebraico:
mayim rabbim lo yukelu lekabbot ‘et ha’ahabah wneharot lo yishtpuha
“Le grandi acque non potrebbero spegnere l’amore, e dei fiumi non potrebbero sommergerlo”.
Ma tra le acque buone da una parte (la grazia di Dio) e le acque malvage dall’altra (le opere dei diavoli) prevarrà sempre la salvezza opera da Cristo, che ha fondato l’ultima religione, quella perfetta. I teologi cristiani sostengono che anche coloro che praticano un’altra religione, se seguono i dettami della legge naturale che Dio scrive nel cuore di ogni uomo, possono salvarsi, ma sempre per i meriti del sacrificio di Cristo, l’Uomo Dio incarnato nel nostro mondo per ottenerci il paradiso.
L’anima delle persone si evolve nel tempo e le varie religioni hanno bisogno di adattarsi allo spirito dei tempi sempre nuovi. Per questo ciò che valeva una volta non vale ai nostri giorni. Tutte le religioni si evolvono. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
L’induismo viene considerato la religione più antica, sebbene non esista come entità unitaria. Nel passato in India tutti praticavano il metodo del karma, il “sacrificio” pubblico officiato dai sacerdoti, termine sanscrito che letteralmente vuol dire “azione”, dal verbo kṛ-, “fare”, “creare”, donde il latino creo, come a dire che la azione più importante è il sacrifico vedico. Ma ad un certo punto l’animo delle persone cambiò e ciò che era adatto allora perse di importanza, quindi si iniziò ad usare il metodo della jñāṇa, “conoscenza”, come presentizzazione intuitiva delle divinità nel cuore del fedele. Oggigiorno anche questo non è più valido e si usa il metodo della bhakti, cioè la devozione personale alla divinità, termine sanscrito che tra le varie sfumature evoca anche quella dell’amore.
La parola sanscrita bhakti deriva dalla radice verbale bhaj-, che significa “adorare, ricorrere a, affidarsi a” o bhañj-, che significa “rompere” (per dividere una parte di qualcosa). La parola significa anche “attaccamento, devozione, affetto, omaggio, fede o amore, culto, pietà verso qualcosa come principio spirituale, religioso o mezzo di salvezza”. Il significato del termine bhakti è analogo ma diverso da kama. kama connota connessione emotiva, a volte con devozione sensuale e amore erotico. bhakti, al contrario, è spirituale, un amore e una devozione a concetti o principi religiosi, che coinvolge sia l’emozione che l’intelletto. Gli studiosi affermano che la parola bhakti non dovrebbe essere intesa come emozione acritica, bensì connotata di impegno. Infatti, nel concetto di bhakti nell’induismo, l’impegno implica una tensione simultanea tra emozione e intellezione, l’emozione per riaffermare il contesto sociale e la libertà temporale, l’intellezione per radicare l’esperienza in un approccio ponderato e consapevole. Colui che pratica la bhakti è chiamato bhakta.
Il termine sanscrito bhakti evoca nelle fonti più antiche l’idea della “parte”, della “distribuzione”, della “offerta”. Nel Ṛg-Veda (VIII.27.11) si offrono preghiere alle divinità vāmasya bhaktaye, letteralmente “per una parte di benessere”, cioè con lo scopo di ottenere una parte di ricchezza. Vāmasya è il genitivo singolare neutro di vāma, che indica una realtà positiva, bella, quindi anche il benessere, la ricchezza. Bhaktaye è il dativo singolare femminile di bhakti. Da questo significato etimologico arcaico il termine bhakti già nei Veda passa a significare “affetto”, “amicizia”, “attaccamento”, “amore”, “devozione”, perché l’amore nei confronti di una divinità consiste nell’offerta della propria vita in un atto di donazione continua.
Anticamente il buddhismo, nato nel nord dell’India con la predicazione di Gautama Buddha (Siddharta) nel VI secolo a.C., pur non prescrivendo la dura ascesi, era rivolto a persone molto povere, per questo il Buddha insegna a mangiare al limite della sopravvivenza. Ma oggi il mondo è cambiato e i buddhisti non seguono più quel regime alimentare.
Ci sono molti modi per approcciarsi a Dio. Ma tutti devono tendere ad amarlo, che è la vera “conoscenza” in questo mondo e nell’altro. Chi inizia ad amare inizia a conoscere la verità.
In sanscrito esiste una parola assai interessante: pratibhā, che indica il genio poetico, quella virtù innata che rende un essere umano un vate. Il termine sanscrito significa di per sé “luce verso (il pensiero)”, è costituito da prati + bhā, corrispondente al greco pròs + fōs. Il termine greco fōs, “luce”, è la contrazione di: fa-os. La radice indoeuropea di queste parole è bh-eH2, “splendere”, da cui si hanno, in greco, tanto fōs, “luce”, quanto fanai, “dire” (cfr. latino fārī e sanscrito bhāṣā).
Perché la luce è connessa con la parola e il pensiero? Forse perché con la parola si illuminano gli altri. Anche la Bibbia dice che “lampada per i miei passi è la tua Parola” (Salmo 118, 105). O forse perché nel mondo indoeuropeo è la luce a rendere visibile la parola del dio.
In Ṛg-Veda (III.62.10) si canta (è la Gāyatrī, il mantra più importante dell’induismo):
tát savitúr váreṇyaṃ bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodáyāt
“Meditiamo sullo splendore eccelso del divino sole
il quale possa illuminare le nostre menti”.
“Splendore/luce” è la traduzione del termine sanscrito bhargo, dalla nostra radice indoeuropea. Bhargo è in sandhi, la forma base è bhargaḥ, cioè bhargas. La “luce” (bhargo) è in concordanza con tat, anche questo in sandhi (tad), “questo”, “quello” (cfr. inglese that). In sanscrito tale pronome a volte è come se fosse un articolo, ma alcuni ritengono che il poeta vedico voglia qui alludere al Brahman, l’Assoluto, che nei Veda è per l’appunto definito Tat. Si tratta dello splendore del “sole”, in sanscrito savitur, genitivo.
Il sole, savitur, è sostantivo maschile, quindi il pronome relativo maschile yo (yaḥ) si riferisce al sole. È però possibile anche un’altra traduzione. Il pronome relativo yo, benché maschile, potrebbe riferirsi al sostantivo neutro bhargo, quindi la luce “che” (yo) illumina le nostre menti. Bhargo potrebbe significare anche “cibo”, quindi si chiede il sostentamento quotidiano.
Ma cosa c’è di più necessario per la nostra vita che capire la volontà di Dio, cioè la sua Parola? La volontà di Dio è che le sue creature lo amino di vero cuore.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 55 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.