Gli eredi del campanilismo
Una vera e propria forma di isteria economicista sta oggi trasformando, giorno dopo giorno, la terra in una enorme discarica. Risulta ormai accertata l’impossibilità di una crescita infinita in un mondo finito ed è scontata l’incompatibilità del pianeta nel poter continuare a sopportare una popolazione sempre in aumento.
Gli ultimi eccessi della mondializzazione e lo spettro del pensiero unico hanno di recente portato alcuni studiosi, sensibili alle scienze sociali a ravvisare nel localismo (intendendo per tale il senso di appartenenza e volontà di tutela del patrimonio materiale, culturale, relazionale esistente in un determinato territorio) una delle possibili alternative ad una società che rischia di non saper sopravvivere al proprio sviluppo.
Tradizionalmente, nell’accezione d’uso corrente, si definiva campanilismo l’attaccamento esagerato e gretto alla propria gente e al proprio paese; quindi un sentimento circoscritto che non travalicava la propria cerchia muraria.
Oggi anche non sospetti detrattori dell’identità sono pronti ad affermare che “Se i misfatti dei ripiegamenti identitari e dell’etnicismo devono essere denunciati, non bisogna buttare via il bambino con l’acqua del bagno”(S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, 2008) . Anche i nuovi indirizzi orientati alla proposta di una economia solidale e comunitaria hanno riscontrato nella valorizzazione del patrimonio locale non tanto anguste volontà di chiusura o di ripiegamento, bensì la pista da seguire per valorizzare una creatività già esistente e consolidata, per combattere le esondanti pretese produttivistiche e consumistiche che ignorano le disponibilità reali, le esigenze primarie, i limiti territoriali e le sensibilità etniche.
In passato non sono mancati casi di aberrazione, tuttavia sono anche presenti una nutrita serie di esempi positivi che vengono proposti esaminando la storia artigianale e contadina della società vernacolare. Sono modelli di vita rintracciabili in alcune comunità tradizionali che per secoli hanno saputo adeguarsi all’ambiente utilizzandone le risorse oculatamente e opportunamente senza portarle a distruzione, operando in armonia, evitando traumi alla natura intesa come madre e non semplicemente come res predatoria (F. Schuon, Sguardi sui mondi antichi, 1996).
Questi schemi, per prima cosa, comportano il superamento non facile relativo all’accrescimento dei bisogni superflui. Va posto coraggiosamente un limite al sovraconsumo, agli sprechi generati da strane e moderne abitudini (imballaggi, prodotti inutilizzati, gusto per lo shopping, desideri di possesso fine a se stesso). Non è ulteriormente tollerabile e rischia di fomentare una situazione di degradata conflittualità sociale la progressiva disuguaglianza tra paesi troppo ricchi e quelli troppo poveri. La stessa cosa per analogia ha valore con gli esseri umani presi singolarmente.
Il campanilismo del passato, purgato da alcune detestabili spigolosità, può fornire intuizioni, spunti e concetti su cui ricomporre la nuova mappa dei legami sociali.

Basta prendere in considerazione la logica oblativa, l’etica della gratuità contro quella dell’accumulazione (C. Champetier, Homo consumans, 1999). La prima diversamente dalla mercantile si basa sugli arcaici rituali del dare, ricevere e contraccambiare, così come è stata esaminata da Marcel Mauss per i casi del kula o del potlàc, in uso presso le società a livello etnografico ed è stata riscontrata da Benveniste nell’ancestrale linguaggio degli indoeuropei (M. Mauss, Saggio sul dono, 2002 – E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Vol. I°, 1976).
Ma gli esempi per approfondire questi nuovi eppur vecchi indirizzi non occorre andarli a cercare nelle lontane isole Trobriand o nel pre-colonizzato Nord-ovest americano poiché si stanno evidenziando anche da noi.
Possono rientrare in questa logica: le banche del tempo, l’etica delle gilde artigianali, l’agricoltura contadina, le mutue di credito, gli empori, le associazioni di consumatori, varie forme del volontariato sociale, sanitario e culturale. Ricordiamo che in Italia un antesignano del credito sociale e quindi della finanza etica è stato Ezra Pound – Dieci lezioni alla Bocconi, 2020 – Lavoro e usura, 1972.).
Seppure costretti ai margini dell’economia corrente tali iniziative occupano posizioni di nicchia. Superati i limitati punti di vista dell’individualismo e dell’olismo è necessario prendere in considerazione il modello del dono, dell’alleanza e dell’associazione o come in altro termine è stato definito il terzo paradigma (A. Caillè, Il terzo paradigma, antropologia filosofica del dono, 1998). È infatti quest’ultimo chiamato nel dover tornare a svolgere un ruolo primario e salvifico dell’economia.
L’ossessione frenetica e totalizzante del lavoro e del cosiddetto dopo-lavoro o “tempo libero” occupa ogni minuto della vita dell’uomo moderno finendo spesso per costituire una dipendenza e risultare una vera e propria droga. L’ethos dell’homo faber ha sostituito l’otium dei filosofi e ciò costituisce un buon alibi per non pensare, poiché se c’è già chi è delegato a farlo non ci si deve o dovrebbe preoccupare ulteriormente.
Dopo esser stato opportunamente svuotato delle energie vitali il lavoratore gode gli ultimi anni di vita nel paradiso pensionistico, accompagnato dal senso di inutilità, abbandono e incapacità di coinvolgimento da parte di una società che finisce per considerare peso deficitario tutti gli estranei al processo produttivo.
Resta aperta la porta dell’otium utilis, cioè l’attingere a quelle forme di Volontariato, alle offerte di una operosità, non sorretta da pretese utilitaristiche e appunto perché gratuita, spesso miopisticamente stimata senza valore. In una intelligente prospettiva di opportuna fruizione queste forze, come hanno già dimostrato in campo sociale, assistenziale e sanitario, così anche in campo culturale, sarebbero in grado di risolvere parecchi problemi contingenti oltre che fungere da antidoto alla depressione e a molla realizzatrice del sé individuale.
Dal nativismo al populismo
Il nativismo, sorta di nazionalismo difensivo, è la sintomatica risposta a questi problemi estensibili geograficamente. Il fenomeno costituisce la replica dei nativi nei confronti dei nuovi arrivati che si suppone possano rappresentare una minaccia alla cultura, ai valori e alle istituzioni della comunità originaria (H. Georg Betz, La cultura, l’identità e il problema dell’Islam, in “Trasgressioni”, n° 46, 2008). Fondato sul presupposto che ogni forma di influenza esterna è tendenzialmente portata a minare la base su cui poggia l’identità collettiva il nativismo tende a ravvisare genericamente negli immigrati i portatori di valori inconciliabili con la propria tradizione, con le istituzioni vigenti e vi identifica un pericolo serio e ineludibile.
Ogni forma di renitenza all’integrazione più o meno forzata (sia essa religiosa, politica, sociale ecc.), la pervicacia a voler mantenere usi e conservare i costumi della propria etnocultura, l’ardire di non mimetizzarli ma anzi la pretesa nell’ostentarli e cercare di diffonderli vengono interpretati come comportamenti irriconoscenti nei riguardi dell’ospitalità concessa.
Se il nativismo trae maggiore vitalità da tali presupposti non può però essere comunque omologabile ad una delle tante forme conosciute di razzismo passato o presente.
Di regola ogni forma di diversità riconosciuta può sottintendere la pretesa di superiorità ma genericamente, nel caso in questione, non viene considerata la società come divisa gerarchicamente in livelli di civiltà corrispondenti alle etnie. Non si esprimono giudizi qualitativi o di merito che stabiliscano preordinate differenziazioni tra elite razziali, gruppi con funzioni superiori e destinatari di trattamenti inferiori.
In tale logica non esisterebbero gradi di civiltà essendo tutte equiparate. Società diverse possono esprimere modi differenti, ma non necessariamente sarebbe possibile formulare giudizi comparativi in quanto ogni comportamento o atteggiamento culturale si adatta alle esigenze naturali delle singole etnie.
Quando e se il nativismo si politicizza diventa populismo. Quest’ultimo in nome dell’identità rifiuta la società multiculturale e sostiene l’integrazione, volontaria o forzata, delle minoranze allogene.
Tuttavia le migrazioni di forti e continui flussi verso l’Europa, e in particolare l’Italia, pongono evidente il problema. È facile constatare il fallimento dell’assimilazione etnica di fronte a terzomondisti sempre più numerosi, determinati non solo alla conservazione, ma anche all’esportazione e quindi alla diffusione delle proprie tradizioni.
Volendo preventivamente escludere posizioni estreme di fanatismo xenofobo da una parte, e di universalismo cannibale dall’altra permane la vexata questio: il coesistere di etiche diverse necessita di nuove e più efficienti regolamentazioni, di facile attuazione e tali da ottemperare sia alla salvaguardia dei diritti acquisiti dai vecchi abitanti, sia ad evitare che i nuovi arrivati cadano nelle trappole dello sfruttamento e dell’inserimento malavitoso.
Facendo leva sul disagio popolare verso la partecipazione politica, il populismo attiva strategie di mobilitazione di massa che sfidano apertamente la classe politica in auge, criticandone l’operato in nome di una più diretta partecipazione e mettendo in discussione non tanto i principi bensì la forma organizzativa elitista presente nella democrazia rappresentativa.
Qui la parola popolo assume il significato pregnante che travalica il concetto astratto di demos e diventa equivalente di ethnos.
Il programma di questi movimenti si concretizza attraverso un progressivo percorso di delegittimazione (Y. Meny, Y. Surel, La costitutiva ambiguità del populismo, in “Trasgressioni” n° 34, 2002) nei confronti del potere costituito, così definibile: 1) l’enfatizzazione del ruolo svolto dal popolo. 2) Il leit motiv del tradimento ordito dagli uomini attualmente al potere. 3) La capacità delle nuove forze ad assumere il comando dopo la liberatoria cacciata del vecchio gruppo dominante. 4) La figura di un leader carismatico, garante della volontà comune.
I mezzi proposti dalla democrazia diretta (le varie forme di decentramento, i referendum, le tipologie del volontariato) porterebbero al rafforzamento dell’istituzione consentendo:
– un salutare ricambio della classe dirigente,
– una attenzione maggiore da parte delle élites di potere ai problemi reali del paese,
– un limite al degrado avanzato dal processo di progressivo sradicamento culturale.
La sempre difficile assimilazione delle minoranze in continuo arrivo e il deprecabile annullamento delle culture autoctone indirizzano verso la strada dell’etnopluralismo che a sua volta introduce al concetto di “diritto alla differenza”, boccone di non facile digestione poiché soggetto al bersaglio incrociato delle conflittualità, siano esse politiche, etniche o religiose.
In bilico tra tribalismo reazionario e avventurismo progressista la nostra società stenta a trovare la pista che permetta un decollo equilibrato, esente da traumatiche scosse. Le reciproche pretese di spazio vitale e di rispetto umano possono essere avviate solo attraverso la volontà di un dialogo sincero e aperto, in grado d’affrontate le incertezze prodotte dalla galoppante crisi economica; spauracchio che bene o male coinvolge tutti.
L’antropologia sociale come principio e come via
Osservando le strutture sociali odierne è difficile credere in un ideale progresso storico quando si registra il passaggio temporale da un preteso egoismo di gruppo (il campanilismo inteso come culto del noi) all’egoismo del singolo (l’individualismo utilitarista che prefigura il culto del sé).
Il prevalere nella società contemporanea di logiche fondate, quasi esclusivamente, sulle leggi del mercato ha generato l’inevitabile sostituzione degli entusiasmi identitari alle parimenti distruttive smanie economiciste. L’accelerazione impressa alla circolazione dei beni ha comportato l’alleggerimento nel tessuto sociale di ogni valenza simbolica. Quando ogni cosa viene ricondotta ad un prezzo anche i valori ideali e morali sviliscono.
I rischi messi in atto dall’attuale crescente e preoccupante processo di globalizzazione sono quelli di un universalismo cannibale. La propensione a voler realizzare una società del pensiero unico rappresenta il vero pericolo di un appiattimento indistinto, considerando che l’azzeramento delle identità è destinato non tanto a conseguire una strategia di generale miglioramento bensì a potenziare gli appetiti dei singoli.
Ci si è giustamente interrogati sul perché insieme alla tutela delle biodiversità (animale, vegetale) non si siano così frequentemente, fino ad oggi, registrate altrettante voci in difesa della etnodiversità.
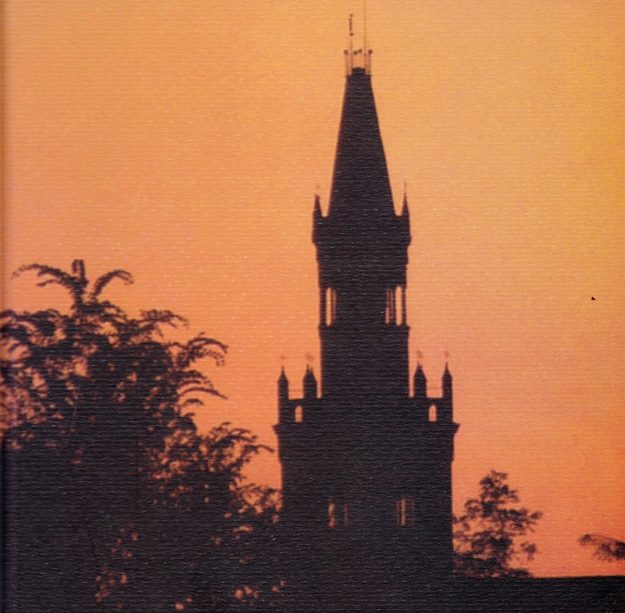
Considerando doveroso battersi per preservare dal pericolo di estinzione la foca monaca e contro la ormai sempre più rarefatta comparsa del carpino bianco risulta poco plausibile l’indifferenza riservata alla difesa delle diverse identità culturali, derivate da una secolare maturazione e frutto di un ininterrotto processo educativo.
Bisogna denunciare l’illusione di una cultura planetaria che sarebbe il sottoprodotto della mondializzazione tecnoeconomica.
In antitesi con la precedente affermazione assistiamo al fiorire di iniziative promozionali che si concretizzano con manifestazioni, rievocazioni, pubblicazioni, non sempre rispettose del processo storico, impegnate nella nostalgica riscoperta di presunte eredità perdute, in realtà, mai esistite.
Sono tentativi, a volte maldestri, che comportano una reinvenzione tardiva di leggende lontane, manipolate al solo fine di procurare vantaggi e tutelare interessi specifici.
Mentre l’etnopopulismo tende a sviluppare il mito dell’età aurea, l’acquisizione dei nuovi modelli mondialisti spesso si accompagna ad un profondo senso di vergogna e svilimento nutrito nei confronti di un passato considerato retrogrado e ostacolo ad ogni nuova emancipazione.
Cestinate le idee di città-stato e quella di stato-nazione, l’omogeneizzazione dei costumi costantemente promossa dall’imbonimento mediatico è risultata l’incapacità a saper promuovere nuovi modelli comportamentali. Inevitabilmente ne è derivata l’idea di una società atomizzata.
Il senso della collegiale appartenenza, insieme al concetto di bene comune, di solidarietà e destino collettivo sono scomparsi, traditi da falsi profeti, mentre la presenza di una massiccia immigrazione, tenacemente ancorata alle proprie specificità tradizionali e decisa a conservarsi fedele alla cultura avita viene naturalmente vissuta come un fagocitante pericolo.
“Una identità, o quello che di essa resta, si sente minacciata e sconfitta tanto più è vulnerabile e incerta”( A. De Benoist, Le sfide della postmodernità, 2003).
Nei confronti dei nuovi soggetti, in maggioranza extracomunitari, sia le prospettive di ghettizzazione quanto quelle di integrazione forzata appaiono entrambe dettate da forti paure, dovute alla debolezza se non alla mancanza di principi coesivi.
Queste carenze che, in base alle differenti visioni, possono sfociare nell’intolleranza verso le culture altre o nel buonismo, a seconda dei casi paventano le aporie di una profilattica marginalizzazione (il muro, il ghetto, il campo) quanto quelle di una selvaggia assimilazione (il monolitismo culturale di stampo occidentale).
Se è razzistico pensare in termini di pretesa superiorità biologica, razziale e culturale, è realistico constatare la differenziazione delle razze. Resta ancora da definire, con un termine appropriato, l’atteggiamento, anch’esso pericoloso, di chi paventa la propria inferiorità.
Il compito dell’antropologia sociale oggi, sotto certi aspetti, pare simile a quello dell’ecologia, della storia dell’arte, dell’archeologia o dell’agricoltura legata alle colture tipiche. Tanti specialisti finalizzano il preciso impegno di trasmettere alle future generazioni, per quanto possibile inalterati, i patrimoni culturali, naturali e artistici espressi dalle esperienze storiche ricevute dal passato. Nell’ottica di recupero tutto va salvato perché non esistono piante buone, animali mediocri o razze di uomini cattivi e altre costituite da presunti eletti.
Si tratta di preservare nel suo complesso la biodiversità, una ricchezza ambientale e umana che non può e non deve essere considerata esclusiva proprietà privata di una generazione, né va lasciata al capriccio, in balia degli umori o peggio in mano alla gestione manichea dei politici di turno.
Nella ricerca sul campo lo studioso di tradizioni popolari sempre più di frequente deve fare i conti con relitti misteriosi di utensili e di beni volatili, dai quali la memoria del corretto utilizzo come i profondi significati simbolici sono sfuggiti da tempo e gli enigmi, una volta spariti gli ultimi depositari, diventano sempre più numerosi delle certezze.
Tali tentativi di salvaguardia non sono fini a se stessi.
Ignorare il comune retroterra culturale porta inevitabilmente a generare complessi di inferiorità, sfocia in paure che sovente conducono di volta in volta ad abbracciare atteggiamenti di intolleranza, di aggressività o di vittimismo interessato.
Come è possibile infatti avere la pretesa di giudicare le identità degli altri quando non si conoscono nemmeno le proprie radici?
Le torri campanarie, prima di diventare un monumento al richiamo turistico, quando ancora gli odierni grattacieli non le avevano mortificate, si ergevano al di sopra delle restanti case, sovrastandole. Esse costituivano una presenza autorevole che incuteva riverente timore perché configurava lo spirito, il genius loci degli abitanti che le avevano laboriosamente volute, erette e difese.
C’è stato un tempo in cui l’invito ad “andà a scùndes apùs al campanil” (nascondersi dietro il campanile) non era solo un modo di dire.
Tuttavia nell’immaginario collettivo se sappiamo prestare attenzione alla loro voce e ci soffermiamo ad ammirarne l’armonica verticalità dei campanili li sentiamo ancora esercitare il fascinoso compito di vigili sentinelle, di pastori paterni dei beni materiali, messaggeri spirituali a cui un tempo sono stati demandati.
Erano e permangono, nonostante l’indifferenza odierna, gli ideali difensori della comunità e dei suoi valori più cari; così, in ogni tempo, sono stati declamati dai poeti dialettali16, immortalati nei quadri dei pittori e accuratamente descritti nei racconti dai cronisti locali.




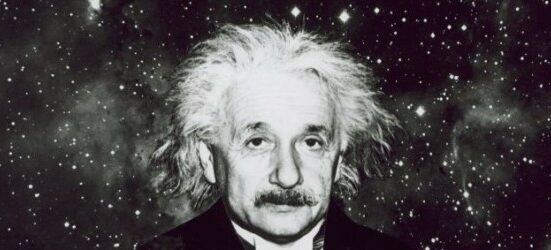


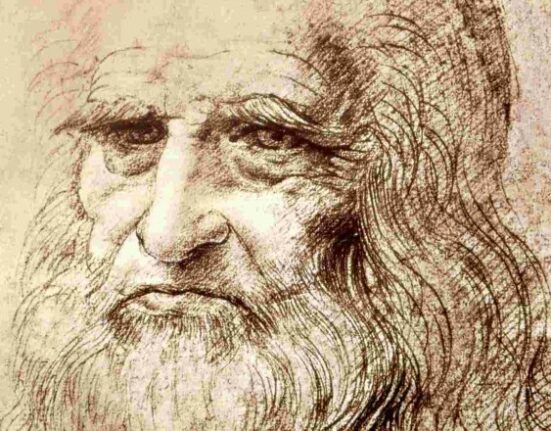
1 Comment