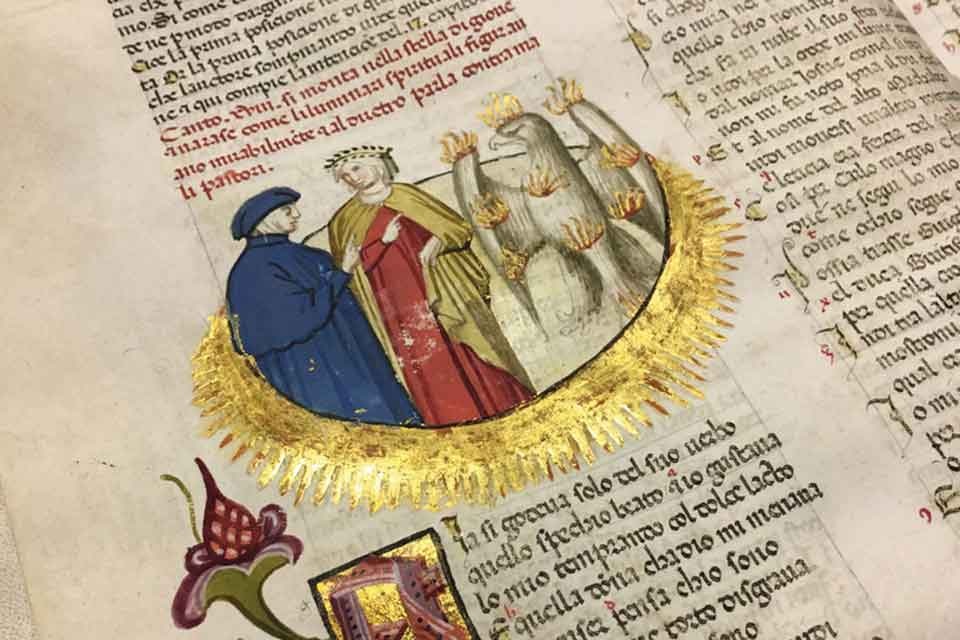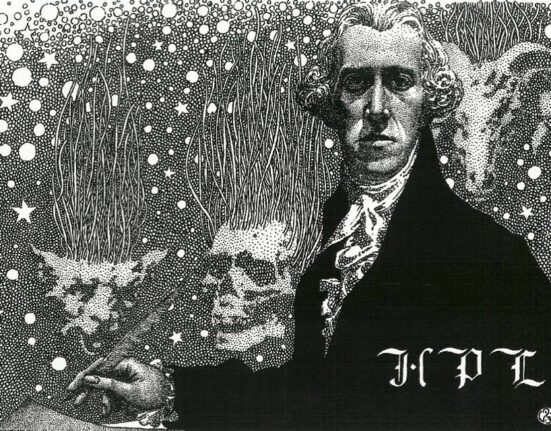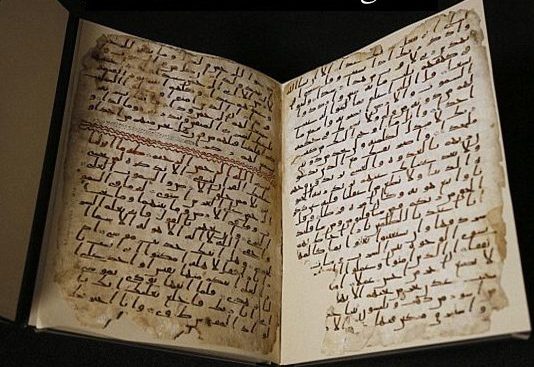“Verso la fine inclinava il vecchio mondo. Della giovane stirpe appassiva il giardino di delizie – allo spazio libero e deserto di lassù anelavano gli uomini cresciuti, non più fanciulli. Gli dei sparirono col loro corteggio – Sola e inanimata rimase la natura. L’avvinsero nella ferrea catena dell’arido numero e della rigida misura. Si ridusse in polvere e vento e in oscure parole l’incommensurabile fioritura della vita”.
Novalis, Inni alla notte, V.
Novalis, forse l’incarnazione più pura del romanticismo tedesco e europeo, in queste poche ma splendide battute, racchiude il senso del vagare degli uomini, posteri di coloro che uscirono dal paradiso terrestre, dall’Eden. Alla gioia che nasce per lo stupefatto incantamento della natura, in una unione inscindibile e intuitiva, propria dei beati, si sostituì l’attuale velo del pensiero razionale e della parola.

La parola è la caratteristica più distintiva di noi esseri umani. Il linguaggio verbale, infatti, permette di pensare ma anche di comunicare ciò che abbiamo pensato, con tutti i suoi limiti, certamente, ma anche con qualche grandezza e utilità. Per Lacan pure l’inconscio sarebbe strutturato come un linguaggio.
A partire dagli anni Cinquanta del Novecento lo strutturalismo americano ha cominciato a dedicarsi allo studio della sintassi all’interno della linguistica moderna. È al linguista Noam Chomsky che si deve l’elaborazione di una teoria specifica di sintassi formale. La maggior parte delle pubblicazioni in questo ambito condivide l’obiettivo di costruire una teoria che tenga conto dei fenomeni sintattici di una lingua in base ad una serie di ipotesi di partenza che si possono riassumere in 4 punti:
- esiste tra le lingue del mondo un sostrato comune rispetto al quale le differenze tra lingua e lingua sono superficiali; il sistema sintattico è quindi astratto e mira ad individuare gli aspetti comuni (o universali) sottostanti le diverse lingue;
- tale sostrato deriva dal fatto che le lingue sono la manifestazione di una capacità linguistica che sta alla base di tutte le lingue (capacità innata);
- la sintassi è il meccanismo centrale di formazione o «generazione» di una lingua rispetto al quale l’insieme dei suoni e dei significati da essa portati sono fenomeni esterni;
- il sostrato comune sintattico è costituito da una serie di principi universali (Grammatica Universale) che determinano la costruzione sintattica di tutte le lingue.
Sulla base di queste ipotesi è stato costruito il modello sintattico che prende il nome di Grammatica Generativa Trasformazionale (GGT – Chomsky 1957) e le versioni che seguono. Ciò che accompagna le versioni del modello generativista è la tendenza metodologica a costruire la grammatica a partire dai fenomeni sintattici di una sola lingua (approccio monolinguistico). Ciò ha comportato l’analisi approfondita della sintassi della lingua inglese. Solo nel 1981 Hale e i suoi studi spingono l’interesse verso altre lingue occidentali. Molti linguisti si interessano alla ricerca di parametri di variazione e Chomsky dichiara che la variazione è solo morfologica e che i comportamenti morfologici vengono considerati solo nella misura in cui conducono alla visibilità del meccanismo sintattico. Esistono poi altri studi detti «tipologici» o «tipicologico-funzionali» che si basano su diverse teorie e cioè sull’esistenza nelle lingue di principi di costruzione universale, principi non di natura sintattica ma relativi alla funzionalità, a livello comunicativo, dei Tipi grammaticali individuati, e sulle differenze tra le lingue, importanti in quanto utili nel determinare la gamma di realizzazioni grammaticali (o Tipi); vedendo la sintassi, non come l’unico livello che determina la costruzione della grammatica. Da ciò deriva un approccio multilinguistico o plurilinguistico per gli studi su una sola lingua, un approccio multi o inter livello per gli studi interessati all’interazione della sintassi con altri livelli di analisi.
Con GGT s’intende qualcosa di diverso rispetto alla tradizione linguistica. La grammatica non è tanto lo studio delle categorie fonetiche, morfologiche e sintattiche di cui una lingua è composta, ma piuttosto un modello teorico volto ad individuare le proprietà linguistiche che caratterizzano universalmente le lingue naturali. La rapidità con cui un bambino apprende la lingua induce a ipotizzare schemi innati di acquisizione linguistica e porta alla determinazione del concetto di Grammatica Universale (GU). La grammatica è “generativa” nel senso che definisce un sistema di regole che specificano le proprietà di un insieme limitato di espressioni linguistiche e attraverso queste tiene conto di tutte le frasi ben formate della lingua, escludendo quelle mal formate. Il suo obiettivo è quello di costruire un componente sintattico autonomo concepito come un meccanismo che dà come output delle stringhe di parole da interpretare fonologicamente e semanticamente. La sintassi viene quindi identificata con la grammatica e viene definita come il componente che si occupa delle combinazioni delle parole e delle leggi che governano tali combinazioni.
Un principio della GGT è quello di Dipendenza della Struttura che stabilisce che le operazioni sintattiche si basano su raggruppamenti strutturali all’interno della frase e non sulla sequenza lineare degli elementi della frase.
Consideriamo un’operazione sintattica come l’accordo verbale in italiano: «Il dottore visita la paziente». In base a questo esempio si potrebbe stabilire che la regola dell’accordo operi tra il primo sostantivo nella frase e il verbo. Ma non è così. Infatti, se fosse così, la frase «tutti i sabati il dottore visita la paziente» diventerebbe una frase non grammaticale del tipo: «*tutti i sabati il dottore visitano la paziente». La regola dell’accordo ci dice che si basa sulla relazione tra il nome all’interno del raggruppamento di parole a cui è composto ed il verbo. Ma a tali principi vengono associati anche i parametri dell’esperienza.
I parametri sono punti aperti a variazione. Si può vedere, in merito a ciò, come vengono trattate le differenze di comportamento tra italiano e inglese relativamente all’uso dell’aggettivo. Esistono frasi in italiano nelle quali il soggetto può non essere espresso e la presenza del pronome che lo sostituisce non è obbligatoria («dorme») e in questo caso si parla di “pro-drop” o caduta del pronome. Questo fenomeno è correlato con l’assenza del soggetto pronominale ogni volta che si ha un verbo impersonale («nevica»). In inglese è diverso: il soggetto deve essere sempre espresso («Paul is spleeping» – «He is speeplig») e collegato a ciò è la presenza del soggetto semanticamente vuoto («It is snowing» – «*it snowing»). In relazione a questa differenza la GGT formula un principio in base al quale si stabilisce che tutte le frasi in tutte le lingue hanno un soggetto, anche quando si hanno verbi impersonali. Viene così postulato il Parametro del Soggetto Nullo che sia applica a lingue come l’italiano che possono avere il soggetto sottinteso.
La grammatica di una lingua può essere vista come un insieme particolare di valori per i parametri, mentre la GU è il sistema complessivo di regole, principi e parametri che si può considerare elemento del patrimonio genetico dell’uomo, cioè “facoltà di linguaggio”. La grammatica è astratta in quanto genera dei costrutti corrispondenti all’insieme di conoscenze che caratterizzano la facoltà di linguaggio e in tal senso può essere definita come un modello della competenza e cioè delle conoscenze di un parlante-ascoltatore ideale, in una comunità omogenea, il quale conosce perfettamente la sua lingua e non è influenzato da condizioni grammaticalmente irrilevanti nell’applicazione e nell’esecuzione linguistica.
Si distingue così tra un uso effettivo della lingua “esecuzione” e capacità linguistica “competenza”.
La tipologia (TL) della grammatica costituisce una componente importante per la realizzazione delle espressioni di una lingua in quanto associazione tra una sequenza di suoni e un significato. In tal senso la grammatica è costituita da un insieme di mezzi che i parlanti delle lingue umane impiegano per mettere insieme elementi dotati ci significato per formare parole, parole per formare sintagmi, sintagmi per formare clausole, clausole per formare frasi e frasi per formare testi. La sintassi è il dominio che si occupa della costruzione di unità più grandi delle parole, clausole e frasi ma essa non è l’unico principio costruttivo, infatti in molte lingue è la morfologia il fattore determinante per l’interpretazione della frase, entrando nella costruzione delle espressioni linguistiche come un sistema di organizzazione della forma delle parole che contribuisce all’organizzazione dei modi in cui i parlanti veicolano i significati associati ai loro enunciati.
La TL riconosce l’esistenza di principi di costruzione universali. Il Tipo linguistico è un modello astratto il cui scopo è descrivere e spiegare la fenomenologia delle lingue, e consisterà nello studio delle interferenze interlinguistiche circa le tecniche, le strategie, impiegate per veicolare i contenuti semantico-referenziali. La concezione degli universali dei tipologi è legata ad una visione del linguaggio umano come sistema di comunicazione al servizio delle esigenze comunicative dell’uomo.
Esempio concreto di analisi tipologica. Uno dei principi universali relativo all’ordine sintattico nelle lingue è che nelle frasi dichiarative con soggetto e oggetto nominali, l’ordine dominante è quasi sempre quello in cui il soggetto precede l’oggetto e le lingue che seguono questo principio sono di più rispetto a quelle che non lo applicano.
I due approcci di fare sintassi che sono stati presentati considerano importante la ricerca degli universali linguistici, ma l’approccio della GGT tenta di individuarli in modo formale e secondo una metodologia comparativa ed astratta, mentre l’approccio tipologico parte da analisi più concrete e si basa su una metodologia fondata sul confronto plurilinguistico a largo raggio. Così, per la TL non si può arrivare a generalizzazioni significative se i dati non vengono tratti da una vasta gamma di lingue, per la GGT, invece, studiare una sola lingua può dare risultati validi se l’analisi è condotta con rigore. Sicuramente per fare sintassi sarebbe utile poter conciliare i due tipi di approccio e costruire una grammatica formale dotata di un apparato teorico di tipo sintattico e aperta alle ipotesi tipologico-funzionali, al confronto multi-linguistico e all’interazione con la morfologia, la semantica e la pragmatica. La Grammatica Lessico-Funzionale ha mostrato interesse verso la ricchezza del dato linguistico compiendo analisi comparative su lingue tipologicamente diverse allo scopo di cogliere attraverso la diversità linguistica le proprietà comuni a tutte le lingue.
* * *
Esistono circa 5000 lingue nel mondo, le quali sono assai diverse tra loro.
Le lingue del mondo si raggruppano in famiglie. Il greco appartiene alle lingue indoeuropee, assieme all’ittita e al vedico. Queste tre lingue sono le più antiche della famiglia indoeuropea. Il Ṛg-Veda viene considerato uno dei primi libri dell’umanità e la lingua con cui è scritto, il vedico o sanscrito vedico, una delle prime lingue attestate. Questo testo è un insieme di inni (ṛg) rivolti alle varie divinità. Il primo vagito dell’umanità corrisponde a un insieme di inni al divino!
I quattro Veda (Ṛg-Veda, Sāma-Veda, Atharva-Veda, Yajur-Veda) costituiscono la Saṃhita: essi sono dedicati rispettivamente agli inni, alle melodie cantate, alle formule sacrificali, alle formule di incantamento. I 4 Veda assieme a Brāhmaṇa, Āraṇyaka e Upaniṣad costituiscono la Śruti, cioè i testi rivelati. A ciò si aggiungono i testi scritti da uomini (Smṛti), come i Purāṇa, i poemi epici, opere grammaticali, metriche, di architettura e quant’altro. Tutta questa (Śruti e Smṛti) è la letteratura vedica (o Veda in senso estensivo).
L’importanza dei Veda (“conoscenza” in sanscrito), per la cultura indiana, è impossibile da sopravvalutare. Per più di tre millenni gli indiani hanno instancabilmente cercato in questo patrimonio ricchissimo ispirazione per fronteggiare le vicende storiche spesso drammatiche che il destino ha loro riservato e hanno continuamente innovato e modificato in vario modo, sempre nel solco della tradizione, i materiali che complessivamente vanno sotto questo nome. Fonte del diritto, della letteratura d’arte, dell’etica, dei precetti religiosi, della speculazione filosofica, e di competenze più tecniche come la grammatica, l’architettura, la medicina e simili, esso costituisce veramente la summa della civiltà fiorita nell’isola della melarosa, jambudvīpa, ossia la terra abitata dagli uomini, la cui parte meridionale è costituita dall’India propriamente detta.
Le origini della grammatica sono fatte risalire alla figura di Indra (Taittirīyasaṃhitā 6, 4, 7, 3), soppiantata in tempi più recenti da quella di Śiva, con l’inserzione a mo’ di introduzione alla grammatica dell’illustre Pāṇini degli “aforismi di ritrazione” (pratyāhārasūtra), forse per influsso dello śivaismo kasmiro definiti anche māheśvarasūtra, da uno degli epiteti del dio, maheśvara, “grande signore”. La grammatica rimane vincolata al rituale, il che traspare persino dalla terminologia, per esempio il vocabolo che indica la terminazione della flessione nominale, vibhakti, viene fatto derivare dalla radice bhañj, “inchinarsi” (al cospetto delle divinità). Già in epoca vedica si distinguono tre tempi: passato, presente, futuro (Aitareyabrāhmaṇa 4, 29, 3, 4, 31.3, 5, 1, 3). Queste nozioni non sono superflue in quanto per il mondo vedico la Parola, Vāc, è la prima manifestazione dell’Assoluto, Brahman, il quale è definito “inconcepibile” (acitta, Ṛg-Veda 1, 152, 5).
La Sillaba Sacra vedica da cui tutto viene creato è AUṂ (OṂ). Katha Upaniṣad (1, 2,15) rivela:
sarve vedā yat padam āmananti
tapāṃsi sarvāṇi ca yad vadanti.
Yad icchanto brahmacaryaṃ caranti
Tatte padaṃ saṃgraheṇa bravimi
OṂ ity etat
“La Parola della quale tutti i Veda parlano, che tutti gli sforzi di austerità proclamano, per la quale tutti i fedeli praticano la via, questa Parola, ti dirò brevemente: è OṂ”.
La sillaba au forma un dittongo della lingua sanscrita, il quale aveva, nelle fasi più antiche della lingua, la prima vocale lunga (āu); ma in sanscrito già in antichità questo dittongo extra-lungo si ridusse a dittongo regolare lungo (cioè con la prima vocale breve: au); in seguito il dittongo regolare au si ridusse a monottongo, cioè a semplice vocale di timbro o. In questo modo si spiega il passaggio di AUṂ a OṂ. Per fare un esempio, in sanscrito auṣṭha significa “a forma di labbro” e riflette una fase della lingua nella quale il dittongo au si mantiene ancora, invece oṣṭha, “labbro”, riflette una fase della lingua nella quale il dittongo au si è già monottongato nella vocale semplice o. Invece Ṃ alla fine della Sillaba Sacra (AUṂ, OṂ) è un anunasika, cioè un suono nasale riguardo la cui origine gli studiosi non concordano.
Misticamente la A allude al mondo fisico (nell’uomo il corpo fisico), la U allude al mondo sottile (nell’uomo il corpo psichico), la Ṃ al mondo causale, non manifesto (nell’uomo il puro spirito). Graficamente la Sillaba Sacra è sovrastata da una mezzaluna con sopra un punto, si tratta di Nada e Bindu, le due forze cosmiche necessarie alla creazione, che procede dal mondo causale a quello sottile per determinare infine il mondo fisico.
Secondo la mitologia indiana gli dei avevano paura della morte, quindi pensarono di nascondersi, e lo fecero entrando nei Veda, avvolgendosi nei metri come in drappi: per questo i metri si chiamano chandas, perché gli dei vi si avvolsero (acchadayan). Di più, “la Voce è in verità Brahman nell’Empireo più alto” (Taittirīyasaṃhitā 7, 4, 18, 2). La Parola è definita Voce Eterna (nityā vāc, Ṛg-Veda 8, 75, 6). Essa sarà conosciuta dalla tradizione quale Suono Assoluto (śabdabrahmana). Di conseguenza anche la grammatica affonda le proprie radici nella mitologia, quindi nella scienza vedica.
Nel celebre inno del Ṛg-Veda 10, 129 è rivelato che il primo elemento cosmico è Uno, ekam (lo stesso appellativo usato dalle Upaniṣad per il Brahman), il quale respira di sua propria volontà, svadhayā (simile all’appellativo svayambhū usato dalle Upaniṣad per il Brahman). Stando al verso 3, l’altro elemento cosmico primordiale è la massa oscura e senza vita delle acque. L’unione di questi due elementi, non espressamente accennata ma dedotta dal contesto del verso 3, è detta generare la vita, racchiusa in un involucro (tucchya). Anche questo germe è detto Uno, perciò è virtualmente identico al respiro creativo primordiale. E la Parola entra in campo in questa creazione: “Gli dei mi hanno diviso in molte parti, mi hanno assegnato molte dimore e mi hanno fatto pervadere ogni cosa” (Ṛg-Veda 10, 125, 3). La culla della Parola “è nelle acque dell’oceano, da là mi divido in tutte le creature e, crescendo in potenza, raggiungo il cielo” (Śatapatha Brāhmaṇa 6, 1, 1, 9).
Nel mondo vedico l’inno rituale, la preghiera, sono equiparati al cibo e alla bevanda sacrificale. Hanno quindi un valore incommensurabile. Quindi le parole rituali hanno la funzione di nutrire gli dei ai quali sono rivolte. Il sacrificio (yajña) per eccellenza resta quello della parola, in forma di inno, a costituire l’offerta principale dei poeti alla divinità, che se ne ciba e ne trae forza. “I metri sono il bestiame degli dei” (Śatapathabrāhmaṇa 4, 4, 3, 1). Il sacerdote (brahmano) si riconosce per una certa luce, uno splendore, brahmavarcasa, “splendore del Brahman”. Il fine ultimo del sacerdote è quello di essere illuminato dal Brahman. Nel sacrificio vedico si accende un fuoco, sopra al quale si versa un liquido detto soma: il sacerdote che recita i versi dell’accensione del fuoco, mentre lo accende, diviene il destinatario di quella stessa accensione. La sua luce avviene simultaneamente a quella del fuoco, degli inni e delle stagioni. E come il fuoco accompagnato dagli inni ha una luce più intensa, così il sacerdote avrà una luce diversa da quella di ogni altro uomo.
In un interessante contributo Malamoud (1994) fa riferimento al linguaggio segreto degli dei. Mentre il sanscrito classico è una lingua chiara, cioè manifesta, in quanto i significati delle parole derivano necessariamente dalla radice, invece gli dei hanno un linguaggio occulto, “perché gli dei amano l’occulto”, paro’kṣakāmā hi devāḥ. Quindi le divinità odiano ciò che appare con chiarezza e cercano di deformare anche le parole affinché non siano subito comprensibili. In questo modo il dio Indra si chiama in realtà Indha, vale a dire “colui che accende”, dalla radice verbale indh-, “accendere, bruciare”. Ma veniamo a noi. I mattoni che servono a costruire l’altare del fuoco hanno dei nomi. Uno di essi si chiama ati-chandas, “iper-metro”, perché la sua sistemazione è legata alla recitazione di un verso ipermetro. Ma di fatto questo nome è un nome occulto, destinato a soddisfare l’inclinazione degli dei per l’esoterico. Infatti il suo nome originario è atti-chandas, “mangia-metri” (da atti, “egli mangia”), il che spiega anche il fatto che nel Śatapathabrāhmaṇa (8, 6, 2, 13) sia paragonato a un ventre.
In Ṛg-Veda 10, 81 è scritto: “colui che, versando in oblazione tutte queste creature (bhuvanāni), si è insediato come poeta e come officiante (hotā), è nostro padre”. I Veda sono testi squisitamente poetici, altamente retorici e finemente allusivi. Vi è una identificazione tra l’atto di versare l’offerta con l’atto vocale della preghiera. C’è un gioco linguistico che si avverte solo in vedico: si basa sulla omofonia di hu-, “versare, offrire in sacrificio”, e hū-, “invocare”, radici ambedue convergenti in hotā, “officiante”. Anche bhuvanāni contiene lo stesso nucleo hu(v)-: il poeta linearizza fonicamente la correlazione tra il concetto di “essere creatura” e quello di “libagione”, quasi suggerendo l’identificazione tra le “creature” (bhuvanāni) e le proprie “libagioni/invocazioni” (havanāni, che ha entrambi i significati) nella strofa 7: “invochiamo il Signore della parola, possa rallegrarsi di tutte le nostre libagioni/invocazioni”, vācas patim … huvema sa no visvāni havanāni josad.
In merito al grande valore sacrificale della parola, Lazzeroni (1998) opera questa ricostruzione. Ṛg-Veda 10, 43, 7: “Quando i fiumi di soma (liquido del sacrificio) sono versati in Indra come le acque nel fiume, come i fiumi nel mare, i sacerdoti accrescono la sua grandezza (vardhanti viprā maho asya), nella sua sede, come la pioggia il frumento”. La radice mahas- indica “grandezza” più che “onore”. Altrove si vede come la radice vṛdh- designa la crescita, il rafforzamento corporale: “sebbene cresciuto, il suo corpo cresca ancora, onorato con canti e inni”, vṛddhasya cid vardhatām asya tanū stomebhir ukthaiś ca śasyamānā (Ṛg-Veda 6, 24, 7). Ora in vedico la radice mahas-ha come sede privilegiata il campo rituale: mahas- è la qualità che il sacerdote conferisce agli dei stessi; mahant- sono gli dei stessi; mahati e il causativo mahayati indicano l’azione rituale. Quindi mediante il rito (la parola rituale, gli inni) si accresce il dio.
Questa alta concezione della parola è comune a tutti i popoli indoeuropei. Portiamo questo esempio, che fa da Lazzeroni (1998). Il verbo latino interdico indica una proibizione (aqua et igni interdicere, “proibire a qualcuno l’acqua e il fuoco”). Il latino interdicere è analogo al verbo del dire iranico dallo stesso significato: antara-mrū, “bandire”. Entrambi si costruiscono con l’ablativo. La concordanza italo-iranica è indice di arcaicità. Come mai un verbo del dire passa a indicare una proibizione? Il verbo iranico in questione è sintatticamente isotopo con quello vedico antar-dhā, “inter-porre”. Il verbo vedico è specializzato nella pratica esorcistica, ed indica un oggetto che si pone per separare una cosa o una persona da un evento dannoso. In questo antefatto rituale vedico si chiarisce come mai in latino e in iranico si usi un verbo del dire per indicare separazione: la parola come strumento esorcistico che separa il bene procurato dal male da evitare. Valore eminentissimo della parola, che grazie al confronto tra latino, iranico e vedico, doveva essere indoeuropea.
Nello specifico per il mondo vedico, l’alto valore della Parola deriva dal fatto che l’Assoluto (Brahman) coincide con la Parola nelle sfere più alte, come abbiamo già visto. Pertanto anche colui che è rivestito di Brahman, cioè il sacerdote (brahmano), diviene Parola. Malamoud (2005) opera una ricostruzione assai interessante. Quando il sacrificante si appresta a fare il sacrificio deve pronunciare una formula: “Ora lascio la falsità per andare verso la verità” (idam aham anṛtāt satyam upaimi). Alla fine del sacrificio non dice di ritornare dalla verità alla falsità, perché sarebbe negativo, ma solamente “Ora sono soltanto ciò che sono” (idam aham ya evāsmi so’smi). Ma si chiede Malamoud, che senso ha fare un sacrifico se poi l’officiante torna come prima? Il sacrificante si prepara per la morte, tra il momento della verità e quello della falsità, durante il sacrificio, entra nel mondo degli dei e in quel luogo (loka) si prepara un posto per quando morirà. Il sacrificante fa un viaggio e va in un luogo dove risiederà dopo la morte, ma prima di quel momento, alla fine del sacrificio, ritorna nel mondo degli uomini. Il sacrificio sortisce effetti nel mondo invisibile: è questo l’effetto per il sacrificante! Malamoud evoca che durante il sacrificio si pone una statuetta d’oro vicino all’altare di mattoni dell’accensione. Questa statuetta è la immagine del sacrificante. L’immagine in questo caso è un’opera d’arte, e in vedico opera d’arte si dice śilpa, termine che designa anche manufatti che non sono opere d’arte, come la pelle di antilope maculata posta davanti al sacrificante durante il momento della consacrazione prima del sacrificio. L’officiante recita questa formula davanti ai peli bianchi e ai peli neri di quel manufatto: “Voi due siete immagini delle strofe (rg) e delle melodie (saman) dei Veda”. In queste fasi il sacrificante è assimilato a un embrione che gli permette di assumere il corpo nuovo mediante il quale, nello spazio eterico durante il sacrificio, gli consentirà di oltrepassare i confini dello spazio e di andare in quel mondo per prepararsi il posto per la morte, quando essa sopraggiungerà. La parola śilpa indica anche un certo gruppo di inni vedici. In questa maniera l’officiante assume un altro corpo, un altro sé (ātman), il quale, mediante la identificazione tra śilpa e Veda, diviene un essere fatto di metri vedici (chandomaya, “consistente di metri vedici”). Egli non è altro che la stessa poesia vedica. I metri poetici non sono soltanto un mezzo per raggiungere la perfezione (sacrificale) di sé ma sono il fine stesso. Identificarsi con la Parola vedica: tale è la forma di sublimazione, di trasformazione che il sacrificante opera durante il sacrificio, quando si libera dal suo essere profano.
Nel sacrificio vedico è fondamentale la parola, ma anche il mentale, essi (parola e mentale) sono i due elementi del sacrificio (Kauṣītaki-Brāhmaṇa 6, 11). Il mentale richiama il silenzio, ma che nel sacrificio vedico è ugualmente parola. È un silenzio carico di parola: questa è l’onnipotenza della parola! Nel sacrifico gli officianti parlano pronunciando formule, mentre il Brahman sta in silenzio. Malamoud (2008) scrive: “Attraverso il suo silenzio, il Brahman fa percorrere al sacrificio la pista del mentale. Si fa carico di ciò che, nel sacrificio, è l’altro dalla parola. Ma, in quanto medico del sacrificio, egli veglia anche sulla parola e sa come curare la parola indebolita con iniezioni di quintessenza di parola. Questa terapia è valida anche quando la causa linguistica della malattia del sacrificio non è rilevabile: onnipotenza della parola! Le due funzioni del Brahman, maestro del silenzio e medico per mezzo della parola, sono indissociabili. Il terapeuta, in questo caso, è efficace solo in quanto la sua parola si staglia su uno sfondo di silenzio. Ciò che egli dice è esplicito e definito, nirukta, ma le condizioni in cui enuncia la sua parola fanno sì che il silenzio da essa rotto non venga abolito; essa è carica dell’illimitato non-esplicito, anirukta, il cui simbolo è il silenzio”.
Bisogna ricordare che i testi vedici non sono mitologici come noi occidentali possiamo pensare. La mitologia vedica, infatti, è una filosofia, un parlare di concetti astratti mediante immagini. Coomaraswamy cerca di sintetizzare questa filosofia in un modo assai interessante. Il Brahman è ciò che per primo respira, cioè che per primo vive. Questo Primo Spirante è non composto (advaita) e in quiete (śayāna), ed in sé è un Principio Congiunto, formato da una dualità non duale, da una dualità non ancora differenziata. Questo mistero viene adombrato dai Veda quando dicono che la Realtà è composta da Manas (Intelletto) e Vāc (Parola). Questa unità, non concepibile dalla mente umana, forma l’atto fecondatore nell’eternità, in un luogo metafisico anch’esso inconcepibile nel quale tutte le cose divengono identiche (yatra viśvaṃ bhavaty ekanīḍam, Nārāyaṇa Upaniṣad 3). Il prodotto di questo atto fecondatore è la generazione del Figlio. Tale divinità primordiale, il Figlio, è immagine di tutte le cose (viśvasya pratimānam, Ṛg-Veda 2, 12, 9). Da questa divinità primordiale, il Figlio, generato in uno spazio eterno dal Brahman, discendono tutte le cose, che quindi sono immagini della divinità. Qui poggia il principio vedico dell’esemplarismo, per cui le cose del mondo manifesto, della realtà immanente, sono immagini, figure, specchi della Realtà assoluta, del Brahman.
I filologi studiano in continuazione la lingua vedica (specie quella più arcaica del Ṛg-Veda), trovandovi sempre particolarità degne di nota. Ne presentiamo alcune:
- Il vedico è legato all’estremo nord-ovest dell’India antica tradizionale, invece il sanscrito classico all’India settentrionale (Madhyadesh);
- Il sanscrito classico è una lingua artificiale (“sanscrito” è un participio passato passivo, saṃskṛta, che vuol dire “perfetto”, “compiuto”, “elaborato”, che corrisponde al latino confectus; a esso si oppongono le parlate naturali o prakriti), invece il vedico doveva essere una lingua naturale, quella parlata in India dai conquistatori arii, quindi in questo senso sarebbe sbagliato parlare di “sanscrito vedico”. Tuttavia c’è chi vede piuttosto una continuità tra il vedico e il sanscrito classico, nonostante che quest’ultima lingua perda molto del vedico, quindi viene accettata l’espressione “sanscrito vedico”;
- In ogni modo il vedico è più vicino all’avestico che al sanscrito classico. L’avestico è una antica lingua iranica nella quale sono scritti gli Avesta, i testi sacri dello zoroastrismo, la religione dell’Iran. Per il vedico e l’avestico gli studiosi ipotizzano una originaria unità indoiranica. L’indoiranico è una diramazione di uno stesso ramo indoeuropeo. L’unità indoiranica è confermata altresì dalla legge di Bartholomae: sia in avestico sia in antico indiano (vedico e sanscrito classico), in una sequenza di sonora aspirata + sorda semplice la prima delle due occlusive perde l’aspirazione, mentre la seconda acquisisce sia il tratto dell’aspirazione sia il tratto della sonorità (dall’indoeuropeo *bhudh-ta deriva buddha, “risvegliato”). Ciò che caratterizza l’antico indiano e, fino a un certo punto, le lingue moderne dell’India, opponendolo all’iranico, è il suo sistema di consonanti, tanto ricco e simmetrico da impressionare i primi comparatisti e da diventare la base delle loro ricostruzioni. La presenza, in queste lingue, di un ordine di retroflesse, cioè di consonanti articolate con la punta della lingua curvata all’indietro e posta contro il palato, è stata immediatamente interpretata come un tratto specificatamente indiano;
- In vedico l’aumento è ancora facoltativo (come in Omero) e esiste ancora il congiuntivo (che in sanscrito classico viene meno). L’ingiuntivo esiste in vedico in tutte le sue possibilità espressive, mentre in sanscrito classico è ridotto a qualche forma quasi fossilizzata. Solo in vedico imperfetto, aoristo e perfetto avevano significati differenti, mentre in sanscrito classico esprimono un passato che si equivale. Il sanscrito classico si caratterizza complessivamente per un progressivo impoverimento della morfologia specie verbale (in vedico vi erano dodici tipi di infinito, in sanscrito si sono ridotti a uno solo), arricchimento e specializzazione del lessico; in sanscrito classico le forme nominali del verbo e l’uso di composti suppliscono in grandissima misura a forme verbali finite che non sono sopravvissute al vedico. In compenso il sanscrito classico dimostra una sostanziale fedeltà fonologica al vedico;
- Gli studiosi ravvisano nella lingua del Ṛg-Veda diversi filoni dialettali, corrispondenti a distinti ceppi etnico-sociali. Quindi il vedico ha certamente una prima origine naturale ma va visto oggi in maniera più complessa, cioè come espressione organizzata, religiosa e rituale, della fase terminale di una cultura (orale, ma al tempo stesso capace di sofisticate elaborazioni testuali), molto vicina alla tradizione dell’Iran antico, quella delle parti più arcaiche dell’Avesta. I Veda non serbano memoria di un eroe che proviene da lontano, come accade per esempio nel mondo classico occidentale, quindi ancora oggi per gli indiani più conservatori le origini dell’India sono autoctone. Tuttavia gli studiosi più minuziosi ipotizzano nel II millennio a.C. l’arrivo di ondate indoeuropee penetrate nel Nord-Ovest dell’India che hanno spazzato via la raffinata civiltà urbana della Valle dell’Indo, quella precedente alla vedica, determinando la nascita di quest’ultima;
- Il vedico presenta numerose particolarità stilistiche. Come per esempio il paragone per negazione. Noi oggi diciamo “saldo come una montagna”, invece il poeta vedico diceva prima “montagna” poi aggiungeva la negazione (na) e infine “saldo”, cioè “montagna-non saldo” (parvato na acyutaḥ, Ṛg-Veda 1, 52, 2). La negazione serve a far passare il primo termine (montagna) dal senso concreto a quello analogico. Bisogna osservare anche che la particella na assume un valore diverso a seconda della posizione: posta prima della parola, riprende il suo valore originario negativo;
- Altro stilema degno di nota è quello per cui spesso un passaggio oscilla tra due piani: mitologico e rituale. Quindi oggi non sappiamo bene se un testo vada inteso mitologicamente oppure come descrizione di un rito effettivamente praticato;
- Pensiamo altresì al cosiddetto “significato conversivo”. Per esempio una identica parola viene attribuita al dio e poco dopo all’adepto. “Questo capro, destinato a tutti gli dei, è condotto avanti assieme al cavallo che porta le ricompense, come parte (bhāgo) per Pūṣan” (Ṛg-Veda 1, 162, 3, dove bhāgo, “parte”, è riferito al dio); ma poi è scritto: “Procuraci una sorte (bhāghaṃ) gloriosa, della quale si possa parlare bene!” (3, 1, 19, dove bhāghaṃ, nel senso di “sorte”, è riferita all’adepto);
- Tra gli altri stilemi interessanti ricordiamo le “immagini antiartistiche”, cioè l’unione di piani diversi (“Dalla nube ispirata si munge il grasso, il latte. Nasce l’ombelico della legge cosmica, l’immortalità”, Ṛg-Veda 9, 74, 4) oppure l’uso amplissimo di allitterazioni, richiami fonetici, giochi di parole;
- Il vedico e il sanscrito classico hanno otto casi, come l’indoeuropeo: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo, strumentale, locativo;
- Il vedico ha un sistema verbale di diatesi che poggia su una opposizione funzionale del tipo medio vs attivo. Però in vedico vi sono alcune desinenze proprie, che non ricorrono altrove. Alcuni hanno ipotizzato che esse esprimano una terza diatesi (il famoso “stativo”), invece Watkins ha avanzato l’ipotesi che tali uscite vediche rappresentino la più antica forma delle desinenze mediali, anteriore ad un rimodellamento analogico sulle attive;
- Gli studiosi hanno molto discusso sulla differenza tra frase nominale e frase verbale nelle lingue indoeuropee. Sembrerebbe che la frase nominale non sia semplicemente una proposizione senza verbo “essere”, bensì il livello più arcaico della sintassi caratterizzato da assenza di determinazioni temporali, modali, personali. Il vedico sembrerebbe comprovare questo assetto. Infatti, in vedico le frasi nominali ricorrono in usi sentenziosi e nella predicazione di qualità permanenti del soggetto. L’ingiuntivo è una testimonianza di quando il sistema verbale indoeuropeo non aveva valore temporale. L’ingiuntivo viene usato in vedico soprattutto in frasi sentenziose. Pertanto gli studiosi concludono che l’ingiuntivo è il verbo caratteristico delle frasi nominali più vicine a quelle dell’indoeuropeo. Dato che in vedico il verbo asti, “(egli) è”, non ha ingiuntivo, si è ipotizzato che in vedico la funzione di ingiuntivo del verbo essere fosse espressa dalla frase nominale;
- L’accento vedico era libero, come quello indoeuropeo, vale a dire che poteva cadere su ogni sillaba della parola. Si tratta di un accento melodico, cioè caratterizzato da un innalzamento (udatta) o abbassamento (svarita) del tono della voce, come in greco antico e in giapponese. La maggior parte delle parole è accentata, alcune però non hanno accento (anudatta, per esempio il vocativo in certe condizioni). Invece l’accento del sanscrito classico non è più melodico, ma intensivo, come nelle lingue indoeuropee moderne. Per la posizione è simile a quello del latino: se la penultima sillaba è lunga, l’accento cade su questa; se è breve, cade sulla terzultima;
- La lingua del Ṛg-Veda, che costituisce lo strato più antico del vedico, presenta il fenomeno per cui le cerebrali intervocali sonore ḍ/ḍh danno rispettivamente ḷ/ḷh; le aspirate sonore gh, dh, bh in alcuni casi manifestano la tendenza alla perdita dell’articolazione occlusiva;
- Nelle antiche parti del Ṛg-Veda è assente la lettera l, ad essa corrisponde generalmente la r. In antico iranico i due fonemi indoeuropei (l, r) sono confusi del tutto nel fonema r, invece in antico indiano si hanno tracce della antica differenziazione, ma sporadiche. Nel Ṛg-Veda mantengono la l solo alcuni sostantivi precocemente isolati dalla radice cui fanno capo (çloka-, “chiamata”, miçla-, “mischiato”) o termini che sembrano aver avuto un influsso dravidico (loka, “spazio”). Man mano che procediamo nel tempo in molte radici si tende a restaurare la antica l: già nel X Maṇḍala del Ṛg-Veda troviamo per esempio mluc- in luogo del più antico mruc-, “tramontare”. Nell’Atharva-Veda la l è sette volte più frequente rispetto al Ṛg-Veda, e nei testi epici e classici è tre volte più frequente rispetto ai testi preclassici. Le parole che entrano nella lingua dopo il periodo vedico hanno la l, quando la etimologia la presuppone. Si tratta di un fenomeno che prese le mosse dall’area iranica, per poi estendersi alla lingua vedica (in area nord-occidentale, più vicina all’Iran) e esercitare minore influenza sul sanscrito classico (usato in area più distante dall’Iran);
- Il vedico del Ṛg-Veda ha alcune varianti di flessione nominale e verbale che non si riscontrano mai altrove;
- Ci sono particolarità dialettali assenti in sanscrito classico ma presenti in medio indiano (i famosi prakritismi del Ṛg-Veda);
- Significativi alcuni piccoli prestiti dalle lingue muṇḍa e prestiti più consistenti dalle lingue dravidiche;
- Influenza del modello linguistico dravidico, specie nella sintassi (la particella iti, “così”, che marca il limite del discorso diretto, è posta principalmente dopo di esso, come in antico tamil, e non prima di esso, come nell’avestico);
- Nel Ṛg-Veda è presente più che negli altri Veda il fenomeno per cui antichi temi radicali funzionano sia come sostantivo sia come verbo;
- Il vedico del Ṛg-Veda è allo stesso tempo estremamente arcaico e estremamente variabile;
- Spesso un unico significato grammaticale è espresso da più tipi strutturali (sinonimia), ma ad un unico tipo strutturale possono corrispondere più significati (polisemia);
- Fortissima polisemia lessicale;
- Spesso le parole hanno significati antitetici (māya significa sia “saggezza soprannaturale” sia “inganno”);
- Il sanscrito classico è di per sé una lingua assai difficile sia nella struttura sia nella comprensione del testo tanto che per capire l’opera di un poeta è necessario il commento (spesso il commento del commento). Il vedico è una lingua ancor più complessa per via delle numerosissime regole grammaticali, della estrema polisemia delle parole e delle sfumature, le implicazioni e gli impliciti che le parole possono comunicare. A ciò si aggiunge che moltissimo si è perso della esatta significazione del vedico, già lo stesso Pāṇini, che ha codificato il sanscrito classico rendendolo una lingua “artefatta”, artificiale, non sapeva risalire adeguatamente a molte radici del vedico.
Le fasi dell’antico indoario (vedico e sanscrito) sono queste:
- 1500-1000 a.C.: Ṛg-Veda (parte antica);
- 1000-500: Ṛg-Veda (parte recente), Atharva-Veda, Yajur-Veda (parti in prosa); nella transizione tra vedico e sanscrito abbiamo i Brāhmaṇa e gli Āraṇyaka;
- 500-0: sempre nella transizione tra vedico e sanscrito abbiamo l’opera di Pāṇini (il primo grammatico del sanscrito), le Upaniṣad antiche e quelle medie, i Sūtra e i poemi epici nei loro albori (Rāmāyaṇa, Mahābhārata);
- 0-500 d.C.: in sanscrito abbiamo poemi epici (elaborazione), kāvya nei suoi albori (letteratura d’arte, il cui massimo esponente fu Kālidāsa, IV-V secolo);
- 500-1000: poemi epici (fissazione), Purāṇa, kāvya (fissazione), śāstra nei loro albori (letteratura tecnica e scientifica), darśana nei loro albori (letteratura filosofica);
- 1000-1500: śāstra (fissazione), darśana (fissazione), kāvya (epigoni);
- 1500-2000: darśana (epigoni), kāvya (epigoni).
I Veda sono composti in metrica. Ci sono forti affinità tra la metrica vedica e quella greca. Meillet dimostrò come la cosiddetta “base eolica” dei versi gliconici corrisponde alle prime quattro sillabe indifferenti dei versi di otto sillabe della strofa trimembre gayatri (xxxx ˘ – ˘x). Quest’ultimo metro, essendo la versione indiana dei versi gliconici, è sostanzialmente privo di cesura. Ora, dato che si tende a riconoscere al metro di otto sillabe la possibilità di espansioni sillabiche (sia in incipit che in explicit sia all’interno di esso) e quindi ad attribuirgli in nuce la poikilia dei versi eolici e di molti versi sanscriti, si pensa a un verso unico originario di otto sillabe. In seguito due studi molto importanti rispettivamente di Jakobson e di Watkins ricondussero alcune tipologie metriche del verso slavo e di quello celtico alla versificazione indoeuropea, confermando l’ipotesi di Meillet. Poi dopo qualche anno uno studio di West ricondusse le forme metriche studiate da Jakobson allo schema del triṣṭubh vedico e dell’ottonario, e inserì le scoperte di Meillet, Jakobson e Watkins all’interno di una ricostruzione globale della metrica indoeuropea.
Importanti metri vedici sono:
- Gayatri (8-8-8);
- Uṣṇih (8-8-12;
- Anuṣṭubh (8-8-8-8);
- Bṛhati (8-8-12-8);
- Pankti (8-8-8-8+8);
- Triṣṭubh (11-11-11-11);
- Jagati (12-12-12-12).
L’esametro, verso importantissimo della letteratura greca, sfuggiva all’esame comparativo. Solo i versi isosillabici “eolici” erano le strutture che offrivano spunti di confronto con le altre lingue indoeuropee, a detta di Meillet. Questo perché l’esametro presenta la isocronia (cioè due brevi corrispondono a una lunga), la quale non sembra presente nelle forme arcaiche della metrica dei popoli indoeuropei. Probabilmente il verso della poesia orale delle tribù indoeuropee era costituito da un numero fisso di sillabe, che si alternavano verosimilmente a forme catalettiche, e che iniziava con un numero di sillabe indifferenti. L’esametro invece, che non si lascia ricondurre a questo schema, probabilmente è di origine egea.
* * *
Non sempre una lingua può appartenere inequivocabilmente a una famiglia. Pensiamo al giapponese, considerato una lingua isolata, così come l’etrusco, il basco, il sumerico, forse l’egiziano antico, oppure menzioniamo altresì il coreano, la cui affinità a un dato gruppo non è così chiara.
Il coreano, l’attuale lingua ufficiale della Repubblica di Corea, è usato da circa 79 milioni di parlanti. Si divide in:
- Coreano preistorico (coincide con il protoaltaico e si estende fino all’inizio dell’era cristiana)
- Coreano antico (fino all’inizio del X secolo, periodo che coincide con quello dei Tre regni formati da Silla antico, 57 a.C.-676 d.C., Koguryo, 37 a.C.-668 d.C., Paekche, 18 a.C.-660 d.C., fino alla fine della dinastia Silla unificata, 668 d.C.-935 d.C.)
- Coreano medio (intero periodo del regno Koryo, X secolo-XV secolo, fino al 1592, anno dell’invasione della Corea da parte dei pirati giapponesi)
- Coreano moderno (che deriva da un antico dialetto coreano, via via sempre più sensibilmente sinizzato)
- Coreano contemporaneo.
Quasi tutti gli studiosi concordano nel considerare il coreano parte del ceppo linguistico altaico, composto principalmente dalla lingua turca, mongola e manciù-tungusa. Sono significative le somiglianze tra coreano e lingue altaiche: sono lingue SOV; i modificatori come aggettivi, avverbi, frasi subordinate precedono gli elementi modificati; ricorrono posposizioni al posto delle preposizioni; non si ha una distinzione netta tra singolare e plurale; non esistono articoli né pronomi relativi; la morfologia è rigorosamente di tipo agglutinante. Ricordiamo che questa ipotesi è stata dimostrata inconfutabilmente da Ramsted (1957) e Poppe (1960), quest’ultimo ha ricostruito non solo la fonologia e la morfologia del protoaltaico ma ha dato anche la definizione del quadro lessicale altaico originario descritto per il tramite di 570 radici comuni.
Tuttavia qualche studioso propende per la relazione tra coreano e lingue austronesiane da un lato e dravidiche dall’altro. Le prime sono quelle indonesiane, melanesiane, polinesiane e micronesiane. Ma le corrispondenze sono davvero poche. Meglio ipotizzabile è la parentela con le lingue dravidiche (tamil), ci sarebbero ben 400 corrispondenze lessicali, come pi del coreano e pej delle lingue dravidiche per indicare pioggia, oppure tari/tal per gamba; tal/til per luna; pul/pul per erba, e così via. Ohno (1981) ipotizza che nel coreano e nel giapponese ci sia insieme non solo uno strato austronesiano ma anche dravidico.
C’è anche chi pensa a una origine comune di coreano e giapponese. Hanno in comune ben 350 coppie lessicali. Ci sono similarità per quanto riguarda alcune marche di caso, alcuni suffissi verbali, alcune marche di interrogazione. Più della metà del lessico coreano e giapponese è accolto nel cinese, tuttavia per Martin non esiste un lessico di base davvero comune tra coreano e giapponese, ma solo di prestiti. È più probabile che il giapponese sia una lingua ibrida, formata dalla fusione di elementi altaici e austronesiani (ipotesi di Polivanov, 1960).
Le diversità tra le lingue si avvertono non solo nelle difficoltà a considerarle di una data famiglia o meno, ma anche nella traduzione. In greco esiste il verbo essere come copula (quando unisce un soggetto a un predicato, Marco “è” un uomo), ma in arabo no. Quindi come hanno fatto i traduttori arabi a rendere il greco to on, “ente”, participio presente sostantivato del verbo “essere”, letteralmente “ciò che è”? To on è parola chiave della Metafisica di Aristotele, il quale si rifà concettualmente a Platone e prima di tutto a Parmenide, il fondatore della metafisica occidentale. Il problema è spinoso anche nel greco stesso. La prima menzione della categoria di “essere” la abbiamo in Parmenide, con tutti i problemi linguistici e filologici, nonché filosofici che ne conseguono. I filologi ipotizzano che in greco vi fosse originariamente una radice *es con il senso di “essere” come “esistere”, la quale aveva anche la possibilità di unire un soggetto a un predicato fino a degenerare con il tempo nella funzione di semplice copula. Le due funzioni del verbo “essere” greco sono note come la dicotomia di Mill. A quale si riferiva esattamente Parmenide? Pertanto tutta la filosofia occidentale (metafisica) si baserebbe su un equivoco tra i due significati di essere: esistenziale e copulativo. Addirittura per Schofield Parmenide si riferiva allo stesso momento ai due significati: quindi l’essere di Parmenide sarebbe esistenziale e copulativo al tempo stesso.
* * *
I primi traduttori arabi della Metafisica di Aristotele per rendere to on hanno usato un derivato dal pronome arabo huwa. In arabo per dire Marco è un uomo basta dire: Marco-uomo. Oppure se nel contesto la relazione non è abbastanza chiara si usa il pronome huwa, quindi: Marco huwa uomo. Questo pronome non è una copula ma contiene il senso di copula. In questo modo i traduttori arabi hanno usato la parola huwiya per rendere “ente”. Il suffisso –ya dovrebbe derivare dal pahlavico (medio persiano).
L’arabo è una lingua semitica storicamente recente ma strutturalmente antichissima. L’arabo vero e proprio appare solo con il Corano nel VII secolo d.C, che fonda l’Islam. Era conosciuta una poesia beduina preislamica con il genere della qasida, il quale continua anche dopo l’avvento dell’Islam.
Sulla lingua del Corano è stato scritto molto. Questo libro sacro è suddiviso in 114 sure (o capitoli). Viene considerato una rivelazione fatta a Maometto da Dio per mezzo dell’angelo Gabriele. Ha una importanza dottrinale e teologica fondamentale, perché per l’Islam solo il Corano e la Sunna sono infallibili sulla terra, tutto il resto non è garantito da Dio come infallibile, anche le sentenze mistiche del sufismo, che è una sorta di esoterismo all’interno dell’Islam. Presso la comunità islamica il Corano ha un valore non solo contenutistico ma anche fonetico: la semplice recitazione delle sure, anche senza essere capite da genti non arabofone, può portare all’estasi.
Secondo l’ipotesi di Nöldeke, una parlata araba preislamica, precisamente quella detta al-Qurayš, attraverso il contatto con le altre parlate della Penisola arabica, sarebbe stata condotta a un graduale raffinamento, prima di diventare, grazie al Corano, la base dell’arabo classico. Quindi il Corano sarebbe espresso in una sorta di koiné letteraria, cioè lingua comune sovradialettale, artificiale, nata dalla unione e dalla purificazione dei vari dialetti arabici della Penisola, che quindi non sarebbe mai stata parlata nella quotidianità. Questa è la posizione della maggioranza degli arabisti occidentali. Ci sono molte evidenze che questa sia la verità riguardo la effettiva lingua del Corano. Non è un fenomeno così strano che da vari dialetti parlati si uniscano i tratti migliori per formare una lingua letteraria, artificiale usata solo per la poesia, pensiamo anche al sanscrito dell’India oppure al berbero del Marocco centro-meridionale, che a tutt’oggi usa per la poesia una lingua raffinata ottenuta da una sintesi delle parlate berbere locali. Del resto, stando alla produzione araba preislamica e a quella appena successiva alla conquista, si nota come le tribù erano isolate e parlavano dialetti diversi, anche se la lingua letteraria era unitaria: questo perché la lingua letteraria era artificiale, solo così infatti sarebbe stato possibile garantire la unitarietà letteraria nonostante la frammentazione politica.
I detrattori della teoria della lingua unitaria e artificiale del Corano pongono vari argomenti per sostenere la tesi contraria. Uno di questi è quello della declinazione. Le parole arabe, infatti, hanno una forma pausale e una forma declinata. La forma pausale è obbligatoria al termine di una frase o comunque prima di una pausa prolungata. Facciamo un esempio. Prendiamo la parola “libro”, in arabo kitab:
- La forma pausale dell’indeterminato è kitab per il nominativo e il caso obliquo;
- La forma pausale dell’indeterminato è kitaba all’accusativo;
- La forma pausale del determinato è al-kitab in tutti e tre i casi.
Invece la forma declinata si fa aggiungendo le marche dei casi, rispettivamente le vocali –U, -I, -A per nominativo, caso obliquo, accusativo. All’indeterminato si aggiunge una –N finale (tanwin), fenomeno detto di nunazione.
Nel pronunciare l’arabo bisogna fare molta attenzione a dire la parola in forma declinata quando è all’interno della frase e in forma pausale quando è alla fine di un membro o di una proposizione o presa singolarmente. È sbagliato quindi usare la forma declinata per una parola presa a sé stante o a fine frase. Questa regola è particolarmente importante nella recitazione coranica, dove una apposita sigla segnala i passi in cui è necessario adottare la forma pausale. In questi casi pronunciare la parola come declinata farebbe perdere l’effetto fonetico del brano, anche se la marca della forma declinata è riportata nel testo coranico.
Ora veniamo a noi. Ci sono esempi nel Corano nel quale si evince come il tanwin non è presente nello scheletro consonantico delle parole. Questo perché, dicono i sostenitori della lingua artificiale, esso non era realmente pronunciato, ma fu aggiunto in seguito sul modello di una lingua letteraria non parlata.
Però gli altri studiosi, quelli che sostengono che il Corano esprima una lingua realmente parlata, osservano che la grafia dell’arabo sembra riflettere la forma pausale e non quella declinata. Per esempio, nella parola kalb (forma pausale kalb) il tanwin non è presente nello scheletro consonantico, mentre la alif (a) dell’accusativo indeterminato (forma pausale kalba) è sistematicamente riportata, come richiedono le regole della forma pausale. Quindi da ciò si presume che la lingua del Corano rifletta meglio la forma pausale. Perché? Perché l’arabo del Corano sarebbe stato un arabo effettivamente parlato, nel quale cioè le forme pausali sono evidenti.
Un caso interessante di forme dialettali arabe trascritte in caratteri greci è il testo damasceno del Salmo 78, 77 della Bibbia. Il copista dell’VIII secolo aveva davanti a sé il testo arabo e lo traslitterava in caratteri greci per quei cristiani arabizzati che conoscevano anche il greco. Ai versi 11-12 troviamo scritto: oamithl raml elbouchour, “come la sabbia del mare”. Si noti la perdita dei casi, tipica di tutti i dialetti arabi; la pronuncia el- dell’articolo arabo al-, tipica dei dialetti arabi magrebini.
Questa è indubbiamente una testimonianza scritta di arabo dialettale già nel VIII secolo. Per i sostenitori della koiné coranica, i dialetti arabi già c’erano al tempo di Maometto e quindi il Corano, che non evidenzia un unico dialetto in particolare, rispecchierebbe una lingua non dialettale ma per l’appunto artificiale (koiné), magari influenzata da più dialetti. Invece altri ritengono che nel Corano ci sia la lingua effettivamente parlata allora e i dialetti si siano formati sostanzialmente solo in seguito. Quindi il Salmo damasceno fa propendere verso la prima ipotesi, per la quale al tempo di Maometto, cioè il VII secolo (o subito dopo), vi era già una situazione linguistica araba frammentata in dialetti.
La lingua araba presenta affinità con il binomio linguistico amorreo-ugaritico. Infatti in arabo la congiunzione –an e l’articolo al- deriverebbero dall’aggettivo dimostrativo ugaritico HND. Voigt si spinge ancora più indietro e sostiene che l’articolo determinativo arabo al- derivi dall’accadico annum, che troverà attestazione nell’ugaritico hnd del II millennio a.C. per dare origine infine all’articolo arabo al-. L’amorreo, assieme all’accadico, è una antica lingua semitica della Mesopotamia. L’accadico appartiene al semitico orientale, l’amorreo appartiene al semitico occidentale (è un dialetto occidentale dell’ugaritico).
Tuttavia oggi gli studiosi non accolgono del tutto la tesi amorreo-ugaritica. È vero che l’arabo condivide con l’ugaritico queste caratteristiche, e anche il cosiddetto “modo energetico”, ma la presenza della nunazione lo fa avvicinare anche al cananaico. Ragion per cui si ritiene che l’arabo derivi dal contatto dell’amorreo con il sostrato cananaico.
L’unica testimonianza dell’amorreo è costituita, oltre a dei nomi mesopotamici, dalle iscrizioni protosinaitiche. In queste iscrizioni abbiamo forme vicine al cananaico (rb, “capo”, ‘hb, “amare”, b’lt, “signora”). Ma ci si aspetterebbe il plurale maschile –m come in cananaico, invece lo abbiamo in –n (come in arabo). Pertanto si ipotizza che la lingua di queste iscrizioni derivi dall’amorreo per contatto su un sostrato linguistico ancora poco chiaro, comunque sia vicino al cananaico.
Per Garbini l’arabo sarebbe l’estrema propaggine meridionale dell’amorreo. Garbini si riferisce ai primi parlanti arabi. In seguito l’arabo nascerebbe come lingua più evoluta solo verso il V secolo a.C. quando compaiono i suoi tratti distintivi: l’articolo al- e il mantenimento del fenomeno della declinazione (con le tre marche dei casi: U, I, A).
La lingua del Corano è l’arabo, certamente, ma questo testo sacro risente anche di influssi da parte del siriaco, un dialetto aramaico orientale. Ai tempi di Maometto in Arabia vi era una situazione di diglossia, gli arabi parlavano i dialetti arabi ma anche il siriaco/aramaico, che erano lingue franche e internazionali. Dovevano comprendere pure il greco. Nel Corano la maggior parte dei prestiti deriva dal siriaco tanto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che il Corano sia stato scritto in siriaco e solo dopo tradotto in arabo. Gli influssi del siriaco sono a volte molto importanti. Facciamo un esempio. In 43, 70 è scritto: “Entrate nel paradiso, voi e le vostre donne, sarete onorati”. In arabo “sarete onorati” è tuḥbarūn, forma passiva di ḥabara interpretata nel senso di “essere onorato”. Ma in questo contesto suona meglio lo ḥbar aramaico, “raccogliere insieme”. Quindi abbiamo a che fare con una parola araba, certamente, ma il cui significato è ampliato da quello di una parola aramaica: “Entrate nel paradiso, voi e le vostre donne, sarete riuniti”. Fenomeni di questo tipo, cioè non esattamente prestiti ma estensioni di significato, sono comuni nelle lingue antiche. In una famosa iscrizione bilingue nabateo/araba (il nabateo è un altro dialetto aramaico) è scritto: “Che siano ricordati i costruttori e i suoi compagni (‘ḥbr-w), che hanno costruito la tomba della madre”. Ora, la parola ‘ḥbr-w è tecnicamente un plurale fratto arabo, ma ha senso solo secondo il significato della radice aramaica e quindi viene intesa come “compagni”.
Una delle sure più importanti del Corano è la 112, detta Cuore dell’Islam, che riportiamo nell’originale arabo:
qul huwa-llāhu ahadun
allāhu-s-samadu
lam yalid wa lam yūlad
wa lam yakun lahu kufuan ahadun.
“Inneggia: Lui! Il Dio! Egli è unico!
Il Dio è il samadu.
Non genera e non è generato.
Nessuno gli è uguale”.
Sono 4 versetti dalla struttura metrica quasi regolare (7+5+7+7) e terminano tutti quanti in –ad. Il pronome huwa non è necessario per la grammatica, ma qui compare in senso enfatico, per esaltare Dio. “Egli è unico”, ahadun, è una frase nominale formata dalla parola “unico”. La parola Allah non indica il nome proprio di un Dio, come può essere Zeus, bensì la divinità in genere (probabilmente è formato dall’articolo determinativo arabo al + al/el, la radice semitica della divinità, quindi vuol dire propriamente “il Dio”, Iddio). Samadu è di difficile traduzione, alcuni rendono con “eterno” oppure “assoluto” oppure “incorporeo”. La traduzione “eterno” è del celebre asceta del I secolo dell’egira al Ḥasan al-Basrī; il fatto che i commentatori rendono la parola samadu in modo assai diverso indica che il significato era già a loro sconosciuto. “Non (lam) genera (yalid) e (wa) non (lam) è generato (yūlad)”: attivo e passivo maschile singolare del verbo walada, “generare”, nella forma grammaticale detta energetico-iussivo. La negazione lam dovrebbe dare alla forma energetico-iussiva un valore di passato (“non ha generato e non è stato generato”), ma altri danno al verbo un valore di passato storico, quindi si traduce con il presente. Certamente la negazione di una azione del passato dà in questo contesto un senso di eternità, ribadendo il samadu.
Dopo la morte di Maometto e dopo i 4 califfi “benguidati”, segue il califfato omayyade (dal 661 al 750, trae il nome da quello di una potente famiglia meccana) a Damasco (l’inizio del califfato omayyade si deve a Muʿāwiya ibn Abī Sufyān). Avviene l’espansione e si forma uno stato multinazionale, ma con accentramento dei poteri nelle mani di arabi. Abbiamo uno spostamento verso nord, il centro di potere non è più l’Hijaz ma è Damasco, nuova capitale dell’impero islamico sotto la guida degli omayyadi. C’è il problema dell’impatto dei neo-convertiti non arabi e quello del nuovo ambiente multi-culturale. Siamo in una fase molto importante storico-politica, con espansione oltre i confini dell’Impero: si arriva fino all’Egitto. Questa espansione fa sì che sono accorpate tutte le altre comunità che vengono islamizzate. Certamente un fatto problematico è quello di uno stato multinazionale che deve tenere sotto controllo tutti i vari aspetti multi-etnici. I non arabi musulmani non godevano degli stessi privilegi dei musulmani arabi. Letterariamente, si ha un elemento di ricchezza e di eterogeneità nella produzione che raggiungerà il suo apice nell’epoca abbaside. Importanti lasciti dell’impero omayyade sono importanti moschee: la Cupola della Roccia a Gerusalemme su ordine del Califfo Abd al-Malik (687-691) e la Moschea al-Umawiyyin, Damasco, califfo al-Walid I (706).
Abbiamo queste innovazioni letterarie durante il periodo omayyade:
- Nascita della prosa: conseguenza della rivelazione islamica e della Sunna e della sistematizzazione del suo sapere. Avvengono i primi studi della lingua araba, che deve essere depurata da elementi pre islamici
- Nascita di katib: segretario, funzionario di corte
- Gli Hadith, detti di Maometto, sono tramandati attraverso la catena dei trasmettitori; compare la Sira, la prima biografia della vita del Profeta; compare il maghazi: l’espansione islamica fa si che bisogna raccontare le conquiste, si tratta di una narrazione di tipo bellico-militare in particolare le conquiste dei Banu Walid, confluiranno poi negli ‘Annali’
- Nella poesia abbiamo la nuova figura poeta cortigiano. La figura del poeta cambia, poiché adesso deve esaltare il vicario di Dio in terra, lode al califfo o ai suoi deleganti nelle regioni più lontani, capi non solo politici ma anche religiosi. Difensore della comunità islamica e interprete dei suoi valori. I generi precedenti permangono, l’encomio diventa uno dei generi più eminenti.
Specificatamente nella poesia avviene questo:
- Poesia Kharigita: resta la poesia istituzionale ovvero quella dei kharijiti, esempio poesia devozionale: esaltazione dell’eroismo, cioè coraggio e impegno sulla strada di Dio
- La qasida (genere preislamico) diventa politematica, cambia la sua struttura
- Affermazione del Ghazal, che è una poesia d’amore. Abbiamo un Ghazal urbano hijazena (rappresentazione di una donna libera e spietata, che scappa dalle attenzioni dell’uomo) e un Ghazal beduino (ambiente desertico udhrita, dove udhrita è il clan di riferimento di uno dei primi cantori, hanno la stessa modalità compositiva e la stessa fine tragica).
- Permane la poesia beduina, quella di cantori del deserto
- La poesia si evolve, non è più beduina ma diventa urbana, legata alle corti e dell’ambiente cittadino
- Poesia califfale, in cui gli stessi califfi si cimentano in versi ad esempio: il califfo Yazid l’omayyade
- La poesia colta: la “triade” ha una posizione di primato sotto il califfato omayyade, tre massime espressioni e poeti in questa fase: al-Akhtal, Jarir, Farazdaq. I vari temi spaziano da effusioni liriche alla celebrazione del vino fino a invettive contro i nemici. Abbiamo anche Al-Naqa’id (radice: na qa ba), cioè delle controversie tra poeti, botta e risposta tra le rime. Introducono l’elemento di invettiva e una profonda ironia, con un linguaggio che siccome deve essere offensivo a volte è molto rude e violento.
Sotto il dominio abbaside la letteratura araba subisce delle profonde trasformazioni. Emerge un nuovo rapporto del poeta con l’ambiente in cui vive, che non è più il deserto dei beduini, insomma l’ambientazione diviene sempre più urbana fino a perdere ogni connotato con il deserto. Altro aspetto legato al tema dell’innovazione: si iniziano a intravvedere forme di innovazione letteraria. Nella qasida non è riconosciuto l’enjabement, il poeta lodato dalla critica è quello in grado di mantenere in un solo verso l’immagine. Altro aspetto fondamentale è quello del metro: i metri verranno fissati in epoca post islamica (dopo Maometto), in epoca abbaside vengono fissate la specificità di alcune questioni. Ha origine la metrica araba in termini di classificazione di tutti i metri e classificazione di tutte le possibilità, sono schemi molto rigidi e hanno costituito la base irremovibile fino ad un secolo fa. Sui temi l’innovazione è ben avviata, in quest’epoca si inizia un nuovo discorso poetico.
Nella qasida non è riconosciuto l’enjabement, il poeta lodato dalla critica è quello in grado di mantenere in un solo verso l’immagine. Altro aspetto fondamentale è quello del metro: i metri verranno fissati in epoca post islamica (dopo Maometto), in epoca abbaside vengono fissate la specificità di alcune questioni. Ha origine la metrica araba in termini di classificazione di tutti i metri e classificazione di tutte le possibilità, sono schemi molto rigidi e hanno costituito la base irremovibile fino ad un secolo fa. Sui temi l’innovazione è ben avviata, in quest’epoca si inizia un nuovo discorso poetico.
L’Impero abbaside (750-1258) è la nuova grande stagione dell’Islam, dopo quella omayyade. Nel 749 a Kufa (Iraq): Abu-l’Abbas al-Saffāh, detto il sanguinario, si proclama nuovo califfo, in seguito a una rivolta anti-omayyade: gli omayyadi non accettavano i musulmani non arabi. Avviene il trasferimento della capitale a Baghdad. Gli omayyadi regnano circa 100 anni e poi verranno sterminati tranne qualche elemento che si sposterà in Andalus e fonderà uno dei più grandi centri arabo-andalusi. La dinastia che subentrerà a quella omayyade, è quella abbaside che durerà diversi secoli. Lo spostamento geografico della capitale determina uno scenario particolare legato alla eterogeneità dell’impero e della accettazione delle nuove etnie, volevano costruire una nuova comunità islamica (umma)in cui tutte le etnie fossero partecipi, conservando la loro identità che diventa una ricchezza. Quindi abbiamo a che fare con un Impero multi etnico-culturale, nel quale vi fu un forte influsso delle traduzioni del Corano nelle lingue locali. Ci fu un importante ruolo di persiani e turchi islamizzati come Kuttāb negli affari dello Stato. Periodo importante per la cultura grazie all’ingresso del dominio e della cultura arabo musulmana in Europa con la Spagna e il sud Italia.
Il letterato, Adib, non è soltanto lo scrittore ma ha anche una funzione pedagogica e a volte didascalica, talvolta deve descrivere anche i rapporti tra il sovrano e i suoi sudditi. La varietà di etnie viene messa in mostra dalla pluralità di generi e di diverse correnti e visioni. Da segnalare il movimento della Shu’ūbiyya, formato da non arabi che reclamano la superiorità culturale delle loro etnie originarie. Ecco alcune parole di un rappresentante, Bashshār ibn Burd, poeta persiano abbaside (m. 783):
“Dov’è un emissario che canti per tutti gli arabi?(…)
Io sono una persona di nobili natali, elevati al di sopra gli altri.
Cosroe è l’antenato dal quale io derivo la mia preminenza e Sāsān era mio padre (…)
Egli non cantò niente di cammellieri seguendo una bestia rognosa,
Né forò l’amara coloquintide per sete (…)
Né strappò alla terra una lucertola per mangiarla (…)”.
Avviene una crescita di questa visione di tale componente non araba, specialmente i persiani e i turchi, che rivendicano la loro origine nobiliare e quindi un determinato grado politico. Si rimarca l’uguaglianza di tutti i popoli, musulmani, anche di diverse etnie, uguaglianza non presente nel califfato precedente.
Lo sviluppo delle scienze e l’atteggiamento positivo dell’Islam verso il progresso tecnico e scientifico, trasformarono gli arabi nei continuatori dell’eredità culturale greca, da cui trasse beneficio lo stesso Occidente cristiano. Aspetto legato allo studio dei classici greci, eredità greca filosofica e platonica che inizierà ad incidere sulla cultura arabo islamica. Pensatori importanti dell’età abbaside furono Al-Jahiz (m. 869) e Ibn Rumi (m. 896), rappresentanti dell’ellenismo arabo. Alcuni critici arabi e anche studiosi occidentali europei definiscono questi pensatori esempi di ellenismo arabo, forma di rimodulazione del pensiero greco sulla base di un pensiero islamico, esigenza di sintesi tra Islam e pensiero greco.
Il dibattito teologico/scientifico porta a nuovi stimoli intellettuali, una sintesi interessante e calzante di questo discorso vede una commistione di stili, saperi, generi e eredità che vanno a fondersi e costituire il nucleo della conoscenza dell’epoca caratterizzato dal pensiero mu’atazilita. Esso è una dottrina che viene da pensatori dell’area iraqena e iraniana, ha un nome controverso: indica sia qualcosa da cui prendere le distanze, sia la rinuncia a prendere una posizione (=neutralità).
Questa dottrina serba un approccio speculativo-razionalista all’interpretazione del Testo Sacro. La sua visione subisce l‘influsso del pensiero greco, che si unisce all’interpretazione dei testi sacri. Ovvero il tentativo di analizzare razionalmente il dettato coranico. È un qualcosa contro cui molti fondamentalisti combatteranno istituendo anche un nuovo pensiero, al quale si rifanno tutt’oggi alcuni fondamentalisti islamici. Per questi il pensiero mu’atazilita aveva deviato dalla ortodossia islamica e bisognava riportare la umma nella retta via.
Il Corano è parola di Dio, ma “creata”, ossia frutto di eventi storici. Ovvero che c’è la responsabilità dell’uomo e l’intervento umano. Avvenne anche l’affermazione della dottrina del “libero arbitrio”, cioè dell’uomo responsabile dei suoi atti. Il peccato è un attributo dell’umanità, perché Dio “il giusto” non può “ordinare il male”. Per gli ulema dell’epoca, invece, ogni atto umano è “creato” da Dio, creatore di ogni cosa. Invece per il pensiero mu’atazilita l’uomo è responsabile delle proprie azioni e del male che crea. Questo discorso di dare centralità all’uomo crea dei problemi sul piano sia teologico che della gestione politica.
Avvento di una nuova dottrina di Stato con al-Ma’mun (m. 833), istituzione di una Mibna, inquisizione. Per legittimare la dottrina, decide di operare in modo rigoroso istituendo una inquisizione per far si che tutti seguano in modo stretto la dottrina coranica.
Per accennare al fermento culturale sotto gli abbasidi, basti pensare a:
- Formazione di scuole e biblioteche sia per divulgazione religiosa che culturale
- Nascita della Madrasa: istituzione musulmana con alloggio e sussidio agli studenti. Successivamente nasceranno delle istituzioni culturali, nelle quali verranno studiati e tradotti molti testi
- Nascita dell’Azhar al Cairo (970) ad opera dei Fatimidi. Ancora oggi è la massima istituzione religiosa
- Casa della Sapienza di Baghdād (830 in poi) nasce dalla biblioteca privata di Harun al-Rashīd divenne un’istiuzione pubblica sotto al-Ma’mūn. Periodo di grandissima e intensa attività di traduzione.
Vengono raccolti gli Hadīth (detti di Maometto) e le tradizioni religiose e giuridiche. Ci fu forte diffusione delle scienze del linguaggio: grammatica e linguistica. Si ha per un certo verso la glottodidattica, uno dei massimi studiosi di lingua araba è di origine persiana e i critici letterari lo dichiareranno come uno dei migliori linguisti della lingua. Scuola grammatica di Basra, che vide come protagonisti i persiani come Sībawayhi (m. 793). Nella lessicografia si sentì la necessità di sistematizzare la lingua per i non arabi. Daranno un aiuto straordinario alla sistematizzazione della lingua soprattutto i musulani provenienti dall’area iranica.
Per quanto riguarda la poesia, Ibn Qutayba (828-899) definisce il prototipo della qasida: forma, struttura e temi (primo apporto alla critica poetica). Prima di lui nessuno aveva elaborato la visione di strutture e temi della qasida, alla quale solo adesso si dà una definizione precisa e critica e su come va scritta. La qasida deve avere un destinatario, un metro stabilito, con la stessa rima unica, avere una serie di temi. Da lì si svilupperanno una serie di nuovi apporti. Khalil ibn Ahmed al-Farahidiyy (m. 791) fissa un sistema metrico normativo composto da 15 metri (buhūr), basati su 10 unità metriche (piede, taf’ilah). Egli è il teorico della metrica araba.
Solo con gli abbasidi ci fu un primo momento autentico di innovazione tematica e stilistica. La poesia diviene riflesso di ambienti raffinati, originale apporto dei mawali. Riflette questi ambienti di corte. La poesia è un contenitore della vita degli ambienti dell’epoca. Nella poesia l’amore e la bellezza sono espressi nel genere detto Ghazal.
C’è anche il madīh (panegirico) dei califfi, che resta un motivo centrale. Il panegirico è la poesia di corte, deve celebrare la grandezza del califfo ed eternare la sua memoria fissando la sua grandezza. Deve anche riaffermare il timbro dell’Islam ed esaltare la potenza dell’esercito e quindi dell’operato divino.
Nella poesia avvenne una apertura a più temi e registri. Restano questi temi centrali ma c’è una diversificazione. Il poeta riesce all’interno della stessa qasida a inserire più temi.
In epoca abbaside vi era una querelle tra conservatori e innovatori nella poesia. I muhāfizūn sono conservatori, invece i muhdathūn sono gli innovatori, che propongono un nuovo ideale che non era presente nella poesia precedente.
Badī’ è il concetto nuovo relativo all’uso di una lingua ricercata, allusiva. Visione della poesia come arte, in modo affascinante descritta da questo concetto. Propone qualcosa di nuovo, l’arte come fattore artistico: è una nozione estetica che racchiude l’ideale di una lingua più dinamica, che si muove e che tende alla creatività. È un tentativo di innovazione, dare centralità all’idea di innovazione. Passa alla storia con una serie di caratteristiche legate ad un ampia vastità di peculiarità:
- Accostamenti inediti di immagini. È possibile ora correlare 2 elementi contrastanti come la luce e il buio
- Nuove strutture Revisione degli apparati interni alla poesia attraverso l’utilizzo di nuove tecniche prima inutilizzate poiché impensabili
- Sviluppo di immagini retoriche. Prima erano estranee alla visione poetica degli arabi.
- Antitesi. Il contrasto tra due immagini.
Abū Nuwās (756-814) rompe il modello politematico del poema tradizionale, compone carmi bacchici, canta amori illeciti e ammoderna il linguaggio.
Abū Tammām (805-845) ha la fama legata al canzoniere Hamāsā, nato come un lungo poema epico poi integrato da poesie di vario genere. Hamāsā è la virtù guerriera. Questa specie di antologia del valor guerriero definisce il concetto della virtù in battaglia e della capacità di scrittura del poeta a corte. Lungo poema epico integrato da altre poesie.
Al-Mutanabbī (915-965) è un poeta-militante. Rinnova l’orgoglio dell’arabicità affermando la dimensione moralizzante del poeta vate e con toni anche dispregiativi verso altre etnie. Poeta di corte vagabondo a cui si riconduce il discorso del canone arabo classico centrato sul tema dell’orgoglio della propria essenza. È uno dei conservatori sull’ambito dello stile.
Sviluppo della poetica mistica e ascetica (zuhdiyya). Molti di questi poeti pagheranno la loro vocazione con la vita.
La poesia è quel luogo dello spazio culturale della città islamica classica in cui ogni fuga, ogni eresia, ogni trasgressione è lecita – purché sia detta secondo le austere regole del linguaggio poetico. Il tema del rapporto tra espressione poetica e corte è dialettico. La dimostrazione più ovvia di questo equilibrio estetico e sociale è forse data dalla constatazione che, in una società in cui vige il divieto coranico di assumere bevande inebrianti, il canone letterario celebra fra i suoi generi più frequenti quello della khamriyya, ovvero la poesia in lode del vino. Segno evidente, questo, di una differenziazione dei codici di comportamento, e di una società complessa in cui convivono e l’etica religiosa e l’etica profana – e di quest’ultima, la cultura cortese è una delle emanazioni più visibili. Per cultura cortese si intende la cultura delle corti in cui l’etica profana è ammessa come divertimento, il confine tra illecito e lecito si sfuma, solo in determinati contesti e a determinate condizioni. Di nuovo, un altro paradosso: se la trasgressione è ancora un fatto di canone, il poeta deve vivere una vita scellerata. Se Abū Nuwās è il più grande poeta dell’età abbaside, la sua biografia non può che essere la più scellerata di tutte. Come sia possibile che un persiano in quegli anni a corte scriva determinate cose come l’amore omosessuale o la contrapposizione tra donna e vino? La poesia di corte è anticonformista.
Approfondiamo un attimo Abu’l ‘Alā al-Ma’arrī (973-1057), siriano, dotto studioso e poeta-filosofo, rientra nel trend dei muhafisuz ma introduce una serie di novità riguardo i temi trattati che gli daranno una risonanza importante. Fu riscoperto in una fase successiva con il periodo del risveglio, in questa rinascita abbiamo un ripristino dell’antico. Paladino di una prosa ricca, ampollosa e un po’ artefatta (a causa della estrema elaborazione) e di una poesia spinta all’estremo di una sperimentazione prosodica. Viene considerato comunque un conservatore riguardo allo stile. Per questo autore bisognava rifarsi alla prosa del Corano e alla poesia dell’epoca precedente.
Il contesto del luogo dove è nato influenza le sue opere, si sente soffocato, infatti poi emigrerà a Baghdad, dove farà la vita di intellettuale cortigiano che poi percepirà come stretta e contraddittoria e tornerà al suo paese originario. Emerge nella sua opera il tema della migrazione e quello della nostalgia di casa, del territorio di riferimento, che è la casa natale, in cui si è radicato, riferimento spaziale per i musulmani di quel epoca è il dar al-Islam. Per via della sua meditazione filosofica ed esistenziale, da molti è considerato più un filosofo che un poeta. Riflette su Dio e sulla sua esistenza, emergono ateismo e scetticismo. Subisce molti lutti.
Elenchiamo alcune opere maggiori di al-Ma’arrī. Luzumiyyāt o luzūm mā īalzam: Le costrizioni non obbligatorie. È un riferimento allo schema e alla struttura di rime, molto precisa, di queste poesie. Sono 113 sezioni poetiche. Si allude ad una rima complessa che si impose in modo virtuosistico: due consonanti in rima e l’uso in rima di tutte le lettere dell’alfabeto. Si caratterizza per ricerca stilistica legata alla dimostrazione di una conoscenza di ciò che viene richiesto alla poesia tradizionale. Ci sono tutte le possibilità della rima ed esplora il linguaggio. Sul piano dei contenuti sarà questa gabbia che lui si impone a costituire l’ossatura del suo pensiero filosofico con il quale mette in dubbio la presenza di Dio (in alcuni scritti, mentre in altri la riafferma). Usa ilghāz al-badī’i, indovinelli che solo pochi potevano scogliere.
Risālat al ghufrān (o Epistola del perdono) sul viaggio nell’oltretomba e i suoi incontri con letterati e poeti illustri in toni tragicomici. Con temi profondi e seriosi contrapposti a ilarità. È interessante vedere come ci siano delle interconnessioni con la Divina Commedia. È un’opera molto importante che non ha avuto circolazione in quegli anni.
Al-Ma’arri contestava l’innovazione che rischiava di introdurre contenuti eterodossi, bisognava rifarsi alla tradizione linguistica sancita dalla gahilliyya (poesia preislamica), il Corano e la poesia classica. Ha scritto anche molti trattati, ‘adab. Dal punto di vista poetico vi sono i generi di: falsafa (riflessione filosofica) e shi’r (poesia allo stato puro). Si avverte l’influenza del pensiero ellenico, che caratterizza sia la scrittura sia la sua visione. Il dolore della vita terrena ha come unico rimedio la buona azione, il comportarsi in modo pio e benevolo. Forse il suo pessimismo era dovuto alla cecità, ma anche ai molti lutti.
Scrive poesie brevi con l’utilizzo della qasida caratterizzata dalla frammentazione dei versi, in cui emerge la visione scettica della vita terrena. Non formulò una teoria precisa e spesso i suoi testi presentano elementi di contraddizione, unico punto fermo è la scepsi. La sua contraddizione è dovuta a molte ragioni, tra cui la censura. L’unica certezza che si ha del suo pensiero è l’idea di sfiducia.
* * *
Passiamo a un altro ambiente delle lingue semitiche, quello della Bibbia. La Bibbia non è un solo libro, ma una intera “biblioteca”, composta da scritti assai diversi tra loro e di epoca differente. La Bibbia, infatti, è formata da 73 libri: 46 costituiscono l’Antico Testamento, 27 il Nuovo Testamento. La parola Bibbia deriva dall’espressione greca ta biblia, “i libri”. L’Antico Testamento è redatto prevalentemente in ebraico biblico, con alcune sezioni in aramaico (in Esdra e in Daniele) e con sette libri in greco. Il Nuovo Testamento ci è giunto tutto in greco. Ebraico e aramaico sono lingue semitiche, il greco una lingua indoeuropea. L’Antico Testamento è stato scritto durante il I millennio a.C., invece il Nuovo soltanto nell’arco del I secolo d.C.
L’ebraico biblico, cioè quello utilizzato nell’Antico Testamento, è suddiviso in due varianti principali: quello preesilico (cioè prima della caduta di Gerusalemme del 586 a.C. per opera del babilonese Nabucodonosor che deportò la popolazione; è l’ebraico ad esempio del Primo Isaia) e quello postesilico (è l’ebraico ad esempio di Ezechiele).
L’ebraico postesilico è caratterizzato da numerosi aramaismi, come la costruzione perifrastica verbo essere + participio; elisione di aleph in fine di sillaba o di parola, la spirantizzazione delle consonanti (bgdkpt), la neutralizzazione dei fonemi velari e faringali, è operante la legge di Philippi (per la quale /i/ breve diventa /a/ in sillaba chiusa accentata), la legge dell’attenuazione (in certi contesti /a/ diventa /i/), la riduzione di certe vocali a schwa, la riduzione delle consonanti doppie finali, e così via.
Esiste una differenza anche tra ebraico della prosa e ebraico della poesia. La prosa preesilica si distingue da quella della poesia arcaica per il fatto di essere assai più stabile nell’uso dell’articolo e della particella ‘et (nota accusativi), nonché nella distinzione che opera tra le forme verbali semplici e quelle con il waw intensivo; le particelle asher e ki divengono più numerose e di uso più frequente, riducendo così la ricorrenza delle strutture asindetiche.
Per molti l’ebraico biblico non sarebbe una lingua unitaria bensì una lingua che unisce elementi assai diversi (Mischsprache). Abbiamo uno strato più antico (affine all’accadico) e uno strato più recente (affine all’aramaico e al semitico meridionale) Alcuni elementi dell’ebraico, come i tempi consecutivi, presentano una forte parentela con l’accadico. L’argomento che meglio illustra questa teoria è la presenza di forme come qām, “egli sorse”, e rām, “egli fu innalzato”, dove la transizione da /ā/ a /ō/ non ha ancora avuto luogo (come invece negli altri dialetti cananaici), e che si contrappongono ad altre forme come nāqōm, “sorgeremo”, e mārōm, “altitudine”, dove invece la transizione è avvenuta.
Questa teoria ha suscitato aspre polemiche. I detrattori pensano che si tratti di forme dialettali senza bisogno di accettare la nozione di due livelli di struttura morfologica nel verbo concavo (del quale sono esempi le forme verbali citate).
L’ebraico biblico è una lingua povera (ha solo 5000 parole diverse) e arcaica (sintassi semplice e di preferenza paratattica, manca di un vero e proprio sistema ipotetico). Compensa questo con una polisemia esagerata (spesso il verbo è intraducibile per via dei molti significati che può assumere). Oltre il 25% delle parole della Bibbia ricorre una volta sola; di queste non meno di 289 appartengono a radici che nell’ebraico biblico sono usate una volta soltanto. Gli studiosi cercano di continuo di stabilire il loro significato esatto sulla scorta dell’ebraico rabbinico e delle altre lingue semitiche (filologia comparata), oppure analizzando le parole nel loro contesto.
L’aramaico biblico è costituito di sole 600 parole, delle quali circa la metà ricorre una sola volta. L’aramaico di Esdra è quello detto imperiale (vicino alla lingua dei papiri di Elefantina), mentre l’aramaico di Daniele è quello successivo, detto medio. Il greco biblico è la koiné dialektos, cioè la lingua comune ellenistica, una variante sovradialettale che si impose nel periodo ellenistico (l’ultima fase del greco antico).
Il problema delle traduzioni della Bibbia, e dei relativi problemi linguistici di queste operazioni, affascina e impegna gli studiosi. Con l’esilio babilonese gli ebrei si trovarono sradicati dalla loro terra di origine e impiantati in un contesto internazionale dove la lingua ufficiale era l’aramaico, quindi perdettero progressivamente la conoscenza dell’ebraico, che restò quella della Bibbia letta solennemente, e iniziarono a parlare quotidianamente l’aramaico, usato dalle comunità giudaiche palestinesi e della diaspora orientale fino all’avvento dell’Islam.
Per questa ragione sorsero i targum, che sono traduzioni aramaiche della Bibbia ebraica. Inizialmente e per lungo tempo fu proibito servirsi di un targum scritto, poi la regola scemò lentamente e oggi disponiamo di targum per tutti i libri della Bibbia ebraica. La tradizione talmudica fa risalire la nascita dei targum appena al ritorno dall’esilio.
Il targum era sentito come un sussidio per far comprendere l’originale ebraico a chi non lo comprendeva e per spiegare i passi più difficili. Nella sinagoga innanzitutto si leggeva la Bibbia ebraica e poi il passo veniva commentato oralmente sì da creare un targum.
I targum e i midrash (cioè le interpretazioni della Bibbia raccolte nel Talmud) sono testimoni privilegiati del passaggio tra Antico Testamento e Nuovo Testamento. Gli autori neotestamentari, infatti, prendono spesso spunto da questi antichi testi ebraici per incorniciare la storia di Cristo e per motivare certi insegnamenti con lo scopo di evidenziare la continuità con il mondo ebraico.
Oggi gli studiosi ritengono che la traduzione dei targum sia letterale, anche se aggiunge a volte delle parti per rendere comprensibile il testo ebraico quando è poco chiaro. Per esempio in Genesi 1, 2 il tohu bohu, cioè l’assenza di vita, viene esplicitato dal targum come segue: “La terra era informe e deserta, senza uomini né animali, priva di qualsiasi forma di vegetazione …”. Le traduzioni rivelano spesso una mentalità popolare che coltiva il gusto del meraviglioso. La Bibbia viene spiegata con tutta la Bibbia, secondo un principio rabbinico ben consolidato: non c’è un prima né un dopo nella Torah. In questa maniera l’inimicizia che Dio instaura tra il serpente e la donna è vista secondo la luce della vittoria che riporta la discendenza di Eva grazie all’osservanza della Torah (cf. Genesi 3, 15). L’aramaico dei targum presenta molte volte degli arabismi.
Un’altra importante traduzione della Bibbia ebraica è quella in greco detta Settanta, i cui manoscritti più antichi risalgono al II secolo a.C.. Nell’età ellenistica il greco era divenuto la nuova lingua della cultura, quindi gli ebrei sentirono l’esigenza di rendere le Scritture in questo idioma. È una traduzione talmente importante che nei vangeli tutte le citazioni dell’Antico Testamento sono desunte dalla Settanta.
Essa venne presumibilmente approntata dagli ebrei della diaspora che stavano ad Alessandria d’Egitto. In questa città sin dalla fondazione vi era sempre stata una comunità di ebrei e in quel torno di tempo gli ebrei godevano dell’appoggio del sovrano. Ma secondo lo spirito ellenistico erano accettate (o comunque non perseguitate) altre etnie, quindi gli ebrei vollero in qualche modo legittimare la loro presenza e chiesero al sommo sacerdote di Gerusalemme il permesso di fare una traduzione greca della Bibbia. La cosiddetta Lettera di Aristea, un autorevole testimone del II a.C., narra come Demetrio Falero, uomo di stato e bibliotecario di Tolomeo II Filadelfo, nel contesto delle attività culturali della Biblioteca di Alessandria, facesse richiesta della Bibbia degli ebrei per la Biblioteca. Il re passò la richiesta al sommo sacerdote di Gerusalemme il quale inviò ad Alessandria 72 anziani (6 per ognuna delle 12 tribù). Da qui forse prese origine la traduzione della Settanta. Da questa e da altre testimonianze convergenti possiamo capire questo:
- Gli ebrei ebbero il loro ruolo nel tradurre la Bibbia in greco ma la traduzione della Settanta non deriva dalla iniziativa degli ebrei, anche se essi colsero l’occasione opportuna e la seppero sfruttare al meglio;
- La Settanta non è stata fatta per un’occasione liturgica, perché non era ancora entrato nell’uso fare una versione della Bibbia, anzi era severamente vietato;
- L’iniziativa del re Tolomeo permise di superare ogni difficoltà e di ottenere l’autorizzazione e la collaborazione delle massime autorità del giudaismo palestinese. Queste non si sentivano di porre un doppio rifiuto al re, che era anche il loro re (la Palestina restò sotto l’egida della dinastia tolemaica fino al III secolo a.C.) e alla potente comunità della diaspora alessandrina. La cosa risultò anche più semplice perché la traduzione non venne fatta per uso liturgico ma profano.
La Settanta è una traduzione oltremodo libera del testo ebraico e presenta notevoli divergenze (alcuni libri dell’Antico Testamento ci sono noti solo dalla Settanta, sono quelli che gli ebrei ortodossi non accettano). Il giudaismo si basa anche sulla versione della Settanta per elaborare una apologetica che avrà molto successo: ciò che Platone e gli altri filosofi dicono di vero, lo devono alla loro lettura della Torah. Aristobulo, consigliere di Tolomeo VI (180-145 a.C.), voleva provare la dipendenza di Omero, Esiodo, Pitagora, Platone da Mosè. Egli sosteneva che fosse stata fatta una traduzione parziale della Torah prima della conquista dell’Egitto da parte di Alessandro Magno (nel 332 a.C.) e da parte dei persiani (nel 341 a.C.).
Pensiamo anche alla principale traduzione siriaca della Bibbia, detta Peshitta (pronuncia siriaca orientale) o Peshitto (pronuncia siro-occidentale). L’aggettivo siriaco significa “semplice” (usato per la prima volta in relazione a questa traduzione da Mosè bar Kepha, morto nel 904) e si riferisce, per alcuni, al fatto che è in contrasto con i targum, parafrastici, mentre, per altri, al fatto che era adottata dal popolo. Il siriaco è un dialetto aramaico, codificazione di quello usate a Edessa.
Per la datazione: la Peshitta era nota a Afraate, che scrisse tra il 337 e il 345; per alcuni la versione si basa grossomodo sul testo ebraico masoretico, quindi abbiamo un limite risalente alla metà del I secolo (per altri invece il testo su cui si basa la traduzione è un ramo della tradizione targumica, tesi sostenuta da Kahle e Baumstark). Il primo a studiare il testo della Peshitta è stato Rahlfs, nel 1889: il primo grande scisma nella chiesa siriaca si ha nel V secolo, essa si separò in siri occidentali (giacobiti) e siri orientali (nestoriani); questo portò a due forme testuali della Peshitta, quella occidentale (che si dividerà poi in giacobita, melchita e maronita) e quella orientale. Il testo occidentale è rappresentato dal manoscritto Ambrosiano e dal poliglotta di Parigi, quello orientale dall’edizione di Urmia. Per una piccola parte dell’Antico Testamento abbiamo un testo risalente al V secolo, per il resto la documentazione manoscritta è databile tra VI e VII secolo. Abbiamo quindi alcune centinaia di anni di distanza tra le prime testimonianze della Peshitta e l’originale.
Il testo originale ebraico dei libri di Samuele è molto corrotto rispetto ad altri libri dell’Antico Testamento. Gli studiosi adducono come causa la parablepsi. Alle molte difficoltà del testo ebraico dei libri di Samuele ci vengono in aiuto le antiche versioni della Bibbia, quella greca della Settanta, la Peshitta, la Vulgata latina e il targum. In passato si dava molta importanza alle versioni antiche considerandole testimoni del vero testo originale, che ci è giunto corrotto. I copisti ci avrebbero tramandato un testo ebraico pieno di lacune, invece le versioni antiche tradurrebbero fedelmente l’originale dandoci un testo più fedele. Oggi questa linea è andata progressivamente scemando e, all’antipodo, si considera il testo ebraico a noi giunto dei libri di Samuele come quello più fedele all’originale. Quindi oggi si considera la diversità delle versioni come delle loro aggiunte al testo ebraico.
Le antiche versioni della Bibbia in genere sono opere a sé, che riflettono uno stile letterario, traduttivo e interpretativo specchio della particolare comunità nella quale sono sorte.
In passato alcuni studiosi sostenevano che la Peshitta non traducesse il testo ebraico ma quello aramaico dei targum. Oggi questa tesi ha sempre meno sostenitori: le uniformità tra targum e Peshitta vengono spiegate non come dipendenza della seconda dal testo del targum bensì come influsso dello stesso ambiente traduttivo, nonché dall’uso della stessa lingua aramaica (ricordiamo che il siriaco è un dialetto aramaico).
Molte volte le varianti tra testo ebraico di Samuele e Peshitta vengono spiegate non come esito di una armonizzazione, assimilazione, correzione o miglioramento né con un testo ebraico differente, bensì come errori di traduzione. Un caso celebre è in 2Samuele 2, 13: in esso ricorre tre volte il termine ebraico “piscina” e tutte e tre le volte la Peshitta traduce con il siriaco “giovani”. Probabilmente la Peshitta si rifaceva a una revisione antica, quella di Giacomo di Edessa, che presentava una lezione simile ma che la Peshitta ha sbagliato a rendere, quindi ne venne fuori la parola “giovane”.
Quando la comunità siriaca traduceva il testo ebraico, quest’ultimo non era stato ancora vocalizzato dai masoreti. A volte la Peshitta vocalizza in maniera differente rispetto al testo masoretico. È il caso di 2Samuele 4, 6: il testo masoretico vocalizza come avverbio di luogo, “qui” (wehenah), invece le versioni rendono come “ed ecco” (presupponendo un originale ebraico wehinah), in siriaco wh’. Un altro esempio interessante lo abbiamo in 2Samuele 14, 17: il testo masoretico ha “possa essere di pace la parola del re mio signore”, invece la Peshittta presenta la versione “si avveri la parola del re mio signore e sia un sacrificio (in siriaco qwrbn’)”. In ebraico “dono”, “offerta” si dice minechah, invece “riposo” si dice menuchah: si tratta di due parole assai simili, quindi da uno stesso scheletro consonantico i siriaci hanno inteso in un modo, invece i masoreti in un altro.
I “libri storici” accettati nel canone cattolico sono: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Samuele, 1-2 Re, 1-2 Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, 1-2 Maccabei. I due libri di Samuele costituiscono, con i successivi due libri dei Re, un’opera continua, da ricondurre a un unico progetto, quello di abbozzare la vicenda di Israele sotto la monarchia. I libri di Samuele sono il racconto dell’origine della monarchia. Il primo libro è dominato dall’ultimo giudice e primo profeta, Samuele, e dal primo sfortunato re, Saul. Il secondo libro narra la vicenda di Davide, la cui presenza era però già significativa nel primo libro.
È necessario fare una premessa circa il rapporto tra Bibbia e storia, che sono tra loro intimamente connesse. La Bibbia non è una collezione di tesi teologiche perfette ma il racconto dell’incontro del popolo di Israele con Dio, che scende nella storia dell’uomo, con tutte le grandezze ma anche le miserie dell’attore umano. Secondo gli studiosi, il primo grande credo di Israele è in Deuteronomio 26, 8: “Il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso”. Quindi il credere è per il popolo di Israele un continuo coinvolgimento del reale, cioè ha a che fare con l’esperienza storica.
Pertanto la Bibbia è una catena costante di liberazioni e alleanze. La liberazione è un atto con implicazione anche sociale, invece l’alleanza è una categoria squisitamente religiosa, teologica. Per cui la storia (liberazione) è intrinsecamente unita alla teologia (alleanza). La storia è il grembo della salvezza, la quale quindi non fiorisce dalla contemplazione della creazione (come avviene in altre religioni) né da una esperienza estetica (come nei Misteri greci) bensì dall’esperienza del tempo.
Da un lato abbiamo gli eventi storici, dall’altro la teologia. Il senso teologico cerca sempre di affermarsi, quindi l’autore biblico vede sempre la storia come storia della salvezza, cioè come incontro continuo di Israele con Dio. Per gli altri popoli del Vicino Oriente antico la religione si basava sul mito, invece Israele fonda la propria religione su un evento storico: la liberazione dalla schiavitù d’Egitto e le continue liberazioni e alleanze fatte con Dio.
Da una parte c’è il “fatto” (ciò che realmente è accaduto), dall’altra l’ “evento” (l’interpretazione teologica fatta da Israele). Il fatto è il mero dato storico, cioè quanto è realmente accaduto, invece l’evento brilla di iridescenze segrete, è aperto alla interpretazione, alla riflessione, alla versione sapienziale e profonda.
È interessante il fatto che la tradizione ebraica chiama i “libri storici”: Profeti Anteriori, nella convinzione che la storia è profezia, cioè che nella storia c’è Dio che scrive dritto sulle righe storte degli uomini.
Nella interpretazione della Bibbia bisogna sempre tenere fisso questo principio. La Bibbia è fondamentalmente storica, ma è anche tutta teologia. L’autore umano, infatti, cerca sempre di interpretare la storia secondo categorie teologiche, inserendo dei particolari che “forzano” il dato storico ma per favorire la narrazione teologica, senza però falsare del tutto la storia.
In questo senso il materiale dei libri di Samuele e Re (tradizione deuteronomistica) è simile a quello dei libri delle Cronache (tradizione sacerdotale), cioè ci sono grossomodo gli stessi personaggi, però i libri di Samuele e Re danno una particolare interpretazione (per esempio la figura di Davide è profondamente carnale, misera, in fondo è un fallito), diversa da quella delle Cronache (la figura di Davide è immersa in nubi di incenso, è la prefigurazione del re Messia, cadono tutte le miserie). Nella Bibbia l’evento non è solo fatto, ma evento teologico, suscettibile di più interpretazioni.
I libri delle Cronache esprimono un altro tipo di storiografia, per rendersene conto basterebbe leggere 1Cronache 1, 1-15, che è un elenco di nomi. Quindi nelle Cronache per molte parti abbiamo un elenco di archivio, anche se con evidente finalità religiosa, teologica, invece Samuele e Re assumono i fatti per costruire una storia più compiuta. Come abbiamo detto, le Cronache dipendono dalla tradizione sacerdotale che ha le sue origini nell’esilio di Babilonia e ha uno scopo molto chiaro: infatti, si prefigge che il popolo di Israele, disperso in comunità pagane, non dimentichi il Dio dei padri.
I libri delle Cronache sono stati scritti probabilmente nel IV a.C., la redazione finale risale forse al III a.C.. Sono in ebraico quando ormai non si parlava più questa lingua, bensì l’aramaico. In questi testi non vi è tanto l’interesse di ricostruire il passato, ma lo si assume per vedere se insegna qualcosa, altrimenti lo si omette. Per tale ragione i due libri delle Cronache sono stati del tutto dimenticati, se non dalla cristianità.
L’autore rielabora spiccatamente materiale già esistente, e lo fa non come uno storico di professione: a lui interessa solo lo scopo che si prefigge, cioè rintracciare il sangue di Israele (le origini, la genealogia), ma soprattutto le origini della fede, cercando di rintracciare un filo di continuità con il passato da mostrare agli ebrei dispersi tra pagani. Pertanto i temi capitali sono il Tempio e Davide. Non è più il Tempio grandioso del pre-esilio, ma quello ricostruito dopo l’esilio, più modesto, ma che comunque è segno del primo e nel quale Dio si manifesta. Un terzo delle Cronache è occupato dal Tempio, la cui liturgia viene descritta in una maniera così dettagliata che a noi moderni sembra strano ma che si giustifica come affermazione della identità ebraica, della unione con il passato. Poi, quella che l’autore alimenta ora non è più la radice davidica (la monarchia non c’è più) bensì Davide nel quale si manifesta il Messia. Abbiamo quindi un Davide trasfigurato in funzione sia del Messia sia del Tempio.
Il genere delle Cronache si avvicina molto al midrash. Il midrash deriva da una radice ebraica che significa “ricercare” ed è una omelia narrativa che parte da uno spunto biblico per poi crescere e fare tutto un discorso teologico o affermare norme del diritto. Le Cronache non sono ancora midrash, perché il riferimento alla storia biblica passata è molto sostenuto, però cominciano quell’itinerario che porterà al midrash. Un’altra peculiarità dei libri delle Cronache è che sono a volte screziati di musica. Inoltre in essi c’è una sorta di messianismo quotidiano, che cerca di vedere i segni della salvezza in ogni istante. Nel passato si consideravano questi due libri come una continuazione di Samuele e Re: questo spiega perché la traduzione greca della Settanta intitola l’opera Paralipomeni, che in greco vuol dire “tutto ciò che è stato omesso”.
La storia come la conosciamo noi occidentali nasce con Erodoto nel V secolo a.C. La Bibbia non è storia come noi oggi usiamo chiamarla, ma non è pura invenzione. Inoltre, nei “libri storici” della Bibbia si confondono altri due piani:
- Nella Bibbia ebraica i vari generi letterari non sono distinti, bensì mischiati tra loro. Poesia e storia (vicina alla nostra idea, cioè racconto di fatti), leggende e racconti teologici si susseguono in un continuum interrotto;
- In un solo libro sono forniti, nello stesso tempo, elementi compilati all’epoca dell’episodio narrato e altri scritti più di cinquecento anni dopo;
- Bisogna altresì osservare come la differenza di generi e gli sbalzi temporali propendono per la tesi che i libri storici non sono stati scritti da una sola mano. Raccolgono infatti materiale assai eterogeneo. Anche all’intero della tradizione deuteronomistica o di quella sacerdotale ci sono molte divergenze, che si possono dimostrare con facilità mediante considerazioni filologiche (individuazione di doppioni, discordanze e contraddizioni). Però i redattori finali hanno raccolto il materiale eterogeneo dando una impostazione ben chiara e non priva di ragione. Per esempio, per Giosuè 24, Giudici 3, 12-16, 31, 1Samuele 1-12 si parla del “Libro dei giudici salvatori”, che fa capo a una tradizione detta “redazione efraimita”, considerata pre-deuteronomistica (la tradizione deuteronomistica vera e propria serba l’idea della unificazione del culto nel Tempio invece la redazione efraimita menziona almeno otto località di culto del Nord di Israele senza farle rientrare in un unico culto legittimo, quindi abbiamo a che fare con materiale precedente la tradizione deuteronomistica).
Samuele e Re dovevano essere quattro libri assieme. Ma il progetto doveva essere anche più esteso e comprendere pure i libri di Giosuè, Giudici, Deuteronomio (che non è un libro storico in senso stretto, fa parte anch’esso della grande riflessione sulle origini). Questi sette libri rientrano nella riflessione storico-teologica sorta entro la tradizione deuteronomistica. Lo indica lo stesso stile linguistico e letterario e le stesse tesi da dimostrare.
Relativamente ai due libri dei Re, essi continuano il materiale di Samuele e raccontano la storia ebraica dal X al VI secolo a.C. Si parte dalla difficile successione a Davide che vede imporsi la grande figura di Salomone e si approda alla tragica data del 586 a.C., allorché Gerusalemme e il suo Tempio vengono distrutti dai babilonesi. Nel mezzo di questi due estremi temporali, le mai sopite tensioni tribali e l’inettitudine del successore Roboamo portano alla scissione del regno in due tronconi: il regno settentrionale (detto di Israele, con capitale Samaria) e il regno meridionale (detto di Giuda, con capitale Gerusalemme). L’autore ricorre a materiali d’archivio e a memorie storiche, usa schemi fissi nel delineare i vari sovrani che salgono sui due troni di Israele e di Giuda, ma soprattutto seleziona, ordina e interpreta gli eventi in chiave religiosa.
Nei libri dei Re abbiamo un interesse storiografico maggiore rispetto ad altre opere. Abbiamo una grande volontà di documentazione, di risalire alle fonti, nonché ci si preoccupa di rintracciare la sequenza storica. Si avverte l’uso di sincronismi, cioè il tentativo di fare una cronologia relativa, vale a dire si instaurano correlazioni (come quando il re di Giuda sale al trono all’inizio del regno del re di Israele).
Il filo teologico dei libri dei Re si basa sul principio retributivo. Dopo che nel Deuteronomio sono state espresse le leggi (ciò che Dio vuole), qui si esprime la risposta dell’uomo. Gli eventi sono misurati nella risposta che l’uomo dà a Dio, secondo categorie religiose. Ogni fedeltà alla legge di Dio è premiata; ogni infedeltà viene punita. Per esempio il re Geroboamo II è considerato infedele alla legge, empio, quindi è sfigurato storiograficamente: ma dal punto di vista archeologico sappiamo che questo non è vero in quanto il suo regno è stato splendido. L’autore lo pone in cattiva luce perché viola l’alleanza facendo una politica sincretistica, aperta ai pagani. Quindi i fatti, il mero dato storico, gli avvenimenti realmente accaduti vengono trasfigurati secondo un intento teologico. Abbiamo a che fare, anche con i libri dei Re, più con la profezia che con la storia in senso stretto.
Dal punto di vista della qualità letteraria, i due libri dei Re presentano generi letterari numerosi con toni mutevolissimi. Abbiamo i ritratti a tutto tondo (Salomone) ma anche i ritratti agiografici (come quelli di Elia e Eliseo, presentati fondamentalmente con lo scopo di suscitare la devozione dell’uditorio). Abbiamo poi molti fioretti (racconti folcloristici, pittorici, che lasciano spazio alla fantasia, ad esempio 2Re 2, 23-25: alcuni bambini deridono le calvizie di Eliseo, questi li maledice e essi vengono sbranati da un’orsa). Sono presenti pure ritratti fissi (soprattutto dei re).
Un tempo si credeva che quando la scuola deuteronimistica stava per spegnersi sorse l’esigenza di raccogliere per iscritto tutto il materiale e quindi vennero messi per iscritto questi sette testi (ipotesi di Noth).
Invece oggi si pensa che questi sette libri abbiano avuto due redazioni:
- Una prima inizia quando il Deuteronomio ha il suo grande successo Ricordiamo la storia di 2Re 22: una donna trova il Deuteronomio nel tempio di Gerusalemme, e che il re Giosia aveva canonizzato nel 609. Non sappiamo con certezza se fosse realmente il Deuteronomio, ma da ciò si evince che in quel tempo la tradizione deuteronimistica stava mettendo per iscritto i libri;
- La seconda redazione avviene dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme, quando la gente, laica, decide di raccogliere in un archivio dello spirito tutto ciò che il Signore aveva fatto per Israele, con lo scopo di continuare a sperare in Dio.
L’ideale sarebbe leggere questi antichi testi nell’originale ebraico per rendersi conto pienamente della loro bellezza. Ma la prosa di questi libri è molto lineare, costituisce un racconto popolare assai accessibile anche in traduzione, al contrario di altre parti della Bibbia, come Giobbe, Cantico dei Cantici, molti Salmi, che devono essere giocoforza letti nell’originale per essere capiti veramente.
I sette libri della tradizione deuteronomistica sono fatti per suscitare una reazione, il narratore vuole una partecipazione viva dell’uditorio perché non sono “presentazioni” ma vere e proprie “rappresentazioni”, sono delle scene quasi teatrali, come quando Davide si innamora di Betsabea nuda. C’è spesso un intento eziologico. Poi non si pone attenzione tanto ai fatti quanto ai personaggi (Samuele, Saul, Davide), che sono caratterizzati narratologicamente molto bene.
Oggi l’archeologia dimostra che i libri storici della Bibbia raccontano fatti realmente accaduti. Nel 1845 venne scoperto a Nimrud il cosiddetto Obelisco Nero, un blocco di pietra nera, levigata, con bassorilievi e iscrizioni. Esso reca il ricordo dei trionfi del re assiro Salmanassar III (regno 857-826 a.C.). In esso un personaggio si inginocchia per baciare i piedi del re di Assiria ed è scritto: “Tributo di Jaua, figlio di Humri: ho ricevuto argento, oro, una ciotola d’oro, piombo, un bastone regale, un giavellotto”. Si tratta di Jeu, re di Israele. Il monumento è l’unica testimonianza che possediamo in cui gli israeliti sono raffigurati nel portare un tributo a un re assiro.
In alcuni sigilli trovati negli scavi della Palestina compaiono nomi di personaggi famosi che si incontrano nei racconti biblici. Non è stato ancora ritrovato nessun sigillo con nomi di re di Giuda o di Israele, ma a volte i loro nomi appaiono nei sigilli dei loro ministri o alti ufficiali. È il caso di due sigilli dell’VIII secolo a.C. trovati a Meghiddo. “Shema, servo di Geroboamo” (probabilmente si tratta di un funzionario di Geroboamo II, re di Israele). “Abija, servo di Uzzia” (si tratta del re biblico Uzzia, re di Giuda).
Il Prisma di Taylor, un prisma cavo di argilla, alto quasi 37, 5 cm, contiene una delle tante iscrizioni che ricordano i successi di Sennacherib, re di Assiria tra il 704 e il 681 a.C. In esso si menziona anche il re Ezechia, un importante re biblico.
I latini dicevano che tempus fugit, il tempo fugge, ma noi siamo immersi nel tempo, quindi cambiando questo, cambiamo anche noi (tempora mutantur et non mutamur in illis), come a dire che anche noi passiamo inesorabilmente. Per questo per il buddhismo ogni cosa è vuota, tutto è impermanente, quindi la realtà è il vuoto. Per Tilopā (928-1009) è questo il Mahāmudrā, il Grande Sigillo, vale a dire la quintessenza dell’insegnamento del Buddha.
Ma la rivelazione biblica dichiara, al contrario, che Dio scende nel tempo dell’uomo, nella sua storia, e lo trasfigura. Dio nell’Antico Testamento incontra l’uomo e poi nel Nuovo si incarna divenendo uomo, ponendo la “tenda” tra di noi: “E il Verbo si fece carne e venne a abitare tra noi” (Giovanni 1, 14), in greco eskēnōsen, dove skēnē è la “tenda”. Egli viene in maniera specialissima nella nostra dimensione spaziale e temporale. Probabilmente Giovanni allude alla “tenda dell’incontro”, quel santuario mobile fatto dagli ebrei in marcia nel deserto, nel quale veniva Dio: ora Cristo, vero Dio e vero Uomo, sceglie come “tenda dell’incontro” la nostra umanità.
Per la Bibbia Dio è Qadosh, Santo, che etimologicamente vuol dire “separato” dal nostro mondo. Questo perché egli è eterno. Salmo 90, 2: Dio esiste “da eternità a eternità”. Isaia 40, 28: “Dio è eterno”. Tuttavia egli per amore decide di creare la temporalità e in essa vi pone l’uomo, non solo ma per amore lo incontra e poi incarnandosi lo redime definitivamente. Se Dio è eterno e ama l’uomo, lo ama di amore eterno (Geremia 31, 3).
Questo intreccio di eternità e tempo caratterizza la creazione del mondo. Isaia 48, 13: “Sì, la mia mano pose le fondamenta della terra, la mia destra distese i cieli. Quando io li chiamo, tutti insieme si presentano”. Abbiamo due assi temporali: un passato e un presente (“chiamo”). Perché? Questo mistero si evince anche da Esodo 19, 1: “Al terzo mese dall’uscita degli israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai”. Questa è la traduzione della CEI. L’uscita degli ebrei ha una data precisa, si situa nel passato, ma come è possibile che nello stesso giorno arrivano nel deserto del Sinai? È un errore? Nel testo ebraico abbiamo letteralmente “… in questo giorno arrivarono al deserto del Sinai”. Si usa l’aggettivo ebraico “questo”, hazeh. È stato scritto molto riguardo questa curiosità filologica.
Dio è signore di entrambi (passato e presente) in quanto è nell’eternità, che avvolge tutto quanto, anche il segmento temporale in cui sta il singolo uomo. Salmo 90, 4: “Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte”. Nell’Apocalisse (1, 8) si dirà che Cristo è l’Alfa e l’Omega, la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco, cioè Cristo è l’inizio e la fine. “Colui che era, che è e che viene, l’Onnipotente”, o ōn kai o ēn kai o erchomenos, o pantokratōr. Tommaso lo appellerà in questa maniera: “Signore mio e Dio mio”, o kurios mou kai o theos mou (Giovanni 20, 28). Giovanni 8, 58: “Prima che Abramo fosse, io sono”, prin Abraam genesthai egō eimi.
In Isaia 43, 16-19 si esprime ancora la dialettica tra passato e presente: Dio aveva aperto per Israele un sentiero in mezzo ad acque possenti (nella liberazione dall’Egitto) e adesso “io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa”. Apocalisse 21, 5: “Io faccio nuove tutte le cose”.
La dialettica tra passato e presente permane anche negli scritti profetici, persino nella grammatica, quando i profeti usano il perfetto. Il perfetto (qatal) è in ebraico biblico un verbo che indica una azione compiuta, cioè svoltasi nel passato, ma i cui effetti perdurano nel presente (e nel futuro). Per questo quando Geremia 31, 33 dice: “Porrò (natati) la mia legge nel loro intimo (beqirbam)” o Ezechiele 36, 26: “Vi darò (natati) un cuore nuovo”, gli autori usano un perfetto prima persona singolare, che quindi unisce le due dimensioni temporali. L’idea del perfetto profetico è quella di una azione iniziata indietro nel tempo ma i cui effetti si riverberano in avanti, quindi il traduttore italiano adopera il futuro. Dio è già stato nella storia e in quel passato ha iniziato a sortire gli effetti che si completeranno solo in seguito.
È un po’ quanto accade con il perfetto greco. In Luca 7 una donna bagna di lacrime i piedi di Cristo, li asciuga con i capelli, li bacia e li cosparge di profumo. Quindi Gesù dice (v. 47): “I suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato”. Il verbo “perdonare” è al perfetto (afeōntai): cioè la donna è stata perdonata ed ora si trova in uno stato di perdono. Il verbo “amare” è all’aoristo (ēgapēsen): esprime i gesti che essa ha compiuto in un dato momento ed ora si sono conclusi. L’amore della donna, che ha avuto nei confronti di Cristo in un dato momento nel passato, ha provocato un perdono in quel passato, i cui effetti perdurano nel presente, quindi risulta perdonata. L’amore ha provocato il perdono.
Il profeta più grande dell’Antico Testamento è Isaia, definito il Dante della letteratura biblica. La sua è una poesia finissima. I suoi versi sono di una limpida armonia. Gli oracoli si distinguono per un’equilibrata concisione e le immagini sono di una smagliante diversità e novità. Isaia è capace di maneggiare magistralmente gli artifici letterari, l’allitterazione, la paranomasia, le ripetizioni di parole. Genio poetico delle brusche immagini, delle aspre antitesi. Degna di nota la varietà di generi letterari usati dal poeta.
Ma bisogna dividere il libro di Isaia in almeno tre parti: nella sua opera, infatti, confluiscono gli scritti di altri due autori, anonimi, molto posteriori. Isaia è vissuto sotto i re Acaz e Ezechia nel VIII secolo a.C. e scrive buona parte dei capitoli 1-39. Dal capitolo 40 al capitolo 55 entra in scena un altro autore, detto Deutero-Isaia, vissuto negli anni successivi al 538 a.C., quando il re persiano Ciro, vinti i babilonesi, aveva permesso agli ebrei esuli di ritornare nella loro patria. Gli ultimi capitoli del libro di Isaia (56-66) sono attribuiti al cosiddetto Trito-Isaia, vissuto durante la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme e negli anni successivi (dal 520 a.C. in avanti).
La storia che si capisce dalle tre parti del libro di Isaia è molto diversa:
- Isaia 1-39: questi capitoli fanno riferimento all’epoca assira. In epoca assira si collocano i quattro re nominati in 1,1 (Ozia, Iotam, Acaz, Ezechia);
- Invece in 40-55 il contesto storico muta radicalmente. Gli assiri vennero sconfitti dai babilonesi, i quali deportarono gli ebrei, che in seguito furono fatti ritornare in Palestina dal re dei persiani Ciro dopo che i persiani ebbero sconfitto i babilonesi. Quindi il materiale di Isaia parla di “consolare Gerusalemme” che ha scontato “il doppio dei suoi peccati”, in quanto ha subito l’esilio. Allo stesso tempo Ciro è descritto come colui che fa la volontà di Dio, in quanto fa ritornare Israele nella sua terra di origine;
- Nei capitoli 56-66 il contesto storico è ancora più tardo, qui siamo nel post-esilio, dove la religione ebraica cominciò a perdersi e l’autore allora nota che i sacrifici non sono offerti con spirito puro.
Ma gli studiosi hanno trovato che anche queste tre parti possono essere suddivise in sezioni più piccole, scritte da autori diversi. E tutte queste suddivisioni – le tre principali e le altre – non dipendono solo dal contesto storico differente che emerge, ma anche: dal cambiamento dello stile linguistico; dal cambiamento dello stile letterario (dal capitolo 40 si va verso uno stile metastorico e apocalittico); dal cambiamento contenutistico e tematico (1-39 ha il tema del castigo, mentre 40-55 quello della consolazione); e così via.
Gli studiosi notano però che il libro di Isaia ha una sua unità (lessicale, tematica e teologica), prodotta non dai vari autori ma da una redazione finale che ha unificato i materiali diversi. Gli studiosi hanno notato la straordinaria simmetria tra capitolo 6 e capitolo 40 riguardante la ricezione della parola di Dio: in 6 tramite visione, in 40 tramite un ascolto ugualmente eccezionale. Gli studiosi danno anche altre prove di una unità di tutto il libro di Isaia: per esempio, il titolo divino “Il Santo d’Israele” ricorre in ogni parte, più di 25 volte, mentre è raro nel resto della Bibbia; oppure la radice ebraica della “salvezza” (jsh) compare 3 volte nel capitolo 12 e poi massicciamente nella seconda parte e nella terza parte del libro; abbiamo la ricorrenza dell’espressione “la bocca del Signore ha parlato” (1, 20; 40, 5; 48, 14); il termine rahab per designare l’Egitto (30, 7; 51, 9); in tutte le parti del libro sono messi in evidenza, con varie sfumature, i temi della maestà di Dio, del Resto di Israele, della universalità del futuro regno di Dio.
Già nel III secolo a.C. il libro di Isaia aveva la forma unitaria che appare oggi, come dimostra l’elogio di Isaia contenuto in Siracide 48, 20-25: in questo testo, redatto verso il 200 a.C., si accenna alla seconda parte del libro ascrivendola all’autore “fortemente ispirato” della prima parte. Che il libro di Isaia era tale e quale lo leggiamo oggi lo testimonia anche il rotolo ritrovato a Qumran (1Q IsA) e la versione della Settanta.
I profeti biblici sono spesso oscuri. In Numeri 12, 8 si conserva una tradizione tardiva nella quale si esalta la superiorità della rivelazione di Mosè su quella profetica determinata dall’opposta strategia comunicativa: “Bocca a bocca parlo a lui, in visione e non in enigmi”.
Il primo Isaia, tra i profeti, sembra il più oscuro di tutti. In Isaia 6, 9-10 questa oscurità sembra connaturata alla sua missione: “Va’ e di’ a questo popolo: Ascoltate bene, ma senza comprendere; osservate bene ma senza riconoscere … perché non veda con i propri occhi e non ascolti con i propri orecchi e non intenda con il proprio cuore, affinché ritorni ed Egli lo guarisca”.
Tra le espressioni ambigue di Isaia abbiamo i conii di parole (“un resto tornerà”, 7, 3; “Dio è con noi”, 7, 14; “bottino repentino”, 8, 1), alcuni giochi di parole equivoci (in 28, 14 il participio costrutto può indicare “i governanti” e/o “gli inventori di proverbi”, senza che ci si possa pronunciare decisamente per l’una o l’altra soluzione), la ironia (“avanzi di tizzoni fumanti”, 7, 4, applicato a Samaria e Aram, per indicarne la progressiva e ormai imminente estinzione), le ambiguità (in 5, 1-7 il pronome sottinteso “io” connota l’amico dello sposo, cioè il profeta-cantore, lo sposo, cioè Dio, e la sposa, cioè il popolo, in un intreccio inesplicabile), e così via.
In Isaia 29, 11-12 è scritto: “Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato: si dà a uno che sappia leggere dicendogli ‘Per favore, leggilo’, ma quegli risponde ‘Non posso, perché è sigillato’. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendogli ‘Per favore, leggilo’, ma quegli risponde ‘Non so leggere’ “. Lazzaro appronta una accurata analisi di questo brano, tipico della profezia isaiana, riscontrandovi tratti di forte ambiguità e oscurità. Egli parte dall’analisi del sintagma hazut hakol, letteralmente “la visione di tutto (ciò)”. Già questo incipit è assai ambiguo. Infatti sarebbe più frequente l’ordine “tutto della visione”, quindi Isaia gioca con la oscurità anche riguardo all’inizio di questo passaggio. Non solo, ma il genitivo “di tutto” ha una vaghezza semantica che può riferirsi tanto ai vv.9-10 ma anche a tutto il libro. Inoltre in Isaia la radice ebraica della “visione” può significare sia il vedere dell’uomo sia il “vedere” profetico, cioè la profezia (negli altri profeti ha solo quest’ultimo significato). In Isaia la visione profetica ha quasi sempre tratti negativi (il profeta “vede” cose brutte). Ma qui Isaia si rifà probabilmente al significato di visione con gli occhi, in riferimento ai vv. 9-10 nei quali si dice che Dio ha accecato gli occhi. Pertanto nel dire che una visione con gli occhi è racchiusa in un libro (che è un atto di scrittura) e per di più sigillato (non si può nemmeno leggere), Isaia appronta una “metafora cumulativa”, che accresce l’ironia e l’ambiguità. Non solo, ma nella Bibbia la lettura è funzionale all’ascolto e alla adesione della fede: per esempio in Esodo 24, 7 Mosè prende il libro dell’alleanza e lo legge “alle orecchie del popolo”, che esegue i dettami della Legge. Invece Isaia presenta un forte effetto di straniamento e di ambiguità, che va contro la prassi della lettura biblica, che di solito tende ad essere capita e quindi eseguita: Isaia infatti dice che quello che sta scritto non può essere né letto né capito!
Oltre a queste caratteristiche tipicamente isaiane, anche se non esclusive, la Bibbia ebraica in sé stessa è colma di ambiguità e sensi poco chiari da attribuire alla lingua. In Isaia 29, 4 il termine ebraico ke’ob è una nota vexata quaestio. Esso può significare tre cose, tutte attinenti alla pratica della necromanzia: “buca, fossa” (scavata nel terreno per comunicare con il regno sotterraneo dei morti); “spirito, spettro” (da evocare); “necromante, evocatore di morti”. I vari studiosi ipotizzano il significato esatto cercando di sviscerarlo dal contesto.
Bibliografia
- Amaldi, Storia della letteratura araba classica, Bologna 2004;
- V. Arnold, Vedic Metre in its historical Development, Cambridge 2009;
- Banfi, N. Grandi (a cura di), Le lingue extraeuropee: Asia e Africa, Roma 2022;
- D. K. Bosch, Il Germe d’oro. Un’introduzione al simbolismo indiano, Milano 2017;
- Calasso, Ka, Milano 1996;
- Calasso, L’ardore, Milano 2010;
- P. Carbone, G. Rizzi, Le Scritture ai tempi di Gesù, Bologna 1992;
- K. Coomaraswamy, La tenebra divina. Saggi di metafisica, Milano 2017;
- H. Cousin, J. P. Lémonon, J. Massonnet, A. Méasson, Come gli ebrei leggevano i testi sacri, Bologna 2006;
- R. Daumal, Lanciato dal pensiero, Milano 2019;
- C. Della Casa, Corso di sanscrito, Milano 1980;
- Diez, Introduzione alla lingua araba. Origini, storia, attualità, Milano 2018;
- B. Dirksen, La Peshitta dell’Antico Testamento, Brescia 1993;
- J. Elizarenkova, Il Rigveda. L’inizio della letteratura e della cultura in India, Roma 2011;
- Gabrieli, La letteratura araba, Firenze 1967;
- Garbini, Introduzione all’epigrafia semitica, Brescia 2006;
- Garbini, O. Durand, Introduzione alle lingue semitiche, Brescia 1994;
- Il Corano, introduzione, traduzione e commento di F. Peirone, 2 voll., Milano 1984;
- Isaia, versione, introduzione e note di S. Virgulin, Milano 1989;
- Jung, Manuale di lingua e linguistica coreana, Milano 2018;
- Lazzaro, Isaia l’oscuro. Forme dell’oscurità linguistica isaiana e storia della loro recezione nell’attestazione di Isaia 29, Roma 2020;
- Lazzeroni, “Frase nominale e ingiuntivo nel Rig Veda”, in Studi Classici e Orientali 32 (1983) pp. 277-283;
- Lazzeroni, La cultura indoeuropea, Bari 1998;
- Malamoud, Cuocere il mondo. Rito e pensiero nell’India antica, Milano 1994;
- Malamoud, Femminilità della parola. Miti e simboli dell’India antica, Roma 2008;
- Malamoud, La danza delle pietre, Milano 2005;
- Martinet, L’indoeuropeo. Lingue, popoli e culture, Roma-Bari 2001;
- Meillet, Lineamenti di storia della lingua greca, Torino 2003;
- Mereu, La sintassi delle lingue del mondo, Roma-Bari 2004;
- Milizia, Le lingue indoeuropee, Roma 2002;
- Morani, Su due doppioni dell’antico indiano, in Aevum, Anno 56, Fasc. 1 (Gennaio-Aprile 1982), pp. 83-86;
- Oldenberg, Prolegomena on Metre and Textual History of the Ṛgveda, Berlino 1888;
- Pelissero, Dizionarietto di sanscrito per filosofi, Brescia 2021;
- Pelissero, Letterature classiche dell’India, Brescia 2020;
- Perego, Atlante biblico interdisciplinare, Milano 1998;
- Petrantoni, La traslitterazione greca del Salmo 78. 77di Damasco e la diglossia nel mondo arabo, in Rivista di cultura classica e medievale, Vol. 53, No. 2 (Luglio-Dicembre 2011), pp. 285-307;
- Pozzobon, La Peshitta del secondo libro di Samuele, Roma 2016;
- Ravasi, Nuova guida alla Bibbia, Milano 2008;
- Rofé, Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica (Pentateuco e libri storici), vol. 1, Brescia 2011;
- Ronzitti, Campi figurali della “creazione” nel Ṛgveda, Alessandria 2001;
- Sàenz-Badillos, Storia della lingua ebraica, Brescia 2007;
- Zonta, P. Grezzi (a cura di), Terminologia filosofica tra Oriente e Occidente, Firenze 2018.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 48 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.