È possibile affrontareil rilevante tema migratorio con rigore e sistematicità, risultando originali e persuasivi nonostante la quantità di pubblicazioni, analisi e opinioni che affollano la discussione pubblica in merito? Sì. Questo agile saggio di Giuseppe Giaccio, vocato a dare voce al “comune sentire” sull’argomento, fornisce una riflessione tanto ampia quanto profonda e originale, pertanto in controtendenza rispetto al conformismo della narrazione dominante sia nella cultura politica e accademica, sia nell’informazione .I sostenitori dell’immigrazione per ragioni umanitarie muovono sempre dalla prospettiva di un diritto individuale incondizionato, ma non si confrontano mai nelle loro argomentazioni con le cause che disgregano le comunità e costringono a emigrare le persone; non esiste cioè un diritto – non meno stringente – a risiedere nei propri luoghi di origine e radicamento, rimuovendo i motivi che generano la drammatica diaspora indotta dalla globalizzazione? Se ci si limita a giustificare l’immigrazione si rafforzano le cause che la generano, accrescendola patologicamente e irresponsabilmente, sommando sofferenza a sofferenza, inducendo quindi l’insofferenza delle comunità di accoglienza.
L’autore si pone volutamente nella prospettiva di analizzare concretamente il fenomeno in oggetto, sottraendo quindi le valutazioni ai pregiudizi ideologici, che all’oggi si fanno forti di un vero e proprio dettato moralistico nella forma del “politicamente corretto”, e giungendo così per via diretta a una interpretazione coerentemente politica e perciò realistica della questione, che è parte costitutiva –e non accidentale o dialettica–delle contraddizioni della modernità occidentale. La retorica umanitaria è un catechismo morale, una vera e propria ideologia del “bene” che va rimessa in discussione in ogni campo. Ben scrive, in questa prospettiva, Diego Fusaro –al quale è affidata la prefazione al saggio – che per approfondire tale problematica occorre destrutturare l’ordine simbolico e semantico dominante, su cui convergono la “Sinistra del Costume” e la “Destra del Denaro”: la prima ha perso la ragione sociale per identificarsi nei “diritti civili”delle minoranze, per cui lo sradicamento universale individualistico viene elogiato in sé come condizione moderna del liberalismo; la seconda, identificandosi nella crescita economica del mercato, porta seco “l’esercito di riserva del capitale”– per dirla con Karl Marx – ela delocalizzazione dello sfruttamento schiavile del lavoro.
In tal senso, è necessario problematizzare le condizioni del presente storico, sociale ed economico, a partire dalla globalizzazione. Elogiata unilateralmente dal determinismo progressista, in realtà si dimostra l’esatto contrario delle aspettative: più Popoli e culture si approssimano, meno ci si ospita e gradisce vicendevolmente. Zbigniew Brzezinski – controverso politologo contemporaneo recentemente scomparso, teorico del primato geopolitico statunitense, e quindi fonte certamente non critica della “occidentalizzazione” del mondo –già negli anni Settanta constatava con realismo che il paradosso contemporaneo consiste nel fatto che l’umanità diviene simultaneamente tanto più unificata, quanto più è frammentata: «L’umanità diventa più vicina e unita, mentre le differenze nelle condizioni delle diverse società si allargano. In queste circostanze, la prossimità, invece di promuovere l’unità, origina tensioni, mosse da un nuovo contesto di congestione globale» (1).Invece di affidarsi al realismo, la destra come la sinistra vedono i precari equilibri internazionali attraverso la lente dell’idealismo liberale. Piuttosto di affrontare un contesto dove la competizione sulle fonti energetiche va di pari passo a conflitti montanti e una insicurezza crescente, l’occidentalismo divide grossolanamente il mondo in alleati “virtuosi” (cioè dei subalterni) e avversari “malvagi” (sempre qualche sorta di “dittatura”). L’espulsione della categoria amico-nemico dalla vita pubblica, nonché da quella politica e culturale, è artificiosa e nasce dal tentativo di negare che ogni ordine nasce da un conflitto, il quale va regolato. Affermare che ci vogliamo astrattamente tutti bene, infatti, con l’implicito ricatto della compassione, non è un assunto effettivo, ma un utopismo culturale e antropologico, fondato sull’astrazione dalla realtà prodotta dall’ideologia dei “diritti umani”, che paradossalmente ci allontana dalla soluzione dei contrasti nell’effettivo rispetto della dignità della persona e delle collettività.
Giuseppe Giaccio, correttamente, per definire il metodo di indagine e quindi distinguere i giudizi dai pregiudizi, parte da lontano –ma in realtà molto da vicino, date le distorsioni e le mistificazioni all’ordine del giorno – considerando come il dibattito sulle “migrazioni” in ambito scientifico e accademico venga comunemente collegato all’origine stessa dell’uomo. Già in questo ambito, dove dovrebbero dominare metodo e razionalità, si palesa l’asserzione ideologica, che presenta la teoria della comune origine dell’umanità nel continente africano e la conseguente deriva migratoria (Out of Africa), come una certezza assodata–quando inrealtà è “mitologica”– nonostante la mole crescente di prove empiriche paleoantropologiche, che invece vanno a rafforzare l’altra teoria oggetto di confronto scientifico e culturale, definita Multiregional Continuity Model, secondo la quale l’ominizzazione sarebbe avvenuta in diverse e plurime realtà geografico-continentali e i percorsi migratori seguirebbero non un vettoriale determinismo evoluzionistico, ma un assai complesso insieme di elementi adattativi spazio-temporali, in cui spesso le Popolazioni si sono distinte per circuitazioni e ritorni nei luoghi di sostenibilità e sviluppo antropologico. Tale elementare confronto di idee e teorie, tuttavia, è completamente censurato a qualsiasi livello di usufruizione, trasmissione e diffusione culturale e scientifica. L’ideologia dominante si veste di scienza, ma in realtà impone una lettura “confessionale”, “superstiziosa”, unilaterale e non rivedibile nelle sue argomentazioni, delegittimandosi così per metodo ancor prima che per la selettività o addirittura la censura sulle prove fattuali. In ultima analisi, la presunta autorevolezza scientifica risponde all’adesione ideologica con il paradigma egemone dei “liberi opportunisti” che lo sostengono, più che all’onestà intellettuale.
Se l’uomo è in continuo “movimento” fin dalle sue origini, ecco allora che il “flusso” e la condizione “liquida” diventano una vera metafisica dello sradicamento, condizione necessaria della modernità e quindi dell’occidentalizzazione del Mondo. Qualsiasi richiamo a vincoli naturali, culturali, sociali ed economici che organizzano comunitariamente la vita, è un ostacolo all’affermazione della “forma capitale”, un indefinito movimento senza attrito di merci e individui iscritto nel determinismo storico. In realtà, il mondo cui apparteniamo, l’Occidente globalizzato, è il prodotto di un conflitto di potenza all’ultimo sangue, che ha visto affermarsi un potere oligarchico tecnomorfo etnocentrico, il quale ha imposto il “flusso” globale mercantile di materiali ed esseri umani distruggendo le società tradizionali e le culture che per millenni hanno caratterizzato le civiltà come delicato equilibrio tra cultura e natura, nel rispetto del limite e della sostenibilità ecologica. Non si possono non condividere, di conseguenza, le parole di Giuseppe Giaccio, quando ci esorta a contrapporre a un mondo uniforme e indistinto, fatto di impermanenza e precarietà – di uomini, denaro, informazioni, tecniche, servizi, immagini – unar ealtà invece poliedrica, un solido cioè in cui le singole facce che lo compongono mantengano la loro identità e originalità: «Il contrario del flusso non è l’immobilità cadaverica, bensì l’armonia dinamica che si fa carico della diversità del mondo». Nonostante il paradigma liberal-capitalista egemone, che si pone come indiscutibile e onnipervasivo, quindi, l’Essere del mondo, il reale, depositario del senso, dei saperi e della sostenibilità della Terra, può e deve contrapporsi al nichilistico titanismo prometeico, destinato ad annegare nella “liquidità” globale che ha incautamente evocato.
Il primo elemento realistico è, per definizione, quello della quantità, quindi della dimensione assunta dal fenomeno migratorio. Questione di “scala”, quando la solidarietà diventa “controproduttiva”,come direbbe Ivan Illich, ragione per cui il fisiologico diviene patologico. Vi è un autore, Olivier Rey, che con il suo fondamentale La dismisura (Controcorrente) è un punto di riferimento della riflessione di Giuseppe Giaccio. L’acqua è una benedizione in quantità ragionevoli, ma quando si presenta come inondazioni e siccità diventa un disastro. Le società tradizionali conoscevano i pericoli della dismisura e provavano a scongiurarli; le società moderne, invece, non concepiscono i limiti che come ostacoli da rovesciare. Ercole aveva scolpito sulle colonne che portano il suo nome “Nec plus ultra”. Carlo V d’Asburgo invece scelse come motto del suo impero “Plus ultra”. È l’epoca in cui il mondo cessa di essere cosmo, vale a dire un insieme ben ordinato e armonioso, per diventare materia prima e quindi interamente disponibile alla volontà umana. Quando non si rispetta il mondo per ciò che è, si tende a non rispettare i limiti del reale; anzi si raccomanda di oltrepassarli. E questo si accorda bene con l’ossessione della produttività: l’aumento della quantità diventa un fine in sé, slegato da ogni finalità compiuta. Scrive Oliver Rey: «Per una morale il cui grande principio è amare l’altro come sé stesso, i numeri troppo grandi hanno qualcosa di satanico. Infatti, come amare il prossimo come sé stesso quando, come il demone, si presenta come legione? Con la migliore volontà del mondo, diventa impossibile fare attenzione a ciascuno. L’anonimato e il gigantismo mettono in scacco una morale fondata sull’attenzione per l’altro». (2)
Se andiamo ad analizzare con attenzione i dati sullo sviluppo economico del continente africano, possiamo osservare come negli ultimi due decenni vi sia stata una crescita maggiore della media mondiale. Sono gli squilibri in tal senso che vanno ricomposticon la giustizia sociale, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e la sovranità politica, affinché quelle popolazioni si emancipino definitivamente dall’eredità coloniale che ancora oggi grava mimeticamente sull’indipendenza e l’autodeterminazione di un intero continente. In Occidente, le vestali umanitarie si rendono partecipi emotivamente degli effetti, ma non si confrontano responsabilmente con le cause del fenomeno migratorio, d’altronde mostrarsi “dalla parte degli ultimi” è un’antica forma di retorica auto-propagandistica, la cui corrispondenza ai fatti è sempre tutta da verificare. A questo proposito, l’astrazione del “diritto a emigrare” dovrebbe invertirsi nel diritto a permanere nel proprio Paese, contribuendo al riscatto politico, sociale ed economico di culture le quali andrebbero emancipate dalla devastante imitazione dello stile di vita consumista che esercita il vero magnete attrattivo dei diseredati del Pianeta; scrive giustamente Giaccio che «la compassione dovremmo semmai provarla, al contrario, per quelli che restano in Patria», impossibilitati anche a spendere i propri miseri risparmi; nel contempo i partenti, invece – nell’aspirazione di migliorare le proprie aspettative di vita in un altrove, che in realtà nasconde la subalternità a un modello mondialista di sfruttamento e disuguaglianze – si affidano a spregiudicate organizzazioni criminali e a trafficanti di essere umani. In un tale contesto, invocare la necessità di immigrati nelle società di approdo fa il gioco del capitale, che fisiologicamente abbassa diritti e salari di tutti per mezzo di una domanda eccedente, un esercito industriale di riserva disposto a tutto pur si sopravvivere nel mercato globale.
Chiaramente, le realtà delle periferie del mondo, l’Africa in primis, sono assai contraddittorie e afflitte da problemi drammatici, in cui ogni semplificazione risulta superficiale, a partire dai mutamenti climatici, dalle fonti energetiche e dalla distribuzione delle risorse. Quello che però è improprio, è il sottrarsi a un’analisi obiettiva. Giuseppe Giaccio ha raccolto nella sua trattazione una coerente mole di dati sulla scia di analisti e specialisti – Paul Collier, Jean-Yves Le Gallou, Massimo Livi Bacci e Paul J. Crutzen, tra gli altri–che in questo ridotto spazio non possono essere direttamente ripresi, ragione per cui rimandiamo alla lettura diretta del testo, ma ci sembra di poter dire, in sintonia con l’autore, che se le realtà periferiche si adatteranno al modello occidentale, ne riprodurranno inevitabilmente l’insostenibilità e le patologie, aggravandole a causa della determinante pressione demografica. L’Occidente se si abbandona la convinzione che il fine dell’economia sia la crescita della produzione di merci. Scrive, al riguardo, Claire Rodier che «l’implementazione di progetti di sviluppo determina il crollo del tessuto comunitario, economico e sociale tradizionale, con la conseguente trasformazione della massa di ex-contadini nel serbatoio per le migrazioni interne e internazionali» (3).
Il Mahatma Gandhi pose il fondamento dell’indipendenza indiana dall’imperialismo britannico rifiutando l’industrializzazione, e arrivò ad affermare che «se una intera nazione [l’India] iniziasse uno sfruttamento economico dello stesso tipo [dell’Inghilterra], devasterebbe il mondo come un nugolo di cavallette». Il mutamento di paradigma deve riferirsi – in controtendenza –alla resilienza, la capacità in natura di autoripararsi dopo un danno o in una comunità (o sistema ecologico) di ritornare al proprio stato di equilibrio dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che ne ha causato l’allontanamento. Il punto è quindi come sottrarsi allo schema vettoriale del progressismo con il suo dettato economicista di “sviluppo illimitato” e di “vantaggi comparati” del mercato globale, ponendo l’evoluzione di identità, culture e società in ciclicità virtuose e sostenibili, che declinino se stesse oltre la modernità, e dove quindi l’economia punti – per dirlo con John Quiggin– sulrealismo piuttosto che sul “rigore”, sull’uguaglianza piuttosto che sulla “efficienza”, sull’umiltà piuttosto che sulla “arroganza”. Bisogna decolonizzare l’immaginario, cioè bisogna uscire dall’ossessione consumistica e dalla logica della crescita infinita, in quanto non si può avere una crescita materiale illimitata in un mondo finito; di conseguenza, bisogna porre dei limiti e trovare un equilibrio.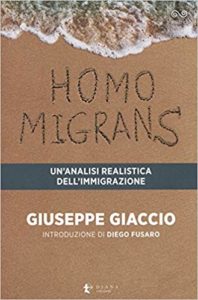
L’impatto dell’immigrazione di massa in Europa ha ovviamente espliciti effetti sulle identità locali e sugli equilibri sociali endogeni. Lo scrittore francese Renaud Camus è arrivato a utilizzare il concetto di “grande sostituzione” (Le Grand Remplacement), per denunciare il fatto che nei Paesi occidentali sarebbe in corso una sostituzione dei popoli con un altro popolo venuto da fuori. Alain de Benoist ha correttamente rilevato come non sia esatto porre la questione in questi termini, perché le implicazioni sono forse ancora più drammatiche, se intese come disgregazione universale di ogni appartenenza e differenza culturale, in quanto la modificazione multietnica in corso rimanda piuttosto a una “grande trasformazione” antropologica. Coloro che gioiscono di questo fenomeno in realtà disprezzano il loro Popolo e vogliono modificarlo, così come desiderano assimilare l’altro da sé, eradicando ogni identità, rappresentandogli immigrati come“felici” di dover lasciare il loro Paese di origine. Afferma coerentemente Alain de Benoist:«L’immigrazione è una forma di sradicamento, un dramma individuale e familiare; di conseguenza, affrontare la tematica dell’immigrazione come un fatto naturale vuol dire strumentalizzare i loro sentimenti». La retorica antirazzista dominante – sorretta propagandisticamente dai mezzi di informazione – si prefigge primariamente di far credere che tutte le critiche all’immigrazione sono ispirate dal “razzismo”, in realtà dissimulando l’adesione al sistema capitalistico. L’antirazzismo ha sostituito l’anticapitalismo e quindi la critica sociale, cioè la capacità di comprendere le cause reali delle disuguaglianze e dell’ingiustizia. Non è infatti più nascosto il piano totalitario (riduzione all’unico), che alimenta il “globalitarismo”, la colonizzazione tecnomorfa dell’umanità, dei “beni comuni” e della biodiversità. Parrebbe una narrazione distopica, ma la reificazione e lo scenario post-umano descritto da Parag Khanna è invece la proiezione dell’imminente; per Khanna, uno dei più rilevanti accademici e teorizzatori dell’omogeneizzazione mondiale, le future mappe del Pianeta non dovranno più rappresentare l’esistenza di entità politiche sovrane, bensì degli spazi economico-finanziari funzionali. Il supply chain world è un mondo trasformato in un indefinito rizoma logistico, in cui un’immensa filiera collegherà domanda e offerta di produzione e consumi in assenza di conflitti politici; la lotta di “tutti contro tutti” per accaparrarsi le posizioni migliori nella catena (chain)è intesa come una “condivisione di opportunità” individuali, ragione per cui la mobilità diviene essenza sublimata della volatilità di un denaro digitalizzato capace, per investimenti e rendita, di creare letteralmente dal nulla pop up cities, in Zone Economiche Speciali (ZES) «governate a tutti gli effetti dalla forza del capitale» (4). Una letterale scomparsa dell’umanità, chiosiamo noi.
C’è da dire che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. La globalizzazione come tentativo indotto di uniformizzazione e annesso annuncio di “fine della storia” (esportazione violenta della liberal-democrazia e abbattimento di ogni barriera alla libera circolazione delle merci e capitali) vive ora un contraccolpo (populismi, richiesta di partecipazione democratica, rilocalizzazione e statuto sociale dell’economico), che si fa terreno d’elezione perun ribaltamento di paradigma. Da una parte c’è un’idea della complessità relazionale delle identità in divenire, su cui è necessario discutere e confrontarsi. Ma, dall’altra parte, si negano le identità in quanto tali ed esiste solo un buco nero che inghiotte ogni diversità, ogni storia, ogni confine, ogni limite, ogni cultura, ogni retaggio, ogni tradizione, ogni comunità, ogni popolo… Per poi rigettare il tutto come una poltiglia assimilata incolore metabolizzata dal mercato globale. Giuseppe Giaccio lancia un vero appello alla «insubordinazione fondante» e alla mobilitazione per un pensiero anti-egemonico trasversale. Una specie di sistema immunitario interconnesso, riattivato di fronte ad un pericolo evidente. La sovranità del politico può e deve uscire dal determinismo unilaterale e porsi al servizio di una visione multipolare e differenzialista del mondo reale, fatto di “grandi spazi” in reciproco confronto ed equilibrio planetario. L’appartenenza, il legame naturale e culturale con la propria identità e le sue tradizioni, è un bisogno fondamentale dell’animo umano, un “comune sentire” che appartiene ad ogni epoca e a ogni cultura. Il modo più coerente di affermarla non è lo sciovinismo e quindi la sopraffazione altrui, ma riconoscere il valore universale dell’appartenenza e integrare la pluralità delle identità in contesti più ampi – come il continente europeo, per quanto ci riguarda – e riconoscere reciproca legittimità e valore alle nazionalità che la compongono. Attualmente, la globalizzazione è il soggetto dominante e contrapporvisi frontalmente è velleitario, ma il suo contenuto può essere rimesso in discussione a partire da una lettura metapolitica della realtà. La mondializzazione finanziaria e tecnologica corrisponde all’espansione planetaria dell’aggressività statunitense e della sola logica della forma capitale; una visione pluralista e multilaterale rappresenta – in contro tendenza – l’unica possibilità di conservare la diversità del Pianeta e il solo mezzo per contribuirvi fattivamente è tramite un’Europa sovrana, perché o si è soggetti della propria storia o si diviene oggetti della storia degli altri.
Note
1) Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’sRole in theTechnetronic Era, 1970, p. 3.
2) Oliver Rey, Dismisura, 2016, p. 169.
3) Claire Rodier, Un’Europa che si barrica, in: Fabio Marcelli (a cura di),Immigrazione, asilo e cittadinanza universale, 2013, p. 460.
4) Parag Khanna, Connectography, 2016, p. 388.
Eduardo Zarelli








1 Comment