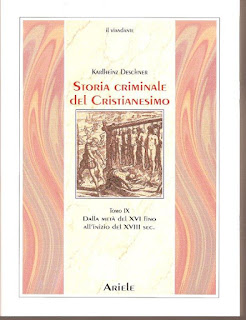Di Fabio Calabrese
Nella prima parte di questo articolo ho (abbiamo, perché io spero che daremo a questi colloqui mediatici il senso di una ricerca condotta insieme) esaminato la leggenda di una derivazione della civiltà e/o di una superiore spiritualità “da oriente”; un esame che mi sembra ne abbia mostrato tutta l’infondatezza, anche se questa leggenda è giunta a condizionare e ad appannare lo sguardo persino di un (presunto) maestro della tradizione come Renè Guenon. Abbiamo visto che non solo l’Europa non è stata tributaria di influenze orientali nel suo sviluppo storico, ma che esiste un’incompatibilità di fondo fra lo spirito indoeuropeo dell’Europa e quello semitico del Medio Oriente. Dal Medio Oriente all’Europa sono venuti solo elementi di dissoluzione, e il cristianesimo è stato il primo e il più grave fra essi. A questo riguardo non è possibile non citare le parole del grande Richard Wagner:
“Per quanto l’innesto sulle sue radici di una cultura che le è estranea possa aver prodotto frutti di altissima civiltà, esso è costato e continua a costare innumerevoli sofferenze all’anima dell’Europa”.
Le consonanze che indubbiamente esistono fra lo spirito europeo, specialmente quale esso ci è attestato nelle sue fasi più antiche come la sapienza greca e la filosofia presocratica, e quello indiano presentano un problema diverso. A mio parere anche in questo caso non si tratta di “luce da oriente”, ma di un comune fondo di cultura indoeuropeo, la stessa luce che si è spostata verso est e verso ovest a partire dall’originaria e ancora non ben individuata patria degli Indoeuropei.
Prima di addentrarci in questa analisi, sarà però il caso di approfondire un punto, una questione che abbiamo lasciato in sospeso nella parte precedente di questo articolo (saggio?).
La bibbia ha avuto un effetto deformante sulla nostra lettura della storia. Nell’Europa antica esiste un vasto insieme di popolazioni “non indoeuropee” ma neppure camitiche o semitiche che occupa gran parte dell’Europa meridionale, mediterranea. E’ difficile stabilire le relazioni reciproche tra queste popolazioni su basi linguistiche poiché in epoca storica sono state sottomesse da élite indoeuropee che hanno portato perlopiù alla sostituzione della lingua dei nativi con la loro, ma le affinità sia antropologiche sia culturali sono piuttosto evidenti: Etruschi, Minoici, Liguri, Iberici, Pelasgi della Grecia continentale, che nel loro insieme potremmo denominare semplicemente “Mediterranei”. La difficoltà a riconoscerli come gruppo, come quarto ramo della famiglia caucasica deriva principalmente dal fatto che non è possibile riscrivere la bibbia per aggiungere un quarto figlio di Noè da cui farli discendere, ed è una prova drammaticamente eloquente del potere che ha ancora questa antica raccolta di favole mediorientali nel condizionare la nostra visione storica.
Poiché è con ogni verosimiglianza della maggior parte dei nostri antenati e di noi stessi che stiamo parlando, non è una questione che si possa lasciar cadere con facilità.
Il mancato riconoscimento dei Mediterranei come gruppo autonomo ha spesso portato alcuni a identificarli o a identificare alcuni di essi (ad esempio talvolta gli Etruschi) con alcunché di semitico; un errore che non dovremmo fare, vista anche la nota propensione dei semiti a impadronirsi sottocosto di ciò che loro non compete (e gratis è proprio un prezzo stracciato), e sicuramente la paternità di capolavori dell’antichità come gli affreschi delle tombe etrusche e dei palazzi micenei o dei templi megalitici maltesi non è certamente un’inezia.
Una volta riconosciuta l’esistenza del gruppo delle popolazioni mediterranee come un insieme autonomo e coerente, ci si rende conto che non sarebbe probabilmente concepibile una maggiore distanza fra le culture proprie di questo gruppo e quelle dell’area semitica. Pensiamo solo a un tratto per tutti, la posizione che la donna aveva (o ha ancora al presente) nelle rispettive società. Che gli antichi Mediterranei inclinassero al matriarcato e che comunque nelle loro culture la donna vi godesse di dignità e di autonomia pari a quella dell’uomo, su questo mi sembra vi siano pochi dubbi. Andiamo a vedere quello che accadeva/accade nel mondo semitico, ciò che ci è testimoniato dall’ebraismo biblico, dall’islam fino al presente, dalle tracce che quella sorta di semitizzazione dell’Europa che è stata la diffusione del cristianesimo ha lasciato nella nostra stessa cultura: ci accorgiamo di avere a che fare con una mentalità, più che patriarcale, sessuofoba e misogina, dove la metà femminile della popolazione era/è tenuta in condizioni di minorità e spesso di segregazione. Il modo in cui la donna è trattata nel mondo islamico, spesso priva di diritti politici del diritto all’istruzione, spesso persino all’assistenza sanitaria, segregata in casa, costretta a nascondersi sotto lo chador o il burqa quando esce per strada, ci fa giustamente orrore, ma dovremmo ricordare che né l’ebraismo biblico né il cristianesimo antico e medievale ci mostrano un quadro sostanzialmente diverso; in particolare quel libro anacronistico che ci ostiniamo a considerare “sacro” ci fa vedere una mentalità per la quale la donna è solo oggetto e non soggetto di diritti, esiste solo per il piacere del
l’uomo e per dargli figli, contro la quale ogni violenza è presentata con noncuranza, e in ultima analisi lecita.
l’uomo e per dargli figli, contro la quale ogni violenza è presentata con noncuranza, e in ultima analisi lecita.
Non è questa la sola differenza che è possibile riscontrare tra Mediterranei e semiti. Immaginiamo di visitare un museo con riproduzioni dei vari capolavori dell’antichità. Passando davanti alla riproduzione di una sezione di ziggurat babilonese o a un toro alato assiro, per poco che siamo sensibili, avremo l’impressione di una grandiosità plumbea, senza vita, proveremo un senso di oppressione. Chi ha realizzato quelle opere, ci viene da pensare, doveva essere gente oppressa da tirannidi politico-sacrali che ne facevano degli schiavi dalla culla alla tomba, esattamente come ancora oggi la vita dei popoli islamici è condizionata da un’ossessione religiosa che si spinge spesso fino al fanatismo e lascia ben poco spazio alla gioia di vivere o non ne ammette semplicemente l’espressione.
Il Geova veterotestamentario è una divinità feroce, pronto a colpire i suoi devoti coi più tremendi flagelli al minimo segno di disobbedienza o di obbedienza non sufficientemente zelante, e ad aizzarli a sterminare i popoli stranieri per farsi e fargli spazio, ma appare ancora quasi mite se confrontato con altre divinità semitiche come Baal e Moloch, avide di sacrifici umani (tracce di sacrifici umani si trovano però anche nella bibbia, a cominciare dalla storia di Isacco). E Allah? È un’altra divinità con la quale è meglio non scherzare.
Proseguiamo la visita al nostro ideale museo e spostiamo ora la nostra attenzione sugli affreschi etruschi e minoici: è un mondo del tutto diverso quello che troviamo: possiamo vedere scene di feste, di cacce, di attività sportive che ci testimoniano di una visione della vita molto più serena e armoniosa: la figura umana è sempre centrale: uomini e donne dai corpi vigorosi ed elastici, che gli artisti non si sono preoccupati troppo di nascondere, e che sembrano apprezzare pienamente le gioie della vita. Forse un elemento importante per capire le differenze psicologiche fra i due gruppi di popoli e culture, è dato dal fatto che uno dei capolavori della statuaria antica, la “dama di Elche”, è opera di un popolo, gli Iberici, che solitamente gli storici non degnano di molta considerazione. Al confronto, le figurine umane ritrovate nei tophet fenicio-punici di Monte Sirai e Mozia appaiono sorprendentemente rozze e primitive, e non credo sia scorretto interpretare la cosa come una testimonianza del fatto che le culture mediterranee accordavano all’essere umano, all’individuo, una centralità del tutto sconosciuta nel mondo semitico.
C’è anche la considerazione – e aggiunge un motivo in più per considerare il mondo mediterraneo e quello semitico due realtà profondamente antitetiche – esposta da Silvano Lorenzoni in La figura mostruosa di Cristo circa l’insensibilità dei semiti alle arti visive (1).
L’ambiente naturale ha certamente un’importanza fondamentale nel modellare la cultura umana: il semita era (è) essenzialmente un figlio del deserto, di un ambiente vuoto fatto di cielo e dune dove le capre strappavano e strappano una magra sopravvivenza da stentati arbusti e il pastore e allevatore semitico a sua volta strappava e strappa una magra sopravvivenza dalla carne e dal latte delle capre. Questa condizione, per la quale la natura, priva di qualsiasi intrinseca sacralità, è vista come qualcosa di ostile che l’uomo deve dominare e soggiogare, e verso la quale può ritenere di agire senza alcun freno, è certamente alla base del rapporto uomo-ambiente naturale come è tratteggiato dalla bibbia, e sappiamo l’effetto deleterio che ciò ha avuto sulla cultura occidentale che ha compreso tardi (forse troppo tardi) che non è possibile agire verso il mondo naturale con spirito aggressivo e irresponsabile senza pagarne prima o poi pesanti conseguenze.
Sempre i nostri affreschi etruschi e in questo caso soprattutto minoici, ci testimoniano un atteggiamento ben diverso; noi non abbiamo testimonianze scritte, ma le pitture parietali di Cnosso e di Tirinto ci dicono che quella era gente che amava profondamente il mare e le pianure verdeggianti e ricche di fiori, della cui flora e della cui fauna ci ha lasciato splendide raffigurazioni.
Dalle nostre origini mediterranee non possiamo ricavare altro che motivi di fierezza. L’elemento mediterraneo è un costituente fondamentale della civiltà europea, mentre al contrario quello semitico è qualcosa di estraneo ad essa, che per l’Europa è sempre stato una minaccia, sia quando si è presentato sotto la forma dell’aggressione esterna, ad esempio con le invasioni islamiche saracene, sia quando ha scelto la via dell’infiltrazione e della colonizzazione spirituale, come con la cristianizzazione, che è stata la principale causa dello sfacelo dell’impero romano e del tramonto del mondo antico.
Chiarito in maniera spero esauriente questo punto non secondario, torniamo al tema principale della nostra trattazione. E’ bene precisare subito una cosa: l’induismo e il buddismo nel mondo occidentale sono stati letti in vari momenti in modi diversi, perlopiù scorretti, che rispondevano non al reale volto di queste due religioni, quanto piuttosto a tendenze emerse nella cultura occidentale in quel particolare momento. Nel periodo fra le due guerre mondiali, Renè Guenon e Julius Evola si sono occupati con ampiezza dell’induismo mistificato dei teosofi e di Schurè. Negli anni ’70 abbiamo avuto un’altra “buttata” di orientalismo che ha rimasticato temi induisti e zen in commistione con New Age e umori hippy che, sull’esempio dei Beatles ha disegnato un modello di religiosità fai-da-te con l’ausilio di guru pret-a-porter dove non si sapeva bene se “yoga” era il nome di una ginnastica orientale o di un succo di frutta. E’ chiaro che un discorso serio sull’induismo deve prendere in primo luogo le distanze da questa paccottiglia.
L’aspetto forse più interessante dell’induismo vedic
o sono le affinità che esso presenta con aspetti importanti della cultura europea a cominciare dalla sapienza greca e la filosofia presocratica. A questo riguardo, vi rimando direttamente ai concetti che ho espresso nell’articolo Pitagorismo, platonismo, cristianesimo. La vita concepita tragicamente come un ciclo incessante di nascite e morti, l’istinto vitale come causa di desiderio, violenza e di un karma che andrà espiato, anche la somiglianza del pensiero di Anassimene con la concezione indiana del prana; se poi vi accostiamo il fatto che le scuole vediche dell’India come le più antiche scuole filosofiche e le scuole druidiche del mondo celtico contemplavano tutte una dottrina esoterica che non poteva essere trasmessa altrimenti che in modo diretto fra maestro e allievi, e attraverso una lunga comunanza di vita, si ha la sensazione di toccare un comune retaggio anteriore alla suddivisione degli indoeuropei nei vari rami, popoli e culture.
o sono le affinità che esso presenta con aspetti importanti della cultura europea a cominciare dalla sapienza greca e la filosofia presocratica. A questo riguardo, vi rimando direttamente ai concetti che ho espresso nell’articolo Pitagorismo, platonismo, cristianesimo. La vita concepita tragicamente come un ciclo incessante di nascite e morti, l’istinto vitale come causa di desiderio, violenza e di un karma che andrà espiato, anche la somiglianza del pensiero di Anassimene con la concezione indiana del prana; se poi vi accostiamo il fatto che le scuole vediche dell’India come le più antiche scuole filosofiche e le scuole druidiche del mondo celtico contemplavano tutte una dottrina esoterica che non poteva essere trasmessa altrimenti che in modo diretto fra maestro e allievi, e attraverso una lunga comunanza di vita, si ha la sensazione di toccare un comune retaggio anteriore alla suddivisione degli indoeuropei nei vari rami, popoli e culture.
Un fatto che ho già rimarcato (si veda in particolare Il totalitarismo cristiano), è che i paraocchi abramitici tipici del cristianesimo rendono assai arduo rendersi conto di come stano effettivamente le cose; avevo osservato come per i cristiani il fatto che per i filosofi greci “Dio” non fosse percepito come entità personale (il Dio di Senofane di Colofone, l’Idea del Bene per Platone, il Dio “Motore Immobile” – che muove tutto e da nulla è mosso, di Aristotele) costituisce il limite della filosofia antica e, nello stesso tempo l’assurdità di interpretare, appunto come divinità – persona il Brahman dell’induismo o il Tao del taoismo, che è un modo per ridurre queste concezioni in termini cristiani.
La verità è tutt’altra, perché il cristianesimo non ha rappresentato un progresso dello spirito ma un enorme arretramento della cultura europea. Il Dio – persona cristiano (che poi non è altro che il Geova totemico degli Ebrei promosso a divinità universale) è un rozzo antropomorfismo (“Un Dio con mani e piedi” confessò “sant’” Agostino in un raro momento di sincerità) che avrebbe creato il mondo come un vasaio modella la creta. “Dio” inteso come fondo ontologico dell’universo, che è altra cosa dagli dei, non può non essere impersonale, e che da questo punto di vista la concezione indiana e quella greca si somiglino, non può certo essere fonte di meraviglia.
Siamo qui, lo si vede bene, vicini alla riscoperta di una metafisica originale indoeuropea, e non può stupire che quanti hanno cercato di tirare fuori l’Europa dalle panie cristiano-marxiste-democratiche in termini di pensiero e di azione politica abbiano spesso sentito l’induismo vicino; prima fra tutti la nostra grande Savitri Devi.
Un punto critico per quanto riguarda l’induismo è rappresentato dalla questione delle caste. In un mio scritto apparso sul sito del Centro Studi La Runa, Oltre la destra e la sinistra, ho usato il termine in un’accezione negativa, contrapponendo “società di caste” in cui la mobilità sociale è scarsa o nulla a “società di élite” in cui le persone si trovano aperta la strada di una collocazione sociale corrispondente alle loro capacità e meriti; l’uso del termine era quindi generale, ma non mancava lo specifico riferimento al caso indiano. A lungo termine il sistema delle caste ha reso la società indiana non efficiente e non competitiva rispetto a quella europea (anche se sono innegabili momenti di splendore: pensiamo all’epoca Moghul, dove si è avuta la realizzazione di capolavori architettonici come il Taj Mahal). Cosa si può dire a questo riguardo?
Quando gli Ari giunsero in India, essa era abitata dai Dravidi, che essi sottomisero, una popolazione non caucasica, “scura” ma non negroide che aveva già dato vita a una cultura conosciuta come “di Mohenjo Daro” (dal suo centro più importante) o “della Valle dell’Indo”. E’ probabile che il sistema delle caste sia nato in primo luogo per tenere separati gli Ari conquistatori dai Dravidi sottomessi, quello che oggi chiameremmo un apartheid. Perché l’idea che il figlio di un uomo adatto a svolgere una determinata funzione sia “naturalmente” adatto anch’egli a svolgerla, alla lunga non ha funzionato? Perché gli esseri umani non si riproducono per talea come le viti o i gerani; nessun uomo è la copia genetica del proprio genitore. Se non parliamo di colore degli occhi o di gruppi sanguigni, ma di talenti, attitudini, è probabile che ciascuna di esse non sia legata a un singolo gene, ma a una costellazione genetica complessa che può anche non ripresentarsi nella discendenza. Possono senza dubbio essere avvenute anche unioni illegittime, adulteri rimasti segreti.
Di quando in quando nella casta nascevano individui inadatti ai compiti che essa era chiamata a svolgere, e la rigidità sociale li manteneva in quella posizione impedendo loro di spostarsi in ruoli più acconci. Alla fine, il sistema delle caste si rivela il più adatto per provocare la dispersione in modo assolutamente casuale di talenti, attitudini e capacità lungo tutta la scala sociale, fa sì che “l’uomo giusto al posto giusto” diventi solo un’improbabile coincidenza.
Quel che è venuto a mancare nel sistema indiano è il concetto di selezione, frutto della cura costante che Platone raccomandava ai custodi della sua Repubblica nel vagliare le capacità e le attitudini dei giovani, indipendentemente dal censo di nascita. Platone fa in ogni caso parte della tradizione indoeuropea; se l’Europa ha una metafisica autoctona, essa si trova nel pensiero di Platone. Noi “moderni” a ogni modo non abbiamo alcun titolo per schernire il sistema indiano. Nei nostri orizzonti politici continuano a confrontarsi una “destra” che difende il privilegio dato dal caso di nascita o dal censo e una “sinistra” che predica l’egualitarismo più innaturale. Possiamo davvero credere che fra gli uomini non esistano differenze di sorta o che, là dove esistono, esse siano soltanto il prodotto dell’educazione e dell’ambiente?
Basandosi su tali presupposti, l’utopia egualitaria marxista incarnata nello stato sovietico è andata incontro forse al più spettacolare fallimento della storia nel giro di una settantina di anni, più o meno l’arco di una vita umana neppure particolarmente longeva. E la democrazia “liberale”? Diamole ancora tempo, che sarà comunque un’inezia a confronto dei millenni della civiltà indiana!
Mohandas Gandhi, il Mahatma, la “Grande anima” è stato un riformatore dell’induismo, una personalità per certi versi interessante, un grande mistico in un’epoca desolatamente priva di mistici come la nostra, eppure proprio la sua dottrina più nota, quella della non violenza, desta non pochi sospetti; per prima cosa, è difficile non riconoscere in essa qualcosa di svirilizzante. Sul piano pratico, con la non violenza Gandhi è riuscito a mettere fine al dominio inglese sull’India, ma la non violenza può funzionare facendo appello a un fondo di umanità presente nel nemico, sulla naturale repulsione a incrudelire su di un avversario che offre la gola disarmato. Si può fermare un treno sdraiandosi sui binari solo finché chi è alla guida del treno non se la sente di schiacciare sotto le ruote coloro che protestano in questo modo.
Quando questo fondo di umanità non c’è, la non violenza si rivela miseramente inutile. Pensiamo all’invasione del Tibet da parte della Cina comunista: anche i Tibetani cercarono di opporsi ai Cinesi con la non violenza e ottennero l’unico risultato di facilitare ai comunisti il genocidio del loro popolo. Il comunismo abolisce questo fondo di umanità, cancella la differenza fra l’essere umano e la belva feroce. Questa è una sua caratteristica tipica, ma probabilmente non esclusiva; il cristianesimo dei primi secoli, quanto meno, aveva altrettanta capacità di trasformare gli uomini in belve sanguinarie, pensiamo all’atroce martirio cui è stata sottoposta la sfortunata Ipazia!
Proprio nella cultura indiana, Gandhi avrebbe avuto motivi per ripensare la sua dottrina della non violenza, pensiamo a quel testo sacro dell’induismo che è la Bagavad Ghita, imperniato sul dialogo fra il guerriero Arjuna riluttante a scendere in battaglia e il suo scudiero Krishna che, Arjuna non lo sa, ma è un avatar, un’incarnazione del dio Vishnu. Non sono tanto le azioni quanto gli atteggiamenti e i moti dell’animo che li accompagnano, a creare il karma. Il guerriero che lotta con animo puro, senza odio o crudeltà, che rispetta l’avversario e i codici d’onore, che non incrudelisce sugli inermi, non si crea un cattivo karma, anzi!
E’ un tipo di lezione che forse oggi stentiamo a comprendere: non ci sono più guerrieri; in compenso la guerra, un tempo contenuta entro precise regole, è diventata sempre più brutale e distruttiva, non fa più distinzione fra combattenti avversari e civili, fra armati e inermi, mira alla distruzione illimitata per “demoralizzare” il nemico, secondo la tecnica che le tribù barbariche di trogloditi che vivono tra Messico e Canada hanno messo a punto durante la seconda guerra mondiale.
La dottrina della non violenza è forse il frutto estremo dell’individualismo democratico che a sua volta discende dai “magnanimi lombi” del cristianesimo assai più di quanto i democratici “laici” siano disposti ad ammettere.
Noi forse siamo portati a dare troppo peso alla vita dell’individuo, alla sofferenza e alla morte che ciascuno può causare e ricevere, dimenticando che l’esistenza di ciascuno di noi è effimera, destinata a durare non più di poche decine di anni, e che l’unica speranza di immortalità di cui abbiamo una prova tangibile, è la continuità dei nostri geni, la stirpe. Di fronte alla minaccia ad essa, la sofferenza che possiamo causare o subire, la vita che possiamo togliere o vederci strappata, hanno un’importanza relativa. Nessun principio morale può giustificare il rifiuto di impugnare le armi per difendere la patria.
L’interesse per il pensiero dell’Asia ulteriore, quella che sta oltre il Medio Oriente semitico, da parte degli ambienti “nostri” è una cosa ovvia. Si può ricordare che ad esempio Julius Evola è stato l’autore de La dottrina del risveglio, una delle migliori esposizioni del buddismo che esistono in Europa, e che ricevette l’imprimatur della Pali Society, oltre ad aver posto mano a Il libro del principio e della sua azione, una traduzione corretta Tao Te King, il libro sacro taoista il cui titolo viene perlopiù impropriamente tradotto come Il libro della via e della virtù. Evola ha anche espresso nei suoi scritti un’alta considerazione per il Giappone, la terra del Sol Levante, patria dei samurai e dei kamikaze, a cui invece sembra che René Guenon non abbia prestato la minima attenzione, un atteggiamento che già evidenzia la differenza di carattere fra i due, suggellata in maniera non saprei se tragica o grottesca dalla conversione all’islam del “maestro” francese.
“Le società tradizionali”, ha detto qualcuno, “Sono quelle dove non esistono tradizionalisti”.
Sembra un paradosso, ma non è che la verità pura e semplice. Le società, ma sarebbe meglio dire le culture tradizionali, sono quelle dove “la tradizione” non è una scelta, ma il modo di vivere e l’insieme dei valori comunemente accettati. E’ significativo che per lungo tempo lo scintoismo giapponese non ha avuto neppure un nome: era semplicemente la devozione spontanea del popolo nipponico verso il suo pantheon di divinità grandi e piccole, gli antenati, la propria identità, la patria incarnata dalla figura dell’imperatore, non era “una” religione, era “la” religione tout court. Ne ha avuto uno, quando in Giappon
e sono arrivati i missionari buddisti, “Shinto”, “la vecchia fede”, “la tradizione”, per distinguersi dai nuovi credenti.
e sono arrivati i missionari buddisti, “Shinto”, “la vecchia fede”, “la tradizione”, per distinguersi dai nuovi credenti.
“Shinto”, fedeltà alle proprie radici, alla propria identità, è ciò di cui abbiamo spaventoso bisogno anche noi, e non possiamo altro che guardare con profonda stima e grande rispetto al popolo del Sol Levante che è riuscito a diventare una delle prime potenze mondiali a livello tecnologico e industriale mantenendo pressoché intatta la propria tradizione, la propria identità culturale, e senza passare per nessuna delle convulsioni che la cristianizzazione prima, “la modernità” poi hanno imposto all’Europa.
Stima e rispetto, tuttavia si comprende bene che una conversione allo scintoismo non avrebbe senso per chi giapponese non è. E’ piuttosto verso le nostre radici e i nostri antenati che dobbiamo guardare, antenati di cui certo non abbiamo alcun motivo di provare vergogna, in particolare quegli antenati vissuti prima della cristianizzazione, che non hanno solo creato un impero circum-mediterraneo che è arrivato ad abbracciare quasi tutto il mondo allora conosciuto, ma l’hanno saputo amministrare dandogli buone leggi e una cultura superiore che in tanti aspetti è ancora oggi la nostra, basti pensare alla lingua che parliamo e l’alfabeto con il quale scriviamo. L’esempio nipponico può aiutarci a riscoprire realmente ciò che veramente siamo, al di là dell’offuscamento prodotto da una fede straniera giunta dal Medio Oriente: figli di Roma.
Note:
- “L ’estetologo Richard Eichler, citando un’ebrea, certa Salcia Landmann, ci informa che i beduini, predecessori degli ebrei, mancano di sensibilità per le immagini visuali, da dove deriva l’inimicizia ebraica per le arti plastiche, la quale verrebbe quindi a essere una mancanza di tipo genetico; e questa inimicizia sarebbe stata trasmessa a quei cristianesimi che più si sono riavvicinati alla ‘radice ebraica’, il calvinismo e l’islam”.
Silvano Lorenzoni: La figura mostruosa di Cristo e la convergenza dei monoteismi, Primordia, Milano 2011.