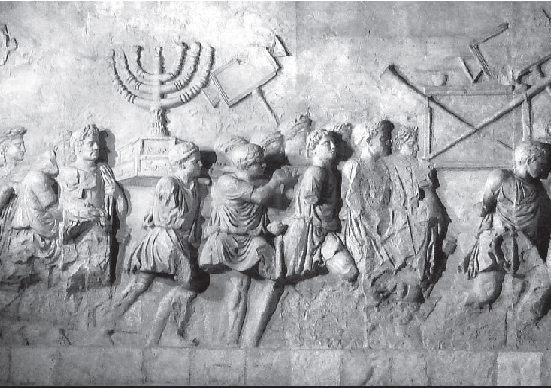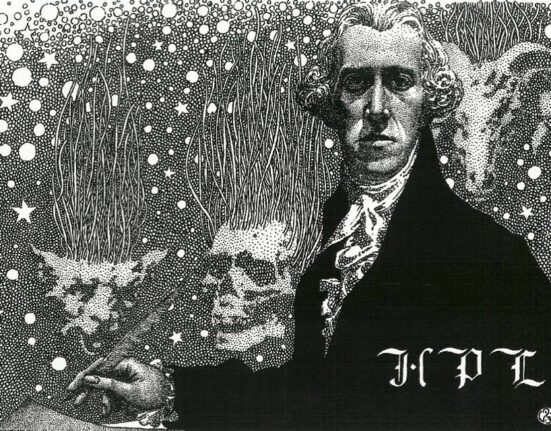Come sempre, anche quest’anno il 4 novembre, anniversario della vittoria italiana nella prima guerra mondiale è passato quasi inosservato, mentre, come ben sappiamo, annualmente il 25 aprile, la sconfitta riportata nel secondo conflitto viene celebrata in pompa magna quasi si fosse trattato di una vittoria. Mi chiedo, continuo a chiedermi, quanto questa autentica ridicolaggine e le continue e crescenti attestazioni di servilismo verso l’invasore straniero di oltreoceano che ci ha assoggettati, quanto disprezzo e quanto sarcasmo ci procurino all’estero dietro le nostre spalle.
Per la verità, ero indeciso se intitolare questo articolo La vittoria dimenticata oppure La vittoria mutilata, termine che fu usato all’epoca per indicare la sproporzione fra l’enorme costo di sangue e vite umane che essa era costata e la relativa modestia dei risultati conseguiti, infine ho optato per La vittoria tradita, termine che mi pare riassuma bene entrambi i concetti, sia la delusione di allora, sia la smemoratezza di oggi.
Cominciamo con il sottolineare un punto importante: certamente l’amarezza per la vittoria mutilata, la constatazione dell’inadeguatezza della classe dirigente di allora a far fruttare il costo umano elevatissimo della guerra che ci era costata un milione di morti, la falcidie di un’intera generazione, fu uno degli elementi che aprirono la strada al fascismo. La critica e la “storiografia” (le virgolette sono d’obbligo) di sinistra, da sempre avverse a tutto ciò che è nazionale, hanno cercato di presentare l’idea della vittoria mutilata come un mito infondato, segno di un nazionalismo incontentabile, eppure, ecco quanto scriveva Franco Bandini, non fra il 1922 e il 1943, ma nel 1968 in occasione del cinquantenario del conflitto, e non su un periodico dell’estrema destra, ma nella sua storia della prima guerra mondiale pubblicata a puntate sulla “Domenica del Corriere”.
Vediamo il brano dove si descrive il comportamento della delegazione italiana alla conferenza di Parigi del 1919 dove furono stipulati i trattati di pace:
“Ottenuta sicurezza alle frontiere del nord-est (ed era stato il nostro principale problema) era necessario volgersi in altre direzioni meno ideali ma più pratiche: le colonie, gli indennizzi finanziari o in materiali, grandi prestiti, soprattutto americani, che ci aiutassero a vincere anche la nostra costituzionale debolezza economica. In altre parole, sbocchi commerciali, fonti di reddito in materie prime, apporti di naviglio mercantile, materiali, denaro: tanto maggiori fossero state queste acquisizioni, tanto più forte e feconda sarebbe diventata la nostra posizione nel Mediterraneo e in Europa.
Non facemmo nulla di tutto questo (…)… In quei tristi ed amari mesi del 1919, al contrario, perdemmo, forse per molti decenni, non solo il risultato di quell’immane sacrificio che era stata la guerra, ma anche il frutto del paziente lavoro che i padri avevano accumulato nell’erezione di un grande stato nazionale dal 1870 in poi”.
Ciò che non era stato capito era che “gli alleati” a fianco dei quali avevamo sostenuto quattro durissimi anni di guerra (gli stessi che poi ci sbraneranno nel secondo conflitto) non erano in realtà più nostri amici di quanto lo fossero gli austro-tedeschi, ed erano intenzionati a concederci il meno possibile.
“Gli alleati non potevano negarci la soddisfazione della polverizzazione dell’impero austriaco, semplicemente perché non era in loro potere resuscitare cadaveri, ma si sarebbero opposti con energia a qualsiasi rivendicazione che intaccasse i loro interessi e i loro compensi”.

Le difficoltà politiche che incontrammo erano almeno in parte legate alla situazione militare verificatasi nell’ultimo anno di guerra. Il 24 ottobre 1917 si era verificato lo sfondamento di Caporetto, che aveva costretto le nostre truppe a lasciare in mano austriaca una notevole fetta di territorio (Caporetto, oggi Kobarid è nell’odierna Slovenia), tutto il Friuli fino al Piave.
Perdere una battaglia non significa perdere la guerra, ma Caporetto fu vissuta in maniera traumatica perché evidenziava lo stato di crisi del nostro esercito dopo tre anni di durissima guerra di trincea e soprattutto il dissanguamento conseguente alla strategia imposta da Luigi Cadorna con offensive che avevano comportato ingentissime perdite umane a fronte di risultati territoriali modesti. Armando Diaz, scelto dal re per sostituire Cadorna nel ruolo di comandante supremo, e promosso a questo compito direttamente da generale di brigata, si sentiva, ed era inadeguato a tale compito. Fece l’errore contrario di quello di Cadorna, adottando una strategia di prudenza eccessiva. La battaglia del Piave del giugno 1918, il tentativo austriaco di un nuovo sfondamento, e la controffensiva italiana che portò il nostro esercito a rimettere piede sulla sponda orientale del fiume, evidenziarono che gli Austriaci avevano dato fondo a tutte le loro risorse ed erano ormai prossimi al collasso, sarebbe bastata una spallata per conseguire quel risultato che Cadorna aveva inseguito invano per tanto tempo. Tuttavia, Diaz esitò.
Bandini lo racconta chiaramente: il generale francese Joffre fece notevoli pressioni su Diaz perché gli italiani non si muovessero, paventando il ripetersi del disastro di Caporetto, pressioni alle quali Diaz era fin troppo disposto a cedere. Ma non era sollecitudine nei nostri confronti.
Il collasso dell’esercito austriaco sarebbe comunque avvenuto, e infatti avvenne il 24 ottobre a Ceneda, poi ribattezzata Vittorio Veneto, in singolare coincidenza con l’anniversario di Caporetto, ma così sarebbe sembrato non una conseguenza della vittoriosa battaglia del Piave, ma un successo “in scia” delle offensive franco-inglesi di luglio sul fronte occidentale, di modo che ci presentammo al tavolo della pace non come i vincitori del Piave e di Vittorio Veneto, ma come gli sconfitti di Caporetto, esattamente come volevano i franco-inglesi, la cui posizione nei nostri confronti era già allora di assoluta malafede.
Un articolo di qualche anno fa su queste stesse tematiche (sempre su “Ereticamente”) l’avevo intitolato Tra l’incudine e il martello, evidenziando che, tra le tre opzioni, schierarsi con l’Intesa, gli Imperi Centrali o una neutralità che ci avrebbe comunque esclusi dall’avere voce in capitolo sugli assetti postbellici che riguardavano anche terre etnicamente italiane, non c’era una scelta giusta, eravamo tra l’incudine e il martello precisamente perché ciascuna delle tre opzioni avrebbe avuto i suoi contro anche pesanti.
L’Italia era nata come stato nazionale nel 1861, si era affacciata su quello che allora si chiamava “il concerto delle potenze” e oggi “l’ordine internazionale” come un parvenu. A parte la frammentazione in un mosaico di staterelli, diverse terre etnicamente italiane erano sotto dominio straniero, e lo sono tuttora. Schierarsi con l’Intesa significava rinunciare a Nizza, alla Corsica, a Malta. Di più, il dominio inglese sul Mediterraneo attraverso la linea Gibilterra-Malta-Alessandria ci bloccava nelle nostre acque territoriali. Dal punto di vista economico, eravamo in guerra con la Francia. Tutte ragioni che ci avevano spinti per evitare l’isolamento internazionale, a cercare l’alleanza con la Germania di Bismarck, che però aveva un pesante scotto, quello di doversi alleare anche con l’odiata Austria.
Che la Triplice Alleanza fosse un accordo instabile in cui due potenze sostanzialmente nemiche erano tenute insieme dal comune interesse ad avere buoni rapporti con la Germania, si vide bene nel 1908, quando l’Italia si trovò in difficoltà a causa del disastroso terremoto di Messina, e a molti alla corte di Vienna parve il momento adatto per aggredirla. Avevamo, si disse, “un alleato con denti di lupo”.
Contrariamente a quello che si sente dire spesso, fu l’Austria, non l’Italia a violare per prima la Triplice Alleanza. Non avevamo del tutto rinunciato alle terre irredente del nord-est. L’accordo prevedeva che a ogni incremento territoriale dell’Austria nei Balcani in conseguenza della disgregazione dell’impero ottomano, corrispondesse una cessione austriaca di territorio all’Italia, si sperava cioè di completare l’edificio risorgimentale per via diplomatica. Tale accordo si rivelò ben presto un pezzo di carta: L’annessione austriaca della Bosnia Erzegovina non ci fruttò nemmeno un metro quadrato di territorio. Ovvio, quindi, che l’Italia non se ne sentisse vincolata.
Quello che è peggio, però, è che proprio perché nelle terre irredente si manifestava una propensione evidente a ricongiungersi allo stato italiano, dal 1867 Vienna aveva cominciato a favorire in tutti i modi l’elemento slavo (e più marginalmente tedesco) a discapito di quello italiano.
La repubblica democratica e antifascista instaurata dai vincitori dopo la seconda guerra mondiale ha provocato in molti di noi un forte senso di nausea, così molti si sono inventati pseudo-nazionalità, si vuole essere padani o bi-siculi (delle Due Sicilie), tutto fuorché italiani, e non stupisce che alcuni, qui nel nord-est si siano inventati di essere mitteleuropei, e la leggenda che “L’Austria era un Paese ordinato”. Ordinato, forse, ma non certo equanime verso i propri sudditi.
In sostanza si può dire che i motivi per schierarsi a fianco dell’Intesa o degli Imperi Centrali si pareggiassero. Non solo a Parigi nel 1919 non ricevemmo nulla più del completamento del nostro edificio nazionale, ma esso non fu neppure completo. Ci fu negata la Dalmazia, e se non fosse stato per D’Annunzio, non avremmo avuto neppure Fiume.
La situazione determinatasi dopo la seconda guerra mondiale è in un certo senso ancora peggiore di quella alla vigilia dei due conflitti, infatti, se è vero che Trento e Trieste sono rimaste italiane (Trieste, per la verità, è stata restituita all’Italia dopo un’odissea di nove anni), il nostro nord-est è stato mutilato dell’Istria e del 90% della Venezia Giulia prebellica, ma quello che è peggio, è che nelle terre già etnicamente italiane passate sotto il dominio della Jugoslavia comunista, la presenza italiana è stata cancellata con inaudita violenza, con atrocità sulle quali la repubblica democratica e antifascista ha steso per decenni un velo di silenzio colpevole e complice.
Di questo, oggi non molti si curano: aver ottuso e distrutto il senso di appartenenza nazionale, non è la colpa minore della democrazia antifascista instaurata dai vincitori.
Tuttavia è forse il caso di fare un passo indietro. Gli storici ancora oggi si interrogano sul perché della Grande Guerra, un conflitto che appare “senza cause”. L’attentato di Sarajevo nel quale fu ucciso l’erede al trono austriaco appare come un cerino acceso in una polveriera, poi il meccanismo automatico delle alleanze avrebbe fatto il resto. Troppo poco per spiegare quello che è stato definito “il suicidio dell’Europa”.
Poiché io non credo all’assenza di cause degli avvenimenti storici, sarà il caso di fare un ragionamento tipico delle inchieste poliziesche, cui prodest? A chi conviene?
Allora c’è chiaramente un indiziato, la Gran Bretagna. Essa è stata la prima a conoscere la rivoluzione industriale già alla metà del XVII secolo, e questo le ha assicurato una posizione preminente a livello planetario per tutto l’ottocento, ma all’alba del XX secolo, le cose sono ormai cambiate, mentre l’industria inglese mostra segni inevitabili di obsolescenza, due nuove potenze industriali sono sorte: gli Stati Uniti e la Germania. Gli Stati Uniti erano ovviamente fuori portata, e poi avevano nel Nuovo Mondo la loro sfera d’azione, ma con la Germania era tutto un altro affare. La meccanica tedesca, la precisione tedesca erano la meraviglia dell’Europa di inizio novecento. Cosa c’era di meglio da parte inglese se non un conflitto europeo di grandi proporzioni che distruggesse la Germania e dai cui effetti devastanti la posizione insulare della Gran Bretagna la metteva al sicuro?
Forse un po’ meno, ma comunque interessata a scatenare una nuova guerra in Europa era anche la Francia, cui nel 1870 la Prussia, non ancora impero tedesco, aveva tolto l’Alsazia e la Lorena.
Che da parte inglese vi sia stato un intenso lavorio politico e diplomatico allo scopo di arrivare al conflitto abbiamo una testimonianza, grazie a Bertrand Russell, uno dei filosofi più originali e anticonformisti del XX secolo, che subì anche la carcerazione per la sua opposizione alla guerra, una testimonianza invero celata in un contenitore alquanto bizzarro (e forse per questo sfuggito a chi ci vuole imporre una visione prefabbricata della storia): nel libro Il terribile giuramento della signorina X (The terrible Statement of Lady X) pubblicato nell’edizione italiana nel 1972 da Rizzoli, un testo che raccoglie in non molti esperimenti di Russell nel campo della narrativa, si trova inaspettatamente un brano che parla delle cause della prima guerra mondiale, ed è una lettura sorprendente:
“Quando la flotta russa sparò contro dei pescherecci inglesi al Dogger Bank, approvai Arthur Balfour [il primo ministro di allora NDA], del quale in genere pensavo male, perché trattò l’incidente con spirito conciliante. Non mi accorsi allora che stava soltanto preparando guerre di più vasta portata (…)…
Sir Edward Grey, allora all’opposizione, parlò a favore di quella che poi diventò la politica delle Ententes con la Francia e la Russia, la quale venne adottata dal governo conservatore circa due anni più tardi, e successivamente consolidata da sir Edward Grey quando egli divenne ministro degli esteri. Espressi con decisione il mio parere contro questa politica, la quale a mio parere conduceva dritto alla guerra mondiale”.
A lato delle parole di Russell, si può ricordare l’incidente coloniale di Fachoda del 1898, parallelo a quello del Dogger Bank, dove le truppe coloniali inglesi e francesi si scontrarono, e fu la Francia a trattare la cosa con spirito conciliante, in vista di null’altro se non di non perdere l’alleato inglese nella futura guerra contro la Germania.
Con la politica delle Ententes, cioè con l’adesione inglese all’Intesa franco-russa in funzione anti-tedesca, lo scenario era pronto, e sarebbe bastato un cerino per far scoppiare l’immane deflagrazione.
La testimonianza di Russell distrugge anche quello che è stato l’alibi standard delle due guerre mondiali, utilizzato nella prima, poi altrettanto bene nella seconda, ossia l’esportazione della democrazia:
“Sapevo che la Germania del Kaiser, sebbene avesse molti difetti, era molto più liberale di qualsiasi regime continentale di quei tempi, tranne quelli dell’Olanda e della Scandinavia. La Russia zarista aveva da tempo riempito d’orrore tutta la gente di idee liberali, e trovavo intollerabile l’idea di entrare in guerra per sostenerla”.
Ovviamente, non si possono che compiangere i Russi che con il crollo dell’impero zarista e l’instaurazione della tirannide bolscevica sono caduti dalla padella nella brace.
Oggi lo scenario è profondamente mutato rispetto ad allora, le due guerre mondiali hanno privato l’Europa della posizione centrale a livello planetario goduta fino al XX secolo, con l’emergere delle potenze americana e sovietica, TUTTI gli stati europei ne sono usciti sconfitti, anche quelli nominalmente vincitori. Peggio ancora, con il crollo dell’impero sovietico, abbiamo scoperto che il dominio statunitense, lungi dall’essere un meno peggio, prepara la morte dei popoli europei per sostituzione etnica. Se vogliamo intraprendere la via di un’improbabile salvezza, dobbiamo ritrovare l’orgoglio della nostra appartenenza nazionale, smettendo di celebrare sconfitte e ritrovando la fierezza della nostra vittoria dimenticata e tradita.
NOTA: Nell’illustrazione, Grande Guerra, fanti italiani all’assalto in un manifesto dell’epoca.