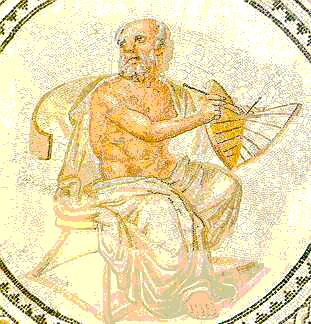Anassimandro da Mileto, vissuto tra la fine del settimo e la prima metà del sesto secolo nell’antica Grecia ionica, è il primo pensatore che ha lasciato uno scritto che segna l’inizio della filosofia europea. Il suo detto, che è un brevissimo frammento riportatoci dal filosofo sincretista Simplicio, che visse circa mille anni dopo Anassimandro, rivela già tutta la potenza e la profondità estatica del suo genio, poiché in poche righe si trovano, in estrema sintesi, tutte le problematiche della filosofia, che per la sua specificità è il sapere che studia l’essere e il fondamento.
In questo lavoro non si leggerà il detto anassimandreo dal punto di vista filologico: celeberrimi sono stati a tal proposito, ma non solo, i saggi di Heidegger (1) o di Severino (2), per non citare altri come quelli di Nietzsche o Diels. Lo scopo è invece quello di comprendere e far comprendere il senso profondo della scoperta di Anassimandro, ossia la scoperta dell’Infinito, come principio o archè, ovvero il fondamento primo, e la conseguente scoperta della dialettica, intesa come lotta fra contrari. Il testo che si userà è quello classico di Diels, e che dice:
“Anassimandro… ha detto… che principio degli esseri è l’infinito… da dove infatti essi hanno l’origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi pagano l’uno all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo” (3).
La parola nuova, potente, che segna davvero l’inizio del pensare è la parola Infinito. Per esattezza il termine che adopera Anassimandro è àpeiron, che in greco significa illimitato, senza confini. Ma illimitato significa appunto infinito che tutto comprende, ovvero ciò che è manifestato e ciò che non è manifestato. Aristotele nel terzo libro della “Fisica” definì tale principio, come principio fisico e materiale. Questa interpretazione oggi è considerata dai più erronea , in particolare da G. Colli nel suo saggio “Aristotele e le origini della filosofia” (4). In realtà già nel quarto libro della “Fisica” Aristotele conviene che nel detto del Milesio l’Infinito contiene una “legge” interna, un Lògos che attraverso i contrari regola la vita degli enti che sono da lui contenuti. E’ chiaro che il Lògos, che nel greco antico aveva il significato precipuo di Discorso non poteva essere un elemento materiale, come per esempio l’acqua di Talete. La lotta fra contrari, come si vedrà, non può essere concepita che come principio razionale immanente all’interno dell’Infinito stesso. Anzi, la fisionomia “spirituale” dell’Infinito si precisa proprio grazie a questo Lògos, che il filosofo Jaeger vede esteso “non solo alla vita umana, ma nell’intero universo, negli esseri tutti” (5).
L’àpeiron è quindi l’Infinito che lo stesso Aristotele ricorda essere “…ingenerato ed incorruttibile…”, “… che abbraccia e governa tutte la cose…”, e che a differenza di queste e “…senza morte… e senza distruzione…”. In altre parole l’Infinito è eterno, indeterminato, illimitato, unico. Eterno perché senza tempo, in quanto il tempo stabilisce il prima e il dopo delle cose finite (degli enti) e mondane. Indeterminato perché non è una parte, ma è la Totalità che è oltre le parti. Illimitato per le ragioni su espresse. Unico perché altrimenti sarebbe una parte e perciò finito.
Queste parole vengono solitamente adoperate per designare l’Infinito. Ma perché esse hanno una così grande importanza per il pensare filosofico, tanto da costituire il fondamento stesso di tale pensare?
Se le si esamina con un minimo di riflessione si comprende come esse in realtà siano di per sé indefinibili, poiché ognuna di esse è priva di contenuto empirico, in quanto non si può fare esperienza con i sensi né dell’eterno perché si nasce e si muore, né dell’indeterminato poiché si è piccola parte, né dell’illimitato perché si è minuscola estensione corporale, né dell’Unico assoluto perché si fa parte della molteplicità. L’Infinito sfugge quindi ad ogni designazione linguistica o ad ogni esperienza sensibile e perciò è di per sé inconoscibile.
Si pone allora una domanda. Perché esso è il fondamento di tutti gli esseri viventi (gli enti) se per l’appunto non lo si può conoscere? A tale domanda cruciale si può rispondere solo con una serie di domande correlate. Ossia, se a noi esseri umani mancasse il concetto, o il sentimento, o, meglio ancora, l’intuizione intellettuale dell’Infinito, si potrebbe pensare? Infatti come potremmo cogliere con il nostro pensiero il senso della successione temporale o di quella spaziale o della numerica? Quando si parla di tempo non si dice che esso non finisce mai? E quando si parla di spazi non si dice che esistono spazi irraggiungibili? O, infine, che cos’è la matematica se non lo studio del numerico che non finisce mai, poiché si può sempre aggiungere ad una qualsiasi cifra un “più uno”? Fra l’altro, se ci mancasse il senso della temporalità sarebbe impossibile pensare? In particolare l’opera “Essere e tempo” di Heidegger (e tante altre dello stesso autore), ma anche dello stesso Kant nella “Critica della ragione pura” (in primis nello “Schematismo trascendentale”) dimostrano che le nostre capacità di progettazione, di associazione, di relazione logica, di memoria sono possibili solo perché siamo “caduti nel tempo”. Tuttavia questi concetti (il numero) ed intuizioni (spazio e tempo) possono darci l’idea dell’Infinito, ma non sono l’Infinito. Infatti essi contengono o una determinazione (il numero esprime quantità) o un legame all’esperienza ( lo spazio è il senso esterno che coglie le distanze, mentre il tempo è il senso interno che coglie la successione del prima e del poi). Come tali perciò appartengono al mondo finito, in quanto limitati, che però contengono la nostra predisposizione a concepire l’Infinito. Ciò risulta chiarissimo a partire dalla generazione dei numeri. Ad ogni modo è sbagliato parlare di infinito matematico,poiché la matematica si restringe ad un ambito specifico e limitato, che è quello della quantità. Semmai si può parlare di un indefinito matematico, che è soltanto una estensione o sviluppo che procedendo dal finito vorrebbe raggiungere l’infinito, ma che, proprio perché parte dal finito è, di conseguenza, riducibile ad esso (6). Tempo, spazio e numero sono quindi propensioni concettuali o intuitive che spingono a concepire l’Infinito senza però coglierlo mai.
Si è quindi chiarito un aspetto teorico importantissimo: che il pensiero trova il suo fondamento nell’Infinito.
La filosofia, nel suo scaturire, si palesa subito grande: Anassimandro è il primo vero filosofo che si svincola dall’influenza di un pensare legato alla physis (alla natura) ed è quindi il fondatore della metafisica. L’Infinito che egli intuisce per primo è un Infinito assolutamente incondizionato ed indeterminato, poiché come affermava Guènon,
“…ogni determinazione, qualunque sia, è necessariamente una limitazione, proprio in quanto lascia qualcosa all’esterno di sé, vale a dire tutte le altre determinazioni ugualmente possibili” (7).
Spazio, tempo e numero sono divisibili, e ciò che è divisibile è necessariamente limitato, tuttavia essi ci fanno capire che senza l’intuizione dell’Infinito non sarebbero possibili e quindi non si potrebbe pensare.
Ma perché l’Infinito è soprattutto una intuizione di tipo intellettuale, dal momento che solo con il pensiero l’uomo rivolgersi ad Esso? E che cosa significa intuizione intellettuale?
Ebbene qui non si tratta di fare una semplice disquisizione terminologica, ma di mostrare l’essenzialità di tale concetto. La parola intuizione deriva dal latino intuere che significa principalmente vedere. Tuttavia quando si parla dell’Infinito non si può certo vederlo coi sensi, semmai di “vagheggiarlo” solo con la mente. Per Platone ed anche per Aristotele l’intuizione intellettuale era ritenuta una facoltà che acconsentiva all’uomo di cogliere la verità assoluta dell’eterno, e di ottenere perciò una perfetta “adaequatio rei et intellectus”, ovvero una conoscenza perfetta del mondo sia fisico che trascendente.
In realtà, in Anassimandro, non si può dire, nonostante la brevità del suo detto che non permette un chiarimento esaustivo, che sia così. L’intuizione intellettuale acconsente di comprendere che l’Infinito c’è, ma non di comprendere che cosa esso sia: si può presupporre che ci sia già qui l’anticipazione teorica della teologia negativa, che ammette l’esistenza di Dio (anzi la dà per scontata), senza però sapere nulla di Esso, poiché l’Infinito (che è Dio) non è conoscibile. Dio c’è, l’Infinitoc’è, ma non perché siamo in grado di dimostrarlo attraverso ragionamenti discorsivi, come per esempio la famosa prova di Sant’Anselmo o le prove di S.Tommaso, ma c’è perché lo comprendiamo, come s’è scritto precedentemente, con prove indirette, che non sono definibili, ma che sono vere, poiché l’esistenza nella nostra mente del senso dello spazio e del tempo (da cui discende, come abbiamo visto, la matematica) ne sono la testimonianza appunto indiretta, e pur tuttavia indubitabile.
L’Infinito, diceva Anassimandro, è l’origine di tutti gli esseri. Questo fatto costituisce da sempre il più difficile problema filosofico. Infatti, che cosa si intende per origine?
La parola sta a significare nascita, quindi l’Infinito è il fondamento non fondato (il fondamento primo) da cui gli esseri viventi, gli enti, sorgono. Quando sorgono? Nell’Infinito gli enti sono da sempre, perché un Infinito senza enti sarebbe un Ni-ente assoluto che non potrebbe in quanto tale produrre niente, in quanto non esiste una volontà di produrre senza avere in sé il voluto, ovvero gli enti stessi. Da ciò si deduce che il finito è esso stesso perpetuo. Ma è evidente che il finito è ontologicamente differente dall’Infinito vero, poiché esso è soggetto al tempo e quindi gli enti che lo costituiscono nascono e muoiono: l’eternità del finito non è la vera eternità, ma perpetuità o perennità, che sono concetti temporali. Il tempo, si diceva, è un indefinibile, ma è pur sempre finito.
L’Infinito è quindi il contenitore entro cui nascono da sempre (temporalmente) gli enti.
Ma come e perché nascono gli enti secondo Anassimandro? Per rispondere riportiamo una testimonianza fondamentale, che ancora una volta ci proviene da Simplicio:
“Anassimandro… ha detto… che principio ed elemento degli esseri è l’infinito, avendo per primo introdotto questo nome del principio. E dice che il principio non è né l’acqua nè un altro dei cosiddetti elementi, ma un’altra natura infinita, dalla quale tutti i cieli provengono e in mondi che in esso esistono… E’ chiaro che, avendo osservato il reciproco mutamento dei quattro elementi, ritenne giusto di non porne nessuno come sostrato, ma qualcos’altro oltre questi. Secondo lui, quindi, la nascita delle cose avviene non a seguito ad alterazione dell’elemento, ma per distacco dei contrari (dall’infinito) a causa dell’eterno movimento” (8).
Questo frammento ribadisce che il fondamento o principio del tutto (e quindi l’origine) è l’Infinito. Ma perché nel suo infinito “interno” l’Infinito si finitezza e produce il finito? E come?
Si è detto che l’idea di infinito implica anche l’idea di assolutezza, il che significa che l’Infinito è anche incondizionato ed illimitato e che comprende tutto, e che deve comprendere tutto altrimenti sarebbe finito. Proprio per questo nell’Infinito tutto è possibile senza limitazioni. L’Infinito è allora Possibilità totale ed universale, ed è impossibile che Esso non sia, poiché nulla è fuori dalle sue possibilità, perché sarebbe altrimenti limitato. L’impossibile non è possibile , perché altrimenti ci sarebbe il nulla assoluto.
Occorre però essere distinguere, come insegna Guènon, la “possibilità” dalla “potenzialità”. La possibilità, considerata come Possibilità totale e perciò divina, esclude in sé ogni condizionamento limitante ed è quindi immutabile ed eterna. Mentre la potenzialità implica necessariamente, come affermava Aristotele, un legame inscindibile con l’attualizzazione, e dunque essa può riferirsi solo a ciò che si sviluppa e diviene. In sintesi, la Possibilità totale è propria dell’Infinito, mentre la potenzialità è propria del finito.
Cusano fu molto chiaro a tal riguardo quando chiamò Dio col nome di “possest”, cioè Essere-potere perché è realmente ciò che può essere e non può diventare nulla che già non sia nell’eternità, per cui in Lui potenza ed atto coincidono, così come la possibilità con la realtà. Nel mondo finito invece potenza ed atto, possibilità e realtà sono disgiunte proprio perché soggette al divenire.
L’àpeiron è quindi apertura illimitata e senza condizioni, poiché altrimenti non sarebbe tale. Il finito è proprio per questo, da sempre, nell’Infinito. Per cui il tempo non è altro che una determinazione indefinita di questa possibilità totale. Il senza-tempo implica in sè il tempo, poiché se non ci fossero gli enti esso sarebbe, come abbiamo detto, vuoto assoluto. Il vuoto assoluto escluderebbe ogni determinazione e perciò esso non in quanto non-manifestazione assoluta non potrebbe manifestarsi. Ma poiché è impossibile che il finito non sia, va da sé che il tempo, come è scritto nel detto anassimandreo, diventa il governatore degli enti, di enti che nascono e muoiono all’interno dell’Infinito, e che quindi va a regolare tutto quello che è manifesto.
L’Infinito, proprio perché è Possibilità totale, viene allora a coincidere con la Volontà assoluta.
Nell’unità dell’Infinito, attraverso la volontà o desiderio puro proprio di Dio, scaturisce il finito, che non viene prodotto a causa di un semplice strappo o di una rottura caotica: la Volontà contiene nel suo agire sempre una motivazione razionale. Aristotele aveva compreso perfettamente questo, quando nel “De anima” scriveva che “… ciò che nel desiderio è desiderato muove, e l’intelletto, il rappresentare, muove soltanto perché si rappresenta ciò che nel desiderio è desiderato…”.
La volontà senza Lògos è caos, è la realtà di un migma, di un indistinto, che il Colli definiva come un concetto mistico, “ di un qualcosa che è al tempo stesso unità e molteplicità” e che è appunto appetito irrazionale, cieco e senza scopo. Ma la volontà agisce anche razionalmente, e questa razionalità trova la sua manifestazione concreta nella lotta fra i contrari.
Secondo la lezione heideggeriana il Kàos è un abisso spalancato, il disordine informe, mentre il Kòsmos è il mettere ordine al caos tramite un Lògos.
Nel caos vi è l’assoluta obbligatorietà di un disvelamento razionale, altrimenti il tutto rimarrebbe informe e indistinto, e gli enti non potrebbero distinguersi e perciò resterebbero ad aeternum pura potenzialità, senza mai diventare atto, ma così l’Infinito, che è Possibilità universale, sarebbe limitato nell’esprimere le sue possibilità, che sono, va da sé, infinite. E’ impossibile, si diceva,che l’Infinito sia impossibilitato ad esprimere tutte le sue possibilità.
Ed è per questo che dal caos nasce il cosmos: l’indistinto si finitezza in individualità limitate e precisamente connotate. Hegel dirà, a tal proposito, che “… un calza lacerata è preferibile ad una rattoppata…”. Il rattoppo va bene per l’uso pratico, ma non per la ragione. Egli esprimeva così il concetto di Trennung, di lacerazione o scissione appunto, col il quale indicava che per la ragione (il Lògos) la divisione fra i contrari costituisce il cosmos stesso. La filosofia è la figlia, dirà ancora Hegel, proprio della scissione. E più aumentano di intensità le lacerazioni, più si afferma il “principium indivituationis”, in base al quale ogni ente assume caratteristiche proprie ed irriducibili ad un altro ente. L’uguaglianza fra gli enti è impossibile, non solo perché limiterebbe la Possibilità totale, ma anche perché lo spazio che un ente occupa e il tempo che esso vive sono unici, in quanto nessun ente può sostituire perfettamente un altro ente. Ciò significa anche che lo spazio-tempo, come affermavano gli Scolastici, Leibniz e Schopenhauer, costituisce il principio di individuazione, e perciò la distinzione fra gli enti.
Tale principio implica inoltre la lotta fra gli enti, che è dovuta al fatto che ogni ente, e in particolare l’uomo, pur nella sua distinzione, possiede nel suo fondamento sia il principio razionale che irrazionale della volontà, per cui lo scontro fra individualità distinte (Hobbes, il secondo Schelling, Schopenhauer e Nietzsche compresero tale verità) diventa inevitabile. Ma lo scontro non porta di per sé necessariamente al caos. Infatti la lotta avviene fra contrari. La contrarietà è una relazione conflittuale fra due o più enti che però, come concepirà poi Eraclito, appartengono alla stessa specie: ad es. bianco e nero appartengono alla specie colore, mentre fra albero e cane non c’è appartenenza di specie, e quindi sono diversi o distinti.
Anassimandro ci rivelò quest’altra potente intuizione: gli enti sono in lotta perenne quando essi sono contrari fra loro. E questa è la legge che regola la loro vita, e in base alla quale essi hanno anche “ …la distruzione secondo necessità” .
La distruzione è necessaria (una necessità-necessitata) perché si tratta di enti finiti, che come tali nascono e perciò muoiono. Ma per Anassimandro la distruzione avviene proprio perché fra gli enti non può non esserci conflitto. Un conflitto che è legge cosmica, poiché gli enti devono necessariamente perire, e che quindi costituisce l’ ordine fra gli enti stessi. Tuttavia il filosofo sentì dentro di sé un profondo dolore per il destino degli enti. Infatti egli aggiunse che essi devono pagare “… l’uno all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”.
Severino, nel commentare questa lotta fra i contrari, ha cercato di spiegarne il senso:
“Non c’è più alcun dubbio, oggi, che, quando Anassimandro afferma che gli enti si pagano reciprocamente la pena e l’espiazione dell’ingiustizia, egli si riferisca ai contrari che vicendevolmente si cacciano dalla scena del mondo tendendo ad occuparla tutta per sé; e che l’ingiustizia è appunto questa prevaricazione, che viene punita dal tempo, sacerdote della giustizia, il quale consente agli esclusi di entrare in scena cacciando il prevaricatore e diventando essi stessi, a loro volta prevaricatori; e che il tempo, che amministra la giustizia del mondo, l’amministra anche riportando il mondo nella sfera donde era uscito” (9).
Lo stesso Severino chiarì poi nello stesso saggio che secondo il suo parere i termini giustizia (dìke) e ingiustizia (àdikìa) non hanno nessun senso giuridico o sociale, bensì una valenza puramente speculativa e metafisica.
C’è però da dubitare assai sulla giustezza di questo parere.
Nell’epoca in cui scrisse Anassimandro l’equilibrio fra ceti dominanti e ceti dominati si andava sempre più acuendo soprattutto nelle città mercantili, in quanto i ricchi diventavano sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri, per cui l’equilibrio armonico precedente (l’isorropia) presente in società fortemente comunitarie (non comuniste) si incrinava sempre più. Non è un caso che proprio nello stesso periodo storico (2500 anni fa ca.) si diffusero concetti filosofici pressoché omeomorfi, cioè quasi equivalenti nel significato, quali il Tao in Cina, il Dharma in India e il Lògos in Grecia. Nessun pensiero, per quanto astratto, può esprimersi al di fuori della vita reale degli uomini.
E’ probabile cheAnassimandro non accettasse la tragicità dell’esistenza degli enti anche che l’osservazione della vita sociale che viveva. Non è per caso che per la prima volta il linguaggio filosofico si palesa con termini quali verità, giustizia (dìke) e ingiustizia (àdikìa). Sebbene tale veduta possa essere configurata come una specie di pessimismo cosmico, si deve comunque, come si è appena detto, calare la sua elaborazione nel mondo sociale di appartenenza.
Il successore di Anassimandro, Eraclito, condividerà la veduta dei contrari, e per quanto potesse avere un’opinione differente sul destino degli enti, poiché egli accettava il “gioco” del destino, tuttavia non esaltava l’hybris (tracotanza o sfrenatezza o dismisura). Anzi egli poneva l’esigenza di spegnere la dismisura (Bisogna spegnere la dismisura più di un incendio) (fr.43) e porre un freno (un katekòn) all’eccessiva ricchezza (Che la ricchezza non vi abbandoni, o Efesii, affinchè possiate dimostrare tutto il male che c’è nel vostro modo di agire) (fr.125a).
La filosofia, come figlia della scissione che tende all’eccesso, rivela ad Anassimandro il sentimento di una sofferenza sociale.
C’è da aggiungere, comunque, che nella concezione metafisica di Anassimandro non v’è in nessun modo il senso del “peccato originale”. Infatti la contesa e la morte non sono una colpa (tutti i Greci antichi non avvertivano certo il senso del peccato d’esistere), bensì il rimpianto di una unità originaria che la dismisura del “principium individuationis” aveva lacerato. E’ il rimpianto, forse, di quell’epoca che Empedocle chiamerà Sfero, in cui regnava l’amore e dove vi era quindi una unità del macrocosmo naturale e del microcosmo sociale. Era quell’epoca in cui si viveva in una dimensione magico-animistica, che corrisponde in Hegel allo stadio della Coscienza (si veda “La fenomenologia dello spirito”) e in Rousseau al mondo sociale umano dopo la scoperta del fuoco e prima della nascita dello stato. Un’epoca che il pensiero tradizionale identifica con l’età dell’oro.
Più di due secoli dopo Anassimandro, Platone proporrà la sua più potente visione filosofica nella “Repubblica”, che è un modello eterno di giustizia e verità in cui il Bene e il Vero coincidono: coincidenza che i Greci chiamarono misura, equità, comunità, ed anche bello.
Il nostro mondo attuale è invece l’antiplatonismo realizzato, in quanto è l’esatto opposto di questi valori. Oltre però non si può andare.
Flores Tovo
f.tovo@libero.it
==========
NOTE
- M.HEIDEGGER, Il detto di Anassimandro, sta in “Pensieri interrotti”, ed. La Nuova Italia, Firenze 1984
- E.SEVERINO, La parola di Anassimandro, sta in “L’essenza del nichilismo”, ed. Adelphi, Milano 1972.
- DIELS-KRANZ, I presocratici: testimonianze e frammenti, traduzione italiana di R. Laurenti, ed. Laterza, Bari 1968.
- G.COLLI, Aristotele e le origini della filosofia, pp.95-135, sta in “La natura ama nascondersi”, ed. Adelphi, Milano 1988.
- W.JAEGER, Paideia, ed. La Nuova Italia, Firenze,1972.
- Illuminanti a tal proposito sono le pagine del filosofo francese R.GUENON,Gli stati molteplici dell’essere, ed. Adelphi, Milano 1996, pp.19-28.
- IDEM, pp.21-22.
- DIELS-KRANZ,op.cit., DK12 A 9.
- E.SEVERINO, op.cit., p.399.
BIBLIOGRAFIA
Testi consultati ed usati:
G.COLLI, La natura ama nascondersi, ed. Adelphi, Milano 1988.
G.COLLI, La sapienza greca, Vol. I, ed. Adelphi, Milano 1990.
DIELS-KRANZ, I presocratici. Testimonianze e frammenti, traduzione italiana di R. Laurenti, ed. Laterza, Bari 1968.
R.GUENON, Gli stati molteplici dell’essere, ed. Adelphi, Milano 1996.
W.JAEGER, Paideia, ed. La Nuova Italia, Firenze 1972.
K.JASPERS, Anassimandro, Cusano, stanno in “I grandi filosofi”, ed. Longanesi, Milano 1973.
M.HEIDEGGER, Il detto di Anassimandro, sta in “Sentieri interrotti”, ed. La Nuova Italia, Firenze 1984.
S.MASO (a cura di), I presofisti e l’orizzonte della filosofia, ed. Paravia, Torino 1993.
F.NIETZSCHE, La filosofia nell’età tragica dei Greci, ed. Adelphi, Milano 1991.
G. REALE, Storia della filosofia antica, Vol.I, Pubbl. Università Cattolica, Milano 1989.
L.ROBIN, Storia del pensiero greco, ed. A. Mondatori, Milano 1962.
F.SCHELLING, Sull’essenza della libertà, ed. Rusconi, Milano 1996.
E.SEVERINO, La parola di Anassimandro, sta in “Essenza del nichilismo”, ed. Adelphi, Milano 1982.
W.WEISCHEDEL, La filosofia dalla porta di servizio, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996.
=======